
Son tanto brava lungo il giorno di Sibilla Aleramo
15 Giugno 2025
Come uscire dalla crisi di J.M. Keynes
15 Giugno 2025Traccia e svolgimento di una Analisi del testo letterario Il Versificatore dalle Storie naturali di Primo Levi
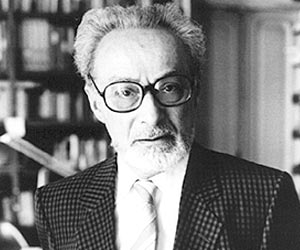
TRACCIA
SESSIONE STRAORDINARIA 2024 – PRIMA PROVA SCRITTA Ministero dell’Istruzione e del Merito ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE
PROVA DI ITALIANO
TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO
TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO
PROPOSTA A2
Testo tratto da: Primo Levi, Il Versificatore, in Storie naturali, in Tutti i racconti, Einaudi, Torino, 2015, pp. 18-37.
TESTO
SEGRETARIA (sottovoce, di malavoglia) Vuole comprare quella macchina?
POETA (sottovoce, più calmo) Non metta su codesto broncio, signorina, e non si cacci in capo idee sbagliate. (Suadente) Non si può restare indietro, lei lo capisce benissimo. Bisogna tenere il passo coi tempi. Dispiace anche a me, glielo assicuro, ma a un certo punto bisogna pure decidersi. Del resto, non abbia preoccupazioni: il lavoro per lei non mancherà mai. Ricorda, tre anni fa, quando abbiamo comperato la fatturatrice? […]
Ebbene: come si trova oggi? Ne potrebbe fare a meno? No, non è vero? È uno strumento di lavoro come un altro, come il telefono, come il ciclostile. Il fattore umano è e sarà sempre indispensabile, nel nostro lavoro; ma abbiamo dei concorrenti, e perciò dobbiamo pure affidare alle macchine i compiti più ingrati, più faticosi. I compiti meccanici, appunto… […]
SEGRETARIA (esitante; via via più commossa) Maestro… io … io lavoro con lei da quindici anni… ecco, mi perdoni, ma … al suo posto non farei mai una cosa simile. Non lo dico mica per me, sa: ma un poeta, un artista come lei… come può rassegnarsi a mettersi in casa una macchina… moderna finché vuole, ma sarà sempre una macchina… come potrà avere il suo gusto, la sua sensibilità… Stavamo così bene, noi due, lei a dettare e io a scrivere… e non solo a scrivere, a scrivere sono capaci tutti: ma a curare i suoi lavori come se fossero i miei, a metterli in pulito, a ritoccare la punteggiatura, qualche concordanza, (confidenziale) anche qualche errorino di sintassi, sa? Può capitare a tutti di distrarsi…
POETA Ah, non creda che io non la capisca. Anche da parte mia è una scelta dolorosa, piena di dubbi. Esiste una gioia, nel nostro lavoro, una felicità profonda, diversa da tutte le altre, la felicità del creare, del trarre dal nulla, del vedersi nascere davanti, a poco a poco, o d’un tratto, come per incanto, qualcosa di nuovo, qualcosa di vivo che non c’era prima… (Freddo ad un tratto) Prenda nota, signorina: «come per incanto, qualcosa di nuovo, qualcosa di vivo che non c’era prima, puntini»: è tutta roba che può servire.
SEGRETARIA (molto commossa) È già fatto, maestro. Lo faccio sempre, anche quando lei non me lo dice. (Piangendo) Lo conosco, il mio mestiere. Vedremo se quell’altro, quel coso, saprà fare altrettanto! […]
SIMPSON (alacre e gioviale; leggero accento inglese) Eccomi: a tempo di primato, no? Qui c’è il preventivo, qui c’è l’opuscolo pubblicitario, e qui le istruzioni per l’uso e la manutenzione. […] (Pausa: ronzio crescente del Versificatore che si sta riscaldando). … Ecco, si sta riscaldando. Fra pochi minuti, quando si accende la lampadina spia, si potrà cominciare. Intanto, se permette, le direi qualcosa sul funzionamento. Prima di tutto, sia ben chiaro: questo non è un poeta. Se lei cerca un poeta meccanico vero e proprio, dovrà aspettare ancora qualche mese: è in fase di avanzata progettazione presso la nostra casa madre, a Fort Kiddiwanee, Oklahoma. Si chiamerà The Troubadour, «Il trovatore»: una macchina fantastica, un poeta meccanico heavy-duty, capace di comporre in tutte le lingue europee vive o morte, capace di poetare ininterrottamente per mille cartelle, da –100° a +200° centigradi, in qualunque clima, e perfino sott’acqua e nel vuoto spinto. (Sottovoce) È previsto il suo impiego nel progetto Apollo: sarà il primo a cantare le solitudini lunari […].
POETA (legge borbottando l’opuscolo) Voltaggio e frequenza… sì, siamo a posto. Impostazione argomento… dispositivo di blocco… è tutto chiaro. Lubrificazione… sostituzione del nastro… lunga inattività… tutte cose che potremo vedere dopo. Registri… ah ecco, questo è interessante, è l’essenziale. Vede, signorina? sono quaranta: qui c’è la chiave delle sigle. EP, EL (elegiaco, immagino: sì, elegiaco, infatti), SAT, MYT, JOC (cos’è questo JOC? ah sí, jocular, giocoso), DID…
SEGRETARIA DID?
POETA Didascalico: molto importante. PORN… (La segretaria sobbalza). «Messa in opera»: non sembra, ma è di una semplicità estrema. Lo saprebbe usare un bambino. (Sempre più entusiasta) Guardi: basta impostare qui l’«istruzione»: sono quattro righe. La prima per l’argomento, la seconda per i registri, la terza per la forma metrica, la quarta (che è facoltativa) per la determinazione temporale. Il resto lo fa tutto lui: è meraviglioso!
Primo Levi, Il Versificatore, in Storie naturali, in Tutti i racconti, Einaudi, Torino, 2015, pp. 18-37.
COMPRENSIONE E ANALISI
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte a tutte le domande proposte.
- Sintetizza il contenuto del brano.
- Come sono caratterizzati i tre personaggi?
- Come viene rappresentato il Versificatore? Ti sembra diverso o simile a un moderno dispositivo tecnologico?
- Le ultime frasi del Poeta sono significative: per quale motivo?
INTERPRETAZIONE
Proponi una tua interpretazione complessiva del brano e rifletti sulle tematiche che propone, approfondendole con opportuni collegamenti mediante tue letture e conoscenze personali e operando una riflessione sulla produzione della poesia e dell’arte affidata a strumenti automatici.
Sessione straordinaria 2024 Prima prova scritta Ministero dell’istruzione e del merito
ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PROVA DI ITALIANO

SVOLGIMENTO
Analisi di ‘Il Versificatore’ di Primo Levi
Il brano tratto da “Il Versificatore”, una delle Storie naturali di Primo Levi, è un dialogo satirico e profondamente riflessivo sul tema del progresso tecnologico e del suo impatto sull’attività creativa, in particolare sulla poesia. Attraverso una scena paradossale in cui un “Poeta” si appresta ad acquistare una macchina per comporre versi, Levi esplora con lucidità e ironia il rapporto tra l’ingegno umano e la meccanizzazione, sollevando interrogativi sulla natura dell’arte e della creatività.
Comprensione e Analisi
1. Sintetizza il contenuto del brano.
Il brano presenta un dialogo tra un Poeta e la sua Segretaria, cui si unisce poi un venditore, Simpson. Il Poeta è intenzionato ad acquistare una macchina per scrivere versi, il “Versificatore”, nonostante le perplessità e la commozione della sua fedele Segretaria, che si sente sostituita e dubita della capacità della macchina di replicare la sensibilità umana. Il Poeta, pur riconoscendo la “felicità del creare” manuale, giustifica la scelta con la necessità di “tenere il passo coi tempi” e affidare i “compiti meccanici” alle macchine, citando l’esempio della fatturatrice. Arriva Simpson, il venditore, che introduce la macchina, sottolineando che non è un “poeta meccanico vero e proprio” ma un modello intermedio, anticipando però l’arrivo di un futuro, rivoluzionario “The Troubadour” capace di comporre in tutte le lingue e in condizioni estreme, anche nello spazio. Il Poeta, entusiasta, si interessa ai “registri” della macchina (elegiaco, satirico, giocoso, didascalico, pornografico) e alla sua estrema semplicità d’uso, che permette di impostare argomento, registri, forma metrica e tempo con poche righe di istruzioni.
2. Come sono caratterizzati i tre personaggi?
I tre personaggi sono caratterizzati in modo distinto, rappresentando diverse posizioni di fronte al progresso tecnologico:
-
Il Poeta: Inizialmente appare suadente e pragmatico, quasi cinico. Giustifica l’acquisto del Versificatore con la necessità di “tenere il passo coi tempi” e di affidare alle macchine i “compiti meccanici”. Tuttavia, rivela una contraddizione: parla della “gioia”, della “felicità profonda del creare” dal nulla, per poi interrompersi bruscamente e annotare freddamente le sue stesse parole come “roba che può servire”. Questo mostra una dissociazione tra la sua sensibilità artistica (riconosciuta ma messa da parte) e la sua adesione alla logica industriale e del profitto. Alla fine, si mostra entusiasta e quasi infantile di fronte alla semplicità e alle potenzialità della macchina, dimenticando i dubbi iniziali e la commozione della segretaria. È un uomo che, pur venendo dal mondo dell’arte, è sedotto dalla modernità e dall’efficienza.
-
La Segretaria: È il personaggio che incarna la dimensione umana, l’affetto, la dedizione e la preoccupazione per la perdita della manualità e della sensibilità nel lavoro. Lavora con il Poeta da quindici anni, è commossa e titubante di fronte all’idea della macchina. Sottolinea la sua capacità di “curare i suoi lavori come se fossero i miei”, di “ritoccare la punteggiatura, qualche concordanza, anche qualche errorino di sintassi”, dimostrando una competenza che va oltre la mera trascrizione e una profonda identificazione con l’opera del Poeta. Le sue lacrime rivelano la sua frustrazione e il suo timore di essere sostituita da un “coso” senza anima. Rappresenta la figura dell’artigiano che vede minacciato il valore del proprio mestiere e la propria dignità umana dal progresso.
-
Simpson: È il tipico venditore moderno, entusiasta, dinamico, persuasivo e leggermente superficiale. Parla con “leggero accento inglese” (simbolo forse di modernità e globalizzazione), ed è “alacre e gioviale”. Si concentra sui dati tecnici, sull’efficienza e sulle potenzialità futuribili della macchina (“The Troubadour” capace di poetare a temperature estreme e nello spazio). La sua presentazione è un inno alla tecnologia e alla sua capacità di superare i limiti umani, senza però comprenderne le implicazioni filosofiche o etiche. Non si preoccupa del significato profondo della poesia, ma solo della performance e della versatilità meccanica del prodotto.
3. Come viene rappresentato il Versificatore? Ti sembra diverso o simile a un moderno dispositivo tecnologico?
Il Versificatore viene rappresentato come una macchina capace di produrre testi poetici, ma con caratteristiche che ne sottolineano la natura meccanica e, al contempo, anticipano la potenza dei moderni dispositivi tecnologici:
- Funzionalità meccanica e oggettiva: Inizialmente, il Poeta lo descrive come uno strumento per compiti “ingrati”, “faticosi”, “meccanici”, simile a una fatturatrice, un telefono o un ciclostile.
- Capacità di “creare” su comando: È in grado di comporre versi basandosi su impostazioni precise: “argomento”, “registri” (elegiaco, satirico, giocoso, didascalico, pornografico), “forma metrica” e “determinazione temporale”. Questa modularità e la capacità di generare output specifici su input determinati sono molto simili ai moderni algoritmi di generazione di testo.
- Facilità d’uso e automazione: “È di una semplicità estrema. Lo saprebbe usare un bambino.” Questo enfatizza l’idea che la creazione artistica, grazie alla macchina, diventa un processo semplificato, quasi automatico, privo di sforzo intellettuale o emotivo.
- Potenzialità futuristiche (The Troubadour): Simpson introduce un modello futuro, “The Troubadour”, descritto come un “poeta meccanico heavy-duty” capace di comporre in “tutte le lingue europee vive o morte”, “ininterrottamente per mille cartelle”, “in qualunque clima, e perfino sott’acqua e nel vuoto spinto”. È previsto per il “progetto Apollo”. Questa descrizione esalta la capacità di superare i limiti umani di resistenza e versatilità, proiettando la macchina in contesti fantascientifici.
Il Versificatore è molto simile a un moderno dispositivo tecnologico, in particolare a un generatore di testo basato su Intelligenza Artificiale (IA), per i seguenti motivi:
- Generazione di contenuti su parametri: I moderni modelli di IA (come quelli di linguaggio, ad es. GPT) possono generare testi (anche poetici) su input specifici (tema, stile, tono), proprio come il Versificatore con i suoi registri.
- Automazione e efficienza: L’IA mira ad automatizzare compiti complessi, rendendoli veloci ed efficienti, esattamente come il Poeta desidera che la macchina faccia con i “compiti meccanici” della versificazione.
- Assenza di intelligenza “vera”: Simpson afferma chiaramente “questo non è un poeta. Se lei cerca un poeta meccanico vero e proprio, dovrà aspettare ancora qualche mese”. Questa distinzione anticipa la riflessione di Floridi sull’IA come “ossimoro” (“ciò che è veramente intelligente non è mai artificiale e ciò che è artificiale non è mai intelligente”, v. B3 Sessione straordinaria 2023). La macchina ha agency (agisce con successo), ma non coscienza o comprensione autentica.
- Promesse di superamento umano: Le capacità futuristiche di The Troubadour (multilinguismo, produzione illimitata, operatività in ambienti estremi) rispecchiano le ambizioni e le promesse delle IA contemporanee di superare le capacità umane in vari domini.
4. Le ultime frasi del Poeta sono significative: per quale motivo?
Le ultime frasi del Poeta (“Vede, signorina? sono quaranta: qui c’è la chiave delle sigle. EP, EL (elegiaco, immagino: sì, elegiaco, infatti), SAT, MYT, JOC (cos’è questo JOC? ah sí, jocular, giocoso), DID… SEGRETARIA DID? POETA Didascalico: molto importante. PORN… (La segretaria sobbalza). «Messa in opera»: non sembra, ma è di una semplicità estrema. Lo saprebbe usare un bambino. (Sempre piú entusiasta) Guardi: basta impostare qui l’«istruzione»: sono quattro righe. La prima per l’argomento, la seconda per i registri, la terza per la forma metrica, la quarta (che è facoltativa) per la determinazione temporale. Il resto lo fa tutto lui: è meraviglioso!”) sono significative per diversi motivi:
- Entusiasmo e fascinazione per la macchina: Il Poeta si rivela completamente rapito e quasi infantilmente entusiasta della macchina. Il suo stupore (“è meraviglioso!”) contrasta con la sua precedente dichiarazione sulla “felicità del creare” umano e mostra come sia facilmente sedotto dalla semplicità e dall’efficienza tecnologica.
- Riduzione dell’arte a mera meccanica: L’elenco dei “registri” (elegiaco, satirico, giocoso, didascalico, pornografico) riduce la complessità e la profondità dell’espressione poetica a una serie di categorie predefinite, quasi come format o preset. La poesia diventa un prodotto componibile con istruzioni chiare, perdendo la sua dimensione di intuizione, emozione e unicità.
- Deumanizzazione del processo creativo: L’affermazione “Lo saprebbe usare un bambino” sottolinea che la creazione poetica non richiede più talento, esperienza, o ispirazione (come intesa da Szymborska nel suo “non so”, v. B3 Sessione straordinaria 2023), ma solo la capacità di seguire istruzioni basilari. Ciò deprime il valore dell’artista e la dignità del suo lavoro.
- Trionfo della superficialità e della serialità: Il Poeta è estasiato dalla capacità della macchina di produrre versi in serie, senza fatica. Questo anticipa la visione pirandelliana (da Quaderni di Serafino Gubbio operatore, v. A2 Sessione ordinaria 2024) di una vita “meccanizzata” che produce “pezetti e bocconcini, tutti d’uno stampo, stupidi e precisi”, e le riflessioni di Galimberti sul “terrore dell’anonimato” e la produzione di massa (v. C2 Sessione ordinaria 2024). L’arte rischia di diventare una produzione di massa, priva di autenticità e significato profondo.
- Accettazione della mercificazione dell’arte: Il fatto che il Poeta si concentri sui “registri” e sulla “semplicità” d’uso per produrre su scala, rivela la sua accettazione, o addirittura la sua promozione, di un’arte che diventa un prodotto commerciale, standardizzato e replicabile.
Interpretazione
Il brano “Il Versificatore” di Primo Levi è un racconto di straordinaria attualità, una parabola satirica che, pur scritto in un’epoca in cui le tecnologie attuali erano fantascienza, anticipa con lucidità e amara ironia le sfide poste dallo sviluppo automatico dell’arte e della creatività. Levi, con la sua inconfondibile vena di scienziato-scrittore, ci invita a riflettere sulla natura della produzione artistica quando essa si scontra con la logica dell’efficienza e della meccanizzazione.
La tematica centrale del brano è la disumanizzazione della creatività e il conflitto tra l’ingegno umano e la macchina. Il Poeta, figura che dovrebbe incarnare l’espressione più alta della sensibilità umana e della creazione dal nulla, si mostra paradossalmente affascinato dalla possibilità di delegare il suo compito a un automa. La sua “felicità del creare” si scontra con la “freddezza” di chi valuta le parole solo come “roba che può servire”. Questo evidenzia una mercificazione dell’arte: la poesia non è più un’espressione intima o una ricerca di senso, ma un prodotto da generare su richiesta, in base a “registri” predefiniti e con la massima facilità. È la vittoria della quantità sulla qualità, dell’efficienza sulla profondità.
Questa visione si lega strettamente alle riflessioni di altri autori sulla disumanizzazione operata dalla tecnologia e dalla società industriale.
- Luigi Pirandello in Quaderni di Serafino Gubbio operatore (v. A2 Sessione Ordinaria 2024) affronta un tema quasi identico: la macchina che da strumento diventa padrona, riducendo l’uomo a un ingranaggio (“una mano che gira una manovella”) e privandolo della sua anima e della sua vita autentica. La descrizione pirandelliana delle “scatole, scatolette” prodotte in serie dalla macchina trova un parallelo perfetto nei “registri” del Versificatore che producono versi “stupidi e precisi”. Entrambi gli autori denunciano il “trionfo della stupidità” che può derivare da un progresso tecnologico incontrollato.
- Charlie Chaplin nel suo film Tempi Moderni (1936) rappresenta in maniera visiva e comica l’alienazione dell’operaio nella catena di montaggio, ridotto a puro gesto meccanico, proprio come la Segretaria di Levi si sente ridotta a mero strumento.
- La filosofia di Heidegger sulla “tecnica” come “destinazione dell’essere” può essere richiamata: la tecnica non è solo un mezzo, ma un modo di disvelamento del mondo che rischia di ridurre ogni cosa, inclusa l’arte, a “disponibilità” (Bestand), a risorsa sfruttabile e computabile. Il Versificatore è l’esempio di come anche la poesia possa essere ridotta a mera “disponibilità tecnica”.
La figura della Segretaria è fondamentale in questa interpretazione. Lei rappresenta l’umanità resistente, la dedizione artigianale, la sensibilità e la cura che la macchina non può replicare. Le sue lacrime sono la reazione emotiva e autentica di fronte alla perdita di un lavoro che è anche identità e passione. La sua domanda “Vedremo se quell’altro, quel coso, saprà fare altrettanto!” è un monito che si estende al lettore, invitandolo a riflettere sulla vera natura dell’arte.
Oggi, il “Versificatore” di Levi non è più fantascienza, ma una realtà quotidiana sotto forma di Intelligenza Artificiale generativa. Modelli come ChatGPT o Bard possono, a comando, comporre testi in stili diversi, scrivere poesie, generare dialoghi. La riflessione di Levi è quindi più pertinente che mai sulla produzione della poesia e dell’arte affidata a strumenti automatici.
Personalmente, credo che l’arte generata da strumenti automatici ponga interrogativi complessi. Se da un lato l’IA può essere uno strumento prezioso per la creatività umana – ad esempio, come assistente per la generazione di idee, per la sperimentazione di stili, o per superare blocchi creativi – dall’altro non può sostituire la dimensione più profonda dell’arte. L’arte umana nasce dall’esperienza vissuta, dall’emozione, dall’intuizione, dal “non so” che alimenta la ricerca di cui parlava Szymborska. Nasce dalla sofferenza, dalla gioia, dalle contraddizioni dell’esistenza (come l’angoscia del lunedì di Levi stesso). Un’IA può elaborare schemi linguistici e stilistici basandosi su enormi quantità di dati esistenti, ma non ha coscienza, non ha un’anima, non ha un vissuto. Può “imitare” lo stile di un poeta, ma non “essere” quel poeta.
La produzione automatica rischia di portare a un’omologazione dell’arte, a un “trionfo della stupidità” (come dice Pirandello) mascherato da efficienza. Se l’arte diventa un prodotto senza l’impronta unica e irripetibile dell’essere umano che l’ha concepita, rischia di perdere la sua forza trasformativa, la sua capacità di emozionare, di far riflettere, di generare domande. L’elogio dell’imperfezione di Rita Levi-Montalcini (v. C1 Sessione ordinaria 2024) ci ricorda che la vera bellezza e la gioia risiedono anche nel processo, nelle difficoltà, negli errori, in ciò che è autenticamente umano e non replicabile.
In conclusione, “Il Versificatore” di Primo Levi non è solo un racconto satirico, ma un monito profetico sulla mercificazione e disumanizzazione dell’arte nell’era della tecnologia. Ci invita a difendere il valore intrinseco della creatività umana, a non lasciarci sedurre acriticamente dalla logica dell’efficienza e della produzione automatica, e a riconoscere che la vera arte nasce sempre da un’anima, per quanto “di pena” o imperfetta, e non da un meccanismo. Il ruolo dell’uomo nell’arte deve rimanere centrale, non come ingranaggio, ma come creatore consapevole e responsabile.

🎤🎧 Audio Lezioni, ascolta il podcast su Primo Levi del prof. Gaudio
Ascolta “Primo Levi” su Spreaker.




