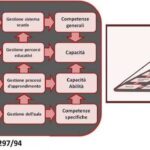
Se la legge è tradita, la scuola soccombe
31 Agosto 2025
L’enigma della morte e la libertà dell’uomo
2 Settembre 2025Dalla riflessione stoica di Marco Aurelio alla visione cristiana di San Tommaso, passando per le voci tormentate di Leopardi, Foscolo e Dostoevskij, questo saggio esplora il mistero della morte, il dramma del suicidio e l’enigma del libero arbitrio.
Un dialogo tra antichi e moderni, tra disperazione e speranza, che interroga l’uomo di fronte all’eternità e alla sua fragilità. Un invito a vivere, nonostante tutto, con coraggio e fede.
Morte, suicidio e libero arbitrio: un viaggio tra filosofia, fede e umanità
saggio di filosofia, riflessione esistenziale e letteratura di Massimo Ricalzone, studioso esperto di filosofia teoretica
Invoco devotamente la benedizione di Nostro Signore Gesù Cristo e di tutti i Santi che hanno vigorosamente intrapreso, in epoche diverse, analisi approfondite di grandi temi quali la morte, il suicidio ed il libero arbitrio (potestas peccandi et non peccandi) affinché ogni mia riflessione, ancorché imperfetta, modestissima e generica ed ogni accenno alle analisi svolte da letterati, filosofi e teologi, possa essere conforme alla divina, immutabile dottrina.
Partendo da una concezione naturale dell’esistenza, si può considerare la morte come semplice cessazione delle funzioni vitali negli organismi viventi e nell’uomo, intesa come decesso e riferibile ad un evento naturale che ha luogo nell’ordine delle cose naturali, quale condizione dell’economia generale della natura vivente.
Dunque nel mondo pagano pre-cristiano l’ateismo, secondo il quale il principio ontologico della realtà è l’Essere, integrale ed univoco, esprime il pensiero fortemente meta-fisico della nascita che significa essere ma anche non essere prima di essere e la morte è da intendersi come non essere, in nessun modo connessa con l’essere, ovvero essere solo fino ad un certo momento.
Marco Aurelio utilizza l’idea della morte quale elemento di uguaglianza di tutti gli uomini ed attuazione storica dello scorrere di tutte le cose verso la dissoluzione, come vanità di una continua ripetizione e tuttavia con un preciso significato: “tutti gli uomini sono uguali di fronte alla morte”.
Alessandro Magno che ebbe un’educazione di alto livello, avendo avuto Aristotele come suo precettore, sul punto di morire, convocò i suoi generali e disse loro le sue ultime volontà:
- che la sua bara fosse trasportata sulle spalle dai medici del tempo;
- che i gioielli, l’oro, i territori conquistati fossero sparsi sulla strada verso la tomba;
- che le sue mani fossero lasciate penzolare fuori dalla bara alla vista di tutti.
Uno dei generali presenti chiese ad Alessandro il motivo di tali insolite ultime volontà ed egli rispose: “Voglio che siano proprio i medici a trasportare la mia bara per dimostrare che essi non hanno potere di guarigione davanti alla morte. Voglio il suolo cosparso dei miei tesori affinché si pensi che i beni materiali ottenuti in questo mondo, restano su questa terra ed inoltre voglio le mie mani al vento per far comprendere che si viene in questo mondo a mani vuote ed a mani vuote andiamo via da esso.”
Ancora Marco Aurelio considera “tutto il tempo presente al pari di un attimo di eternità; tutto è piccolo, mutevole e si dilegua in un baleno. L’Asia e l’Europa, angoli dell’universo, il mare intero, una goccia dell’universo, il monte Athos una zolla dell’universo”. La morte non è mai inquietante per gli stoici bensì è da ritenersi preziosa consigliera che invita all’imperturbabilità.
Nel mondo romano antico, laddove Cicerone e Seneca furono i massimi pensatori e filosofi, assistiamo ad una filosofia derivata dallo stoicismo e, in conformità con lo spirito pratico, politico e giuridico dei Romani, un’etica più che una metafisica. Cicerone non ammette dubDio in merito all’esistenza di Dio e della Provvidenza e, nel racconto della sua morte resoci da Plutarco, egli accetta l’arrivo dei suoi assassini, non tanto di difendersi ma si rassegna alla sua sorte: venne decapitato e, per ordine di Antonio, i sicari gli tagliarono anche le mani con le quali aveva scritto le Filippiche. La vendetta di Antonio fu davvero spietata e volle addirittura che la testa e le mani di Cicerone fossero inchiodate sui rostri del foro romano quale monito per tutti gli oratori e non solo. La località dell’uccisione prese il nome di Vindicius (attuale frazione di Formia) dal latino “Vindicia”, vendetta.
Giovenale, poeta e retore romano, in netta e fiera opposizione alle iniquità, ingiustizie ed immoralità del suo tempo di decadenza morale, idealizza quel passato caratterizzato da una ‘sana moralità’ “agricola” e vede la morte come il risultato dei comportamenti corretti e dei vizi e considera più grande dei crimini preferire la sopravvivenza all’onore e per amore della vita fisica, perdere le ragioni del vivere. Nelle sue satire, Giovenale descrive spietatamente il matrimonio come una forma di suicidio a causa della corruzione morale delle donne. La presenza della morte, nell’opera di Giovenale, spesso tragica e grottesca eppure nella ineluttabilità è liberatoria dalle sofferenze della vita e l’autore apre la sua riflessione alla possibilità del suicidio inteso come via d’uscita e fuga dignitosa dal malcostume e dalla profonda corruzione della società. Particolare curioso, Giovenale era nato ad Aquino, terra d’origine del gigante della scolastica medievale, il più santo dei saggi, il più saggio dei santi, il fondatore della metafisica dell’essere: san Tommaso.
Lo stoicismo di Seneca, mitigato dal Platonismo, presenta un’analisi accurata dei mali dell’anima ed individua la presenza del Dio trascendente nell’anima che persegue le virtù. Tuttavia per Seneca l’uomo deve fare affidamento su se stesso essendo artefice della propria vita. Il pensiero cristiano prevede la salvezza dell’uomo come opera di Dio, senzazialmente la creatura non si salva senza Dio mentre per Seneca l’uomo salva se stesso ed egli, secondo il racconto reso da Tacito, morì suicida per ordine, ma al tempo stesso “generosa concessione” dell’imperatore Nerone. Seneca accusato di avere preso parte ad una congiura contro l’imperatore, preferì il suicidio alla condanna. Scegliendo di “morire bene” mantenne la sua integrità morale e, come Socrate, affrontò la morte coraggiosamente, serenamente e dignitosamente.
Arrivando a considerare la morte secondo la visione religiosa cristiana, ove la filosofia, al servizio della teologia “philosophia ancilla theologiae” e la retta ragione, dimostrano l’esistenza di Dio e portano ad uno dei preamboli di fede, ossia l’immortalità dell’anima, si attesta la finitudine e la limitatezza dell’uomo, creatura di Dio una essenzialmente abitato da Dio. Siccome Dio è puro spirito, Egli non può essere visto e conosciuto direttamente attraverso gli organi sensoriali e dunque nessun intelletto umano può vedere Dio finché resta unito al corpo: è necessario che intervenga la morte corporale al fine di conoscere Dio causa prima di ogni essere. Solo la morte permette la separazione dell’intelletto dal corpo il quale impedisce, finché è vivo, la piena realizzazione dell’“intellectus. Sicut”. Solo così si realizza la felicità ultima e perfetta dell’uomo ossia la visione beatifica di Dio, la “visio dei” impossibile fino a quando non sopraggiunge la morte a separare l’anima dal corpo. Nel cristiano la morte è l’inizio della vita, il “dies natalis”, la nascita alla vita eterna che equivale a conoscere il solo vero Dio.
San Giovanni Evangelista ci dice “Lo vedremo così, com’Egli è”. Tutto si muove o tende verso un fine, lo scopo è un fine, la vita terrena, corporale, termina consentendo il raggiungimento del termine ultimo perché non vi può essere un processo di moto all’infinito. Ogni moto è “ad un” che ci permette di pervenire ad un termine ove il fine è appunto il termine ed il fine ultimo dell’uomo è il bene increato, cioè Dio, il quale nella Sua infinita bontà è il solo capace di colmare perfettamente la misura della umana volontà.
Sempre San Giovanni ci dice “questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e Colui che Tu hai mandato, Gesù Cristo”. Nella teologia di San Tommaso abbiamo la meravigliosa spiegazione di questa affermazione con la precisazione che la visione beatifica non sarà solo di Dio Padre, né solo del Padre e del Figlio, bensì della S.S. Trinità che comprende Padre, Figlio e Spirito Santo e contemporaneamente avremo la visione altresì della santa umanità di Cristo. San Matteo, nel discorso della montagna, ci dice “beati i puri di cuore perché vedranno Dio” che è da intendersi sempre, come precisa San Tommaso, quale comprensione di tutta la S.S. Trinità sempre implicitamente coinvolta quando si citano anche separatamente le 3 persone divine che la compongono. Da questo discende la necessità di vivere bene, secondo le leggi divine, perseguendo le virtù teologali e cardinali: per poter conquistare il celeste Paradiso, dopo la purificazione in Purgatorio, quando, associate agli angeli santi, le anime vedranno finalmente, faccia a faccia, senza la mediazione di nessuna creatura, l’essenza divina in modo immediato, scoperto, chiaro e palese senza interruzione o venir meno della visione e godimento fino al giudizio universale e, da questo, per tutta l’eternità.
Epicuro invece non cerca Dio come S. Tommaso, né la perfezione come Aristotele, tende solo a ricercare il piacere dell’assenza di fastidi e, prima di tutto l’assenza di dolore ed ha come fine della vita il piacere edonistico che esclude la morte: quando noi viviamo la morte non c’è, quando c’è la morte non ci siamo noi. Nella visione biblica la morte viene presentata da San Paolo ai Corinti come pena dovuta al peccato originale: “per un uomo è la morte (Adamo), per un uomo è la risurrezione dei morti (Gesù Cristo, Nuovo Adamo)”. Come risusciteranno i morti, e con quale corpo verranno? Quel che si semina non è vivificato se prima non muore. Il corpo è seminato in corruzione, risusciterà in incorruttibilità, è seminato in ignominia e risusciterà in gloria, è seminato in debolezza e risusciterà in forza, è seminato corpo animale e risusciterà corpo spirituale.
Il cristiano si prepara alla morte, si apparecchia alla morte “come scrive S. Alfonso Maria de’ Liguori ed attende ‘sorella morte corporale’ (S. Francesco d’Assisi) non con paura, ma con fiducia e speranza nella misericordia divina, occasione per abbandonare il peccato risolutamente, chiedere perdono a Dio per i peccati commessi e, nella costante preghiera e nella pratica delle virtù cristiane, invoca il ritorno ‘vieni presto’ e chiede l’intercessione di Maria S.S. e dei Santi per avere consolazione nel trapasso.
Cristo verrà a cercarci come un ladro per cui ci morrà: “state parati quia, qua hora non putatis, Filius hominis veniet”. Per Dio mille anni non sono più di un solo giorno poi verrà a giudicarci “et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos” “judex crederis esse venturus” (Te Deum).
La vita di ogni uomo sta nel cavo di una mano, scorre veloce come l’acqua che raccogliamo alla fontana e che scivola subito via fra le dita. Perciò è esatto affermare che il Signore non tarda a venire. Che il Signore venga al cadere del giorno, o nelle tenebre della notte o al canto del gallo all’alba, il suo ritorno non è mai differito per troppo tempo. Il Signore ci ha promesso la salvezza dell’anima con la perdita della vita terrena e, per mostrare cos’è la gloria eterna, si trasfigurò sul monte Tabor dinanzi agli Apostoli: Pietro, Giovanni e Giacomo, e la fece vedere loro, per quanto potevano contemplarla in questa vita presente, affinché non si rattristassero né della propria, né della morte del Signore. Tant’è che essi, aiutati dall’ardore di questa rivelazione nonché dalle successive manifestazioni di Gesù risorto, conobbero il martirio e lo ottennero.
L’uomo deve profittare del tempo in cui vive sulla terra per guadagnarsi la vita eterna. S. Paolo insegna: “ciascuno riceverà la sua retribuzione secondo il bene o il male che avrà fatto quando era nel corpo”. Perciò ci esorta dunque a compiere il bene mentre ne abbiamo il tempo. La conclusione della giornata, per il Cristiano, riproduce la fine della vita terrena ed a Compieta prega: “in manus tuas, Domine, commendo spiritum meum” e “noctem quietam et finem perfectum concedat nobis Dominus omnipotens. Amen.”
Ogni struttura filosofica moderna, dalla più semplice alla più elaborata, se non è illuminata dalla fede e dall’Amore di Dio, considera la morte come evento ineluttabile e limitante. Privando la morte dell’idea di inizio di un nuovo ciclo vitale, la considera come possibilità esistenziale. Questo implica per Dilthey una “limitazione dell’esistenza” e per Heidegger la morte è la possibilità dell’impossibilità: poiché ogni possibilità può, come possibilità, non essere, la morte è la nullità possibile di ognuna e di tutte le possibilità esistenziali che termina nel nullo.
Sempre secondo la filosofia moderna la vita è caratterizzata da un “desiderio del piacere” perverso infinito. Si dovrebbe dunque disporre di un piacere anch’esso infinito per poter compiere tale aspettativa e soddisfare questo desiderio. Ciò non può avvenire perché il piacere infinito è frutto dell’immaginazione ma non è presente nella condizione umana e pertanto rimane irraggiungibile ed insoddisfatto. E qui abbiamo l’essenza del pensiero leopardiano e l’idea del poeta della vita come continuo passare da un affanno all’altro ove la tranquillità resterà una meta a lungo sospirata e mai raggiunta.
Nella letteratura del 900 troviamo un’opera granDiosa, “Un uomo finito” di G. Papini, romanzo autoDiografico nel quale l’autore racconta di essere “nato con la malattia della grandezza” e, affascinato dal super-omismo e dal titanismo di Nietzsche “voleva diventare Dio”. Dovette arrendersi, deluso, ad accettare la condizione di “uomo finito”. Era pieno di orgoglio, aveva offeso Dio ma, dopo anni di profondo travaglio interiore, si convertì e scrisse quel capolavoro che è la “storia di CRISTO”. L’uomo che volle diventare Dio scrisse poi la vita di un Dio che si fece uomo. L’uomo ha bisogno della pace definitiva, non è mai completamente soddisfatto del presente.
“Noia, impotenza, agitazione continua e desideri eternamente rinascenti: ecco la sorte degli uomini. Per uscire da questo tormento essi seguono due vie: la via del possesso oppure la via della rinuncia”. Quindi secondo Bohini gli uomini cercano di soddisfare il maggior numero possibile di desideri oppure cercano di estirparli tutti. Per Bohini bisogna far sì che non esistano più cose che non si possono avere, ossia è necessario, per l’uomo, possedere tutte le cose e quindi è necessaria l’omnipotenza, l’uomo deve diventare Dio. Successivamente, nella sua rinascita come apostolo della fede avrà un profondo cambiamento e, comprendendo che molte cose desiderate sono irraggiungibili e, scegliendo di vivere secondo la morale cristiana più vigorosa, esaminerà la possibilità di sopprimere la “cupidigia”, di uscire dall’appetizione sensibile. Solo se si offre in totale abbandono a Dio, mediante la grazia, ogni sofferenza ed ogni rinuncia al secolo, è possibile approdare al porto sicuro della salvezza. In caso contrario, di fronte all’insostenibilità dell’esistenza, delle tribolazioni che, nella vita sono sempre grandi, ma che raggiungono talora un’ampiezza smisurata, molti uomini, nel corso della storia ed oggi, ancora più frequentemente, vedono il suicidio come via d’uscita da una vita che, a causa della malattia, dell’età, della depressione, della disgrazia, della disperazione in genere, diventa un peso insostenibile peggiore dell’annichilimento.
Per il Cristianesimo il suicidio è contrario alla volontà divina e costituisce un peccato imperdonabile in quanto peccato di superbia e priva la persona della possibilità di espiazione. S. Agostino nel “De civitate dei” considera il suicidio come un’aggravante dell’omiciDio (V comandamento) perché non è solo una mancanza ed una sorta di tradimento verso il prossimo (ad esempio gli amici ed i familiari) o contro se stessi, ma soprattutto verso Dio, signore della vita dal quale abbiamo ricevuto un dono nel mondo che non è lecito abbandonare.
Il suicidio di Giuda, avvenuto tragicamente dopo che questi aveva gettato nel tempio il prezzo del tradimento di Gesù (i trenta denari) ed era corso ad impiccarsi (l’angelo di S. Matteo) è esemplare: drammatico ed ha alimentato l’orrore per il suicidio. Gesù aveva anticipatamente detto: “meglio per lui non essere mai nato” ed ecco poi la fine ignominiosa, la caduta dell’albero al quale si era impiccato e lo spargimento delle viscere. Giuda compì con un peccato ancora più grave di quello del tradimento perché, in preda alla disperazione, con quell’atto di superbia, disperò della misericordia di Gesù.
Questa vita che san Bernardino definisce mirabilmente “vita mortale o morte vitale” appartiene solo a Dio il quale ce l’ha donata e non ci è lecito togliercela e pertanto, fino al Concilio Vaticano II, era interdetta la sepoltura cristiana a chi moriva suicida. Nel mondo pagano prevaleva il pensiero: “mori licet cui vivere non placet”. Si narra che il Santo Curato d’Ars ebbe una visione durante la quale incontrò l’anima di un uomo che era morto suicida gettandosi da un ponte. Mentre stava volontariamente precipitando dal parapetto del ponte, questo sventurato, prima di raggiungere l’acqua, ebbe un attimo di contrizione e di pentimento per il suo gesto e la Vergine S.S. gli ottenne la grazia del perdono. “Egli è salvo. Il vostro sposo si trova in Purgatorio, dobbiamo pregare per la sua anima.” disse il Santo curato alla vedova di quell’uomo annegato suicida alla quale i medici avevano consigliato di viaggiare per distrarsi dall’atroce disperazione che seguì alla tragica morte del marito. Il Santo d’Ars non conosceva questa donna ma, passando in mezzo alla folla, si diresse verso di lei e le sussurrò all’orecchio “egli è salvo”.
Nell’inferno dantesco, ove il poeta incontra gli spiriti dei suicidi in strani alberi spettrali, che neppure dopo il giudizio universale torneranno a rivestirsi del corpo contro il quale incrudelirono perché la frattura operata fra l’anima ed il corpo non potrà più essere ristabilita, viene collocato Pier della Vigna, poeta e ministro dell’imperatore Federico II, uccisosi in carcere sotto il peso insopportabile delle calunnie e dell’ingiusto sospetto del suo signore. Questi, mosso da uno spirito di ombrosa ribellione, illudendosi di suggellare la propria innocenza riuscì ad oscurarla nella mente degli uomini e, peccando, commise ingiuria contro se stesso, che era stato fino a quel punto vittima innocente della calunnia ed attirò su di sé l’ira di Dio.
Troviamo invece Catone l’uticense, che si uccise in Utica per sottrarsi alla tirannide di Cesare nel Terzo del Purgatorio ove è posto da Dante quale custode, simbolo dell’idea di libertà che rappresenta per il poeta la vittoria della volontà razionale sulle passioni e dello spirito sulla materia coincidendo con il libero arbitrio. Il poeta manifesta grande ammirazione per il “vecchio, austero, maestoso, dignitoso, esaltazione della ‘gravitas’, ‘exemplum’ quasi religioso del martire”.
L’Ottocento è il secolo in cui la letteratura ha presentato forse più frequentemente il tema del suicidio talvolta come volontà di auto-annientamento di scrittori, poeti ed artisti travolti dalla solitudine, dal disincanto, dalla delusione e dalla disperazione, altre volte attraverso protagonisti di opere letterarie.
Ugo Foscolo dedicò al fratello Giovanni Dionigi, morto suicida nel 1801 a soli vent’anni a causa di debiti di gioco, il celebre sonetto “in morte del fratello Giovanni”. Vi domina la tonalità malinconica “io vedrò seduto su la tua pietra, o fratello mio, gemendo il fior de’ tuoi gentili anni caduto” che sembra inaugurare il destino del poeta anch’egli ossessionato dal fantasma del suicidio e pervaso dalla dolcezza della morte, il dolce perdersi di una vita angosciosa nell’oblio del “nulla eterno”, nella pace della sera della “fatal quiete immago”. Nelle ultime lettere di Jacopo Ortis è ancora presente l’abbandono nel nulla di Jacopo nella tenebrosa ora della morte. Egli, inquieto e senza pace, quando viene a conoscenza del matrimonio di Teresa, di cui è perdutamente innamorato, e con il crollo degli ideali romantici in seguito alle infelici esperienze politiche, si uccide conficcandosi un pugnale nel cuore.
Nella letteratura scapigliata, ovvero il tardo romanticismo, prevale la ribellione nell’arte come nella vita, contro la società borghese, la società dell’epoca, la religione, le convenzioni sociali, la ricerca dell’orrido e del macabro, la ricerca quasi di una rivelazione poetica bislacca, di una sorta di estetismo che ostenta il peccato ed i cupi abissi dell’anima per il gusto della dissoluzione, esistenze brevi vissute in modo estremo e, non di rado, terminate con il suicidio. Le vite degli scapigliati, quasi tutte sconvolte da inquietudini, nevrosi, eccessi auto-distruttivi, sono esempi di dissipatezze e sregolatezze estreme: Emilio Praga morì non ancora quarantenne consumato dall’alcool e dalla tabe; Giovanni Camerana, vissuto anch’egli secondo lo stile “bohémien”, morì suicida. Così il pittore, artista scapigliato, Tranquillo Cremona, morì in seguito a lento avvelenamento. Charles Baudelaire, autore dei “fiori del male”, inno all’immoralità, all’indecenza ed allo scandalo, accumulò debiti consistenti e frequentando prostitute, contrasse malattie veneree che lo portarono alla morte. Analoga fine quella di Paul Verlaine caduto nella miseria più nera aggravata dall’alcolismo cronico e dalle malattie veneree. Tutto sommato, in un eccesso di follia, di sfrangiamento la propria mosca. Nel clima milanese della scapigliatura, ma sotto un’influenza manzoniana realista, secondo un impulso divulgativo finalizzato all’elevazione sociale ed intellettuale del grande pubblico, si colloca poi Emilio De Marchi, cattolico sincero, desideroso di diffondere sentimenti d’amore e di benevolenza, ben più importanti delle scoperte scientifiche, per aiutare le persone a vivere bene. Il suo capostipite letterario “Demetrio Pianelli” ci presenta personaggi della piccola e media borghesia, le cui vicende e drammi sono quelli della “povera gente” avvinta in esistenze grigie e scolorite, vite modeste in case modeste, una povertà diffusa nella Milano umida e nelle campagne lombarde piovose e fangose. Demetrio Pianelli, umile impiegato, abituato a vivere un’esistenza incolore, ma moralmente dignitosa, viene sconvolto dal suicidio del fratello Cesare, che invece è ambizioso, desideroso di affermarsi in società e portato ad un tenore di vita superiore alle proprie possibilità, spendereccio. Pur di compiacere la moglie Beatrice, donna onesta e bellissima, che egli adora e per la quale stravede, questi sottrae una somma dalla cassa del suo ufficio per fare fronte ad un debito. Scoperto, mentre ancora si arrabatta per restituirla, si uccide per sfuggire al disonore in un tetto ed angusto sottotetto di una casa all’estrema periferia della città e reduce dalle follie carnevalesche. Perciò corre verso la morte in una furia d’annientamento dopo aver scritto un biglietto d’adDio “un fiume di lacrime gli ottura la vista della carta”. Il debito che lo porta ad impiccarsi è il tributo dovuto alla bellezza della moglie, il naufragio di un’esistenza. Drammatico il rinvenimento del corpo da parte di un adolescente, sguattero di bottega, che sbucato nel sottotetto “urta” con la testa un paio di gambe penzolanti: “di quell’uomo che gettava nella disperazione la moglie ed i tre figlioli.” Il rifiuto degli amici e dei conoscenti di aiutarlo economicamente con un prestito porta (esortano all’annientamento, proprio come Emma Bovary, nel romanzo di Gustave Flaubert, donna irrazionale, vacua, amante del lusso sfrenato, insoddisfatta del grigiore della sua vita coniugale, procura la sua rovina ed il suo dissesto dai quali potrebbe ancora venire salvata da un antico amante del quale Emma, disperata, si reca, nella speranza di ottenere un prestito. Il rifiuto dell’uomo, lei è incapace di continuare a vivere e sprofondare in un abisso si precipita nella farmacia dove riesce ad inghiottire disperatamente una manciata di polvere per topi “poi se n’andò, subitamente calmata, e quasi nella serenità” di un dovere compiuto”.
Nelle opere del realismo ottocentesco spicca quello che Dostoevskij definì l’opera d’arte alla quale “niente della letteratura della vasta epoca può essere paragonato” ossia il romanzo di Tolstoj “Anna Karenina” ove la protagonista, follemente innamorata del conte Vronskij, diventò vittima di una gelosia ingiustificata ed esasperata che la porta a gettarsi sotto un treno. Questa la drammatica conclusione di una tormentata relazione extra-coniugale, di una storia d’amore di cui la stazione diventa scenario dell’inizio e della fine, secondo un processo circolare e la scelta del treno, come strumento di morte, ha anch’essa un forte valore simbolico, ove viene rappresentata la velocità che aveva segnato l’inizio fulmineo della passione e la fine altrettanto rapida nella dissoluzione.
Spesso Leopardi mette in rilievo la radicale contraddizione del nostro essere: da una parte l’amore per la vita che persiste nonostante il dolore, il fastiDio stesso della vita, “la vanità” delle cure “e contemporaneamente presenta una filosofia pessimistica che dovrebbe considerare il suicidio come l’unica soluzione logica di questa assurda vita. Ritroviamo nel “Dialogo di Plotino e di Porfirio” l’intenzione di Porfirio, discepolo di Plotino, di uccidersi a causa dell’assoluta vanità della vita. Plotino, pur approvando le disperate conclusioni e disposizioni d’animo di Porfirio, pur ritenendole ragionevolissime e le forze contrarie irragionevoli”, lo esorta a vivere, in nome di un sentimento più vero e profondo, fondato questa volta non sulla ragione ma su un sentimento che ci fa sentire uniti agli altri uomini, molti compagni di sventura, da un fraterno legame d’amore e di reciproca pietà, “non dobbiamo privarci spontaneamente, per sempre, della vista, del colloquio, della consuetudine dei nostri cari. Né per nulla il dolore della disgiunzione e della perdita dei parenti, degli intrinseci, dei compagni non è da sapiente di barbarie”.
Molto bella la parte conclusiva del dialogo “… l’amico mio, per la memoria degli anni che fin qui è durato l’amicizia nostra, lascia codesto pensiero, con voler essere cagione di questo grande dolore agli amici tuoi buoni che ti amano con tutta l’anima, a me che non ho perso una più cara, né compagnia più dolce … non rifiutiamo di portare quella parte che il destino ci ha stabilita, dei mali della nostra specie. Aiutiamoci a tenerci compagnia l’un l’altro e andiamoci incoraggiando, e dando mano e soccorso scambievolmente … quando la morte verrà non ci dorremo, gli amici ed i compagni ci accoglieranno e ci ameranno ancora.”
Considerando la visione di alcuni filosofi moderni di condanna o apprezzamento totale o parziale del suicidio, possiamo vedere come Hume, nel suo saggio sull’argomento, giustifica il suicidio “Sul suicidio ed altri saggi morali” e lo vede non come un peccato contro Dio e contro la legge naturale, manifestazione per don Tommaso della stessa volontà di Dio, bensì come cessazione di fare del bene alla società.
Martin Heidegger che distingue due modi di rapportarsi alla morte ovvero quello autentico (accettazione della propria finitezza, possibilità sconvolgente, essere – per la morte) e quello inautentico (evento che riguarda solo gli altri) il suicidio è una fuga dalla responsabilità di vivere autenticamente. La grande poetessa Ada Negri, prima ed unica donna ad essere ammessa all’Accademia d’Italia, soffrendo per tanti mali dell’anima e turbamenti della vita coniugale, toccando la piccola bimba accanto assonnata, confida: “ho tanto male al cuore, ho tanto male, che la mia vita stasera coi denti:” “V’è un modo per fuggir l’affanno atroce. Ma tu mi tieni col tuo dolce bacio, tu che non puoi dormire se non ti traccio in fronte a sera, il segno della croce.”
Per il pensiero cristiano, la questione del libero arbitrio è di condominante importanza e per S. Tommaso è ciò che determina l’uomo ad agire ossia l’uomo determina se stesso ad agire in base al libero arbitrio. L’uomo avrebbe la sinderesi (la luce della coscienza, “scintilla conscientiae”) che gli permette di avere conoscenza del bene e del male. Per S. Agostino l’uomo deve di sua spontanea volontà invertire l’ordine delle cose anteponendo le cose materiali e terrene che passano e sono vane al regno di Dio che è stabile. Per non cadere nel peccato l’uomo deve fondare la sua vita sulla grazia. Il peccato originale, che si è trasmesso da Adamo agli altri uomini, ha causato l’indebolimento della volontà della rettitudine della giustizia. Seguirono poi nell’uomo decaduto molte altre indigenze e si modificarono i moti disordinati delle passioni.
Dio conosce tutte le cose prima che avvengano (preveggenza di Dio) e gli eventi non si verificano fatalmente. Così Dio conosce nelle cause degli avvenimenti la nostra volontà e se per preveggenza che questa è causa delle nostre azioni dunque le cause efficienti di tutti i movimenti sono volontarie. Il volere cattivo non è mai da Dio perché sarebbe contro la sua natura e la sua infinita bontà. Sì, Agostino preferisce la prescienza per credere bene ed il libero arbitrio per vivere bene. Perciò l’arbitrio della volontà è libero quando non è schiavo dei Vizi e dei peccati: la vita è piena di fatiche e quanti mali che non sarebbe possibile enumerare ed è ridotta quasi un inferno del quale ci libera soltanto la gratia di Cristo del Salvatore, Dio e Signore nostro. E proprio per questo la gratia aiuta i più buoni nella pena della vita affinché siano sopportate con un sentimento tanto più coraggioso quanto più religioso.
(De consolatione philosophiae di Boezio: La vera filosofia è un dono della gratia divina ed è un grande soccorso contro le infelicità di questa vita. Sì, Agostino assicura, riprendendo il Paolo nella sua lettera ai Galati che la carne ha desideri contrari allo spirito e lo spirito contrari alla carne e perciò non facciamo quel che vogliamo se acconsentiamo ai cattivi impulsi; mente, non acconsentendo, per quanto ci è possibile, con l’aiuto della gratia di Dio, evitiamo l’inganno ed il peccato. Il primo libero arbitrio fu dato all’uomo quando all’inizio fu creato innocente, potendo non peccare ma anche peccare mentre con l’ultimo arbitrio sarà tanto più libero perché non potrà peccare.
Pascal, pur riconoscendo l’esistenza del libero arbitrio sottolinea il ruolo fondamentale della grazia divina nelle azioni umane. Per Kierkegaard il libero arbitrio è un elemento decisivo nella esistenza dell’uomo ove “ex-sistere” indica uscire fuori attraverso la scelta di uscire dall’apatia e da ciò che è indeterminato. L’individuo risulta così esposto alla possibilità del fallimento e di qui nasce l’angoscia, la vertigine della libertà “choisy”. Quando l’uomo sceglie compie il salto nel buio. Solo con la fede e una vita religiosa, si compie per Kierkegaard, la scelta radicale e l’abbandono in Dio.
Al termine di questa serie di considerazioni fatte da uomini illustri e geniali trovo bellissima ed eccelsa la conclusione agostiniana del capolavoro “De civitate dei”: “Ecco quel che si avrà senza fine alla fine. Infatti quale altro sarà il nostro fine, che giungere al regno che non avrà fine.”
Massimo Ricalzone, esperto di filosofia teoretica
Leggi il riassunto di questo saggio L’enigma della morte e la libertà dell’uomo di Massimo Ricalzone, esperto di filosofia teoretica
Materiale didattico e appunti su atuttascuola
-
Summa Theologiae e Quaestio 85 in formato pdf, di Sandro Borzoni
- Compito di Filosofia su San Tommaso e Guglielmo di Ockham di Alissa Peron
Materiale didattico e appunti su altri siti
-
S. Tommaso, Ragione e fede (da Summa Theologiae, I, q. 1. art. 1) – (File PDF, 23.8 KB) a cura del prof. Roberto Mastri del Liceo Malpighi di Bologna
-
De Ente et Essentia in power point della prof.ssa Scalini del Liceo Malpighi di Bologna
-
Fede e Ragione in power point della prof.ssa Scalini del Liceo Malpighi di Bologna
-
S. Tommaso D’aquino di popoli antichi
-
Tommaso d’Aquino del prof. Donato Romano
-
Il problema della eternità del mondo visto da Tommaso D’Aquino di Andrea Inzerillo
-
Guida alla lettura del De Ente et Essentia di Tommaso d’Aquino di Andrea Porcarelli
-
Il MeDioevo e Tommaso di Hans Georg Gadamer
-
S. Tommaso appunti dalle lezioni di filosofia del prof. Maurilio Lovatti, di Paola Volonghi
-
S. Tommaso, Le cinque vie (da Summa Theologiae, I, q. 2. art 3) – (File PDF, 83.2 KB) a cura del prof. Roberto Mastri del Liceo Malpighi di Bologna
-
Tomismo e neo-tomismo nell’Ottocento e nel Novecento di Andrea Porcarelli
-
El problema de la eternidad del mundo visto por Santo Tomás de Aquino di Andrea Inzerillo
-
Schema su Tommaso d’Aquino (ragione e fede, quid e quia, atto e potenza d’essere) di FaDio Utili
-
L’argomento ontologico: le interpretazioni del Novecento di Maurizio Pancaldi
-
L’ontologia genetica dopo la crisi del pensiero unico di Graziella Morselli




