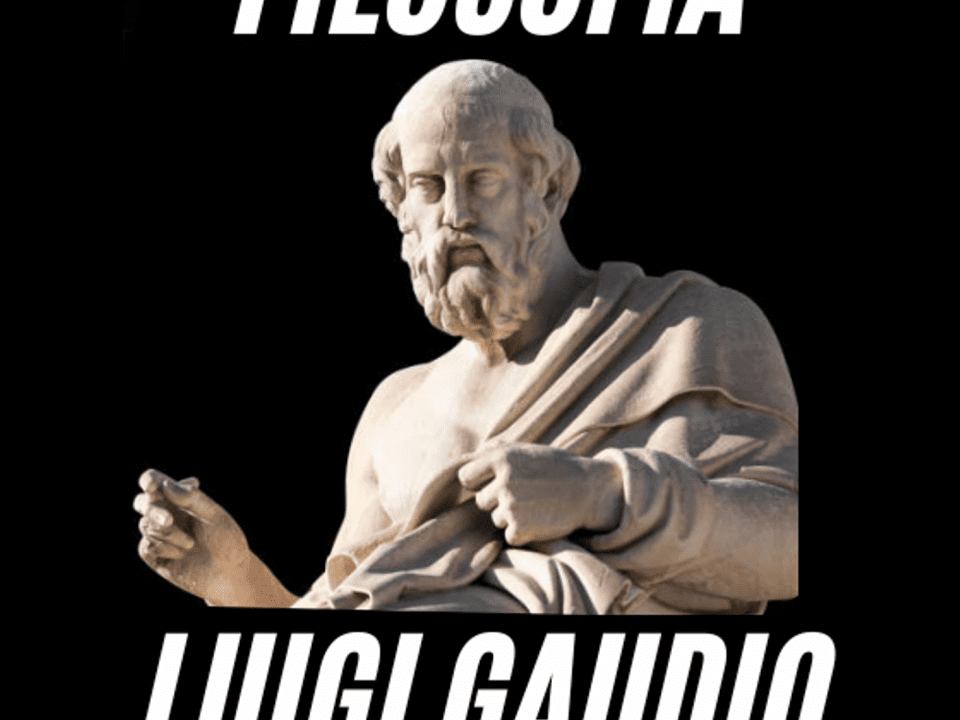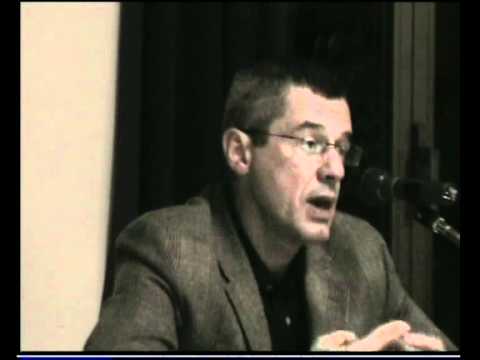
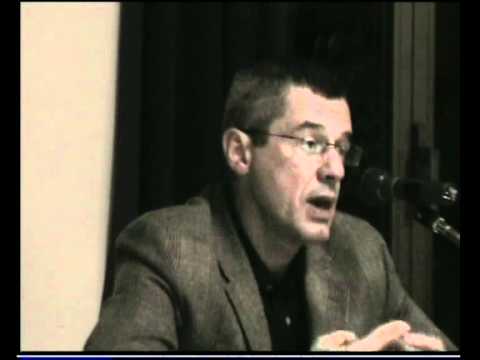
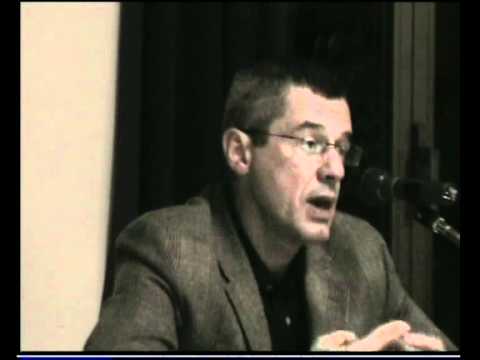
Alberto Reggiori
27 Gennaio 2019

STATO SOCIALE
27 Gennaio 2019dalla Tesina “Le trasformazioni del linguaggio attraverso i mezzi di comunicazione” di Barbara Ruzzo
ITC Melloni – Classe 5 Sirio – Anno scolastico 2010 – 2011
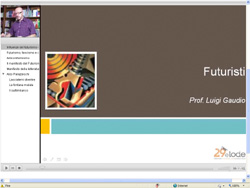
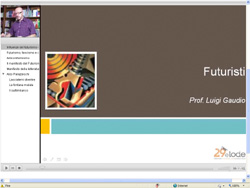
Futurismo
Il movimento futurista fu fondato da Filippo Tommaso Martinetti, che il 20 Febbraio 1909 pubblicò il primo manifesto del Futurismo sul giornale francese Figaro”.
Il termine futurismo sottolineava il carattere di un movimento proiettato verso il futuro, e d’altra parte a Marinetti, che era superstizioso e credeva nelle coincidenze e nella cabala, piacque subito poiché nella parola vedeva anche le iniziali del suo nome (FuTurisMo).
Il futurismo ha prodotto in Europa il primo manifesto della modernità coinvolgendo subito tutte le arti; i futuristi per primi riconobbero l’incidenza sulla moderna società della macchina e delle tecnologie industriali e compresero i rapidi mutamenti della sensibilità contemporanea, provocati dai nuovi mezzi di comunicazione e trasporto. Si scatenavano invece furiosamente contro ogni forma di passatismo”, contro le vecchie abitudini, le vecchie istituzioni (musei, biblioteche), i patrimoni culturali e artistici ereditati dal passato, le città secolari, tutte cose che secondo i futuristi avevano l’odore della muffa e della putrefazione.
Contemporaneamente il movimento si allarga a tutte le arti, dalla pittura alla scultura alla musica al teatro drammatico e al teatro di varietà, praticando quel criterio dell’interartisticità che è tipico di tutte le avanguardie. Il movimento rivela grandi capacità di espansione facendosi propaganda nelle serate futuriste”, in cui gli artisti recitano le loro poesie e provocano il pubblico, non senza risse.
In letteratura i futuristi perseguono soprattutto la ricerca di temi nuovi, desunti dalla vita della moderna città industriale, colta nel suo dinamismo e nel suo disordine : la modernità e i suoi prodotti più tipici: la macchina e la velocità, il caos e l’attività frenetica delle grandi città industriali.
Ma temi nuovi richiedono forme nuove. L’antica sintassi non può reggere alla successione rapida delle impressioni suscitate dalla velocità. Il verso tradizionale non può adattarsi ai nuovi ritmi. Per questo Marinetti, nei suoi manifesti” proclama la distruzione della struttura sintattica e prescrive l’abolizione dell’aggettivo qualificativo, dell’avverbio, della punteggiatura, l’uso del verbo all’infinito e di aggettivi semaforici, l’impiego nella scrittura anche di caratteri musicali e matematici, di segni tipografici e colori diversi, si onomatopee, di parole riplasmate e deformate a scopo rumoristico”.
Questi precetti eversivi sono a fondamento delle parole in libertà”: dopo aver rinunciato alla logica, alla scrittura razionale, all’ordine consapevole dei significati, il futurista si affida ad una dimensione intuitiva, alogica, che procede per immagini e analogie. Pur rinnegando i maestri simbolisti, il futurismo mostra di aver assimilato la lezione simbolista nell’uso della tecnica dell’analogia, in quella volontà di suggerire più che dire, di provocare l’intuizione più che enunciare.
Un’arte capace di conquistare la modernità e per essi legata alla negazione della psicologia, della riflessione, di ogni forma di mediazione: deve identificarsi direttamente con il movimento vitale, seguendo il flusso della produzione di nuovi oggetti; deve esaltare la potenza delle macchine e partecipare al processo di rinnovamento continuo, di costruzione e distruzione di cui è fatta essenzialmente la vita moderna.
Ai processi pacati dell’intelligenza e della comprensione razionale si sostituisce lo choc, il lampo dell’intuizione, il gesto e lo schiaffo, la forza e l’energia giovanile, nella loro distruttiva irrazionalità. Con dirompente aggressività questo nuovo modo di concepire la comunicazione artistica si collega a una volontà di dominio: per il futurismo l’arte deve porsi come giuda dellininterrotto potenziamento delle capacità dell’uomo, espressione dell’energia dei forti contro l’inerzia dei deboli, presa di possesso della natura e scoperta di sempre nuove possibilità di forza e di piacere.
Partendo da questo presupposto, il Futurismo, con la sua visione positivista e ottimistica, teso verso la tecnologia e il futuro, propone una nuova arte che pone come suo unico idolo la macchina , simbolo dell’innovazione, del movimento della dinamicità e soprattutto della “velocità”.
- torna all’indice della tesina Le trasformazioni del linguaggio attraverso i mezzi di comunicazione di Barbara Ruzzo
- torna all’indice della tesina Le trasformazioni del linguaggio attraverso i mezzi di comunicazione di Barbara Ruzzo