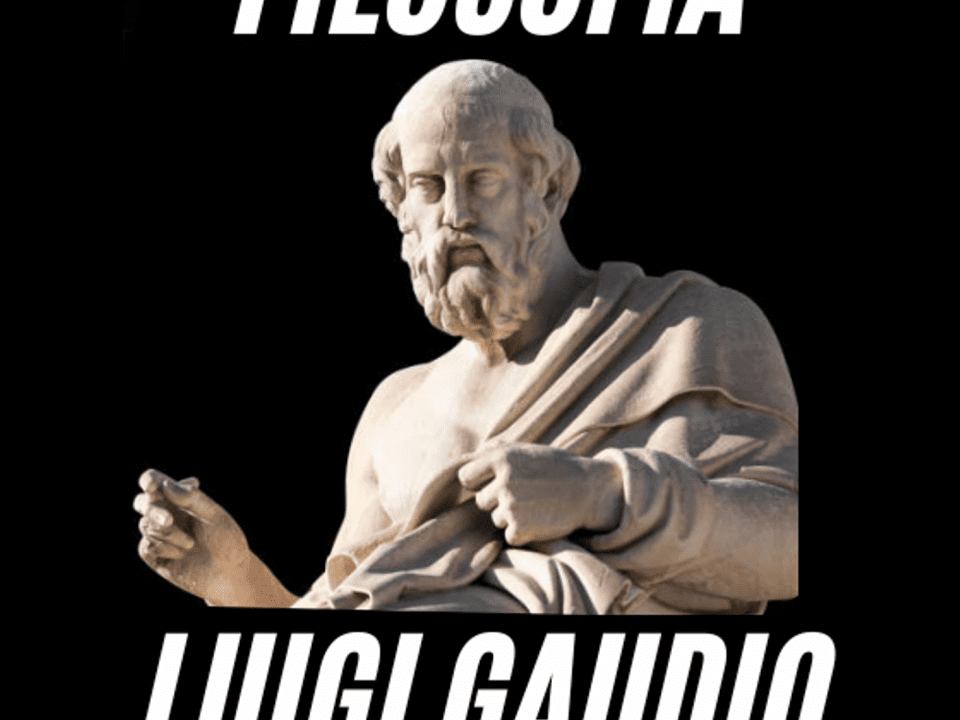Testo descrittivo
27 Gennaio 2019


Dipinti di Antonello da Messina
27 Gennaio 2019
sonetto, n. 100 del canzoniere di Petrarca
analisi del testo di Alissa Peron
testo
Quella fenestra ove l’un sol si vede,
quando a lui piace, et l’altro in su la nona;
et quella dove l’aere freddo suona
ne’ brevi giorni, quando borrea ‘l fiede;
e ‘l sasso, ove a’ gran dí pensosa siede
madonna, et sola seco si ragiona,
con quanti luoghi sua bella persona
coprí mai d’ombra, o disegnò col piede;
e ‘l fiero passo ove m’agiunse Amore;
e lla nova stagion che d’anno in anno
mi rinfresca in quel dí l’antiche piaghe;
e ‘l volto, et le parole che mi stanno
altamente confitte in mezzo ‘l core,
fanno le luci mie di pianger vaghe.
analisi
Componimento 100: viene evocato il luogo dell’innamoramento, un paesaggio interiore, e il primo giorno. Verso finale le luci mie di pianger vaghe: eco dantesca, Inf 29 2-3. Dei due soli l’uno è quello fisico e l’altro è la donna, il vivo sole del sonetto 90. Il primo sole, la donna, può splendere quanto a lui piace, quello fisico in su la nona, è vincolato a illuminare le ore del giorno (la nona = le tre del pomeriggio). E quella: la finestra affacciata sull’inverno, i giorni più brevi anche di memoria virgiliana (brevior dies). A gran dì: nei giorni estivi, più lunghi. Sasso: riferimento a Valchiusa (vd sonetto 127, il sasso dal quale è chiusa questa valle, altamente medievale). Il sasso è un luogo discosto, lontano dal tumulto, dove Laura vuole stare sola. Il fiero passo: il momento in cui Amore colpì il poeta. La nuova stagion: la primavera in cui tutti si innamorano, topos letterario. Il verbo principale fanno è alla fine, unico verbo reggente con tanti soggetti; eco interna con stanno e anno. Il poeta sottrae alle contingenze la loro banalità e le fa assurgere a modello dell’innamoramento; il verbo finale che porta da solo molti soggetti crea attesa e smarrimento al lettore, e finisce con un mazzo di fiori a Dante.