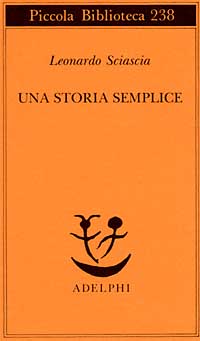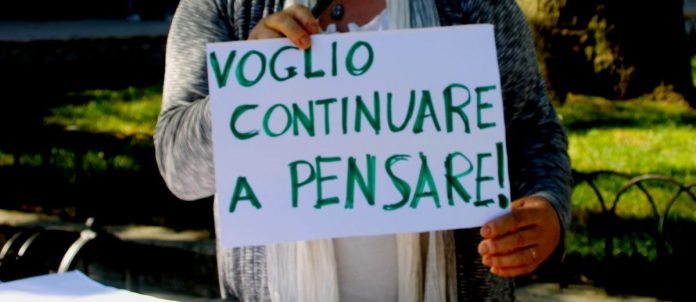In principio era Dylan
27 Gennaio 2019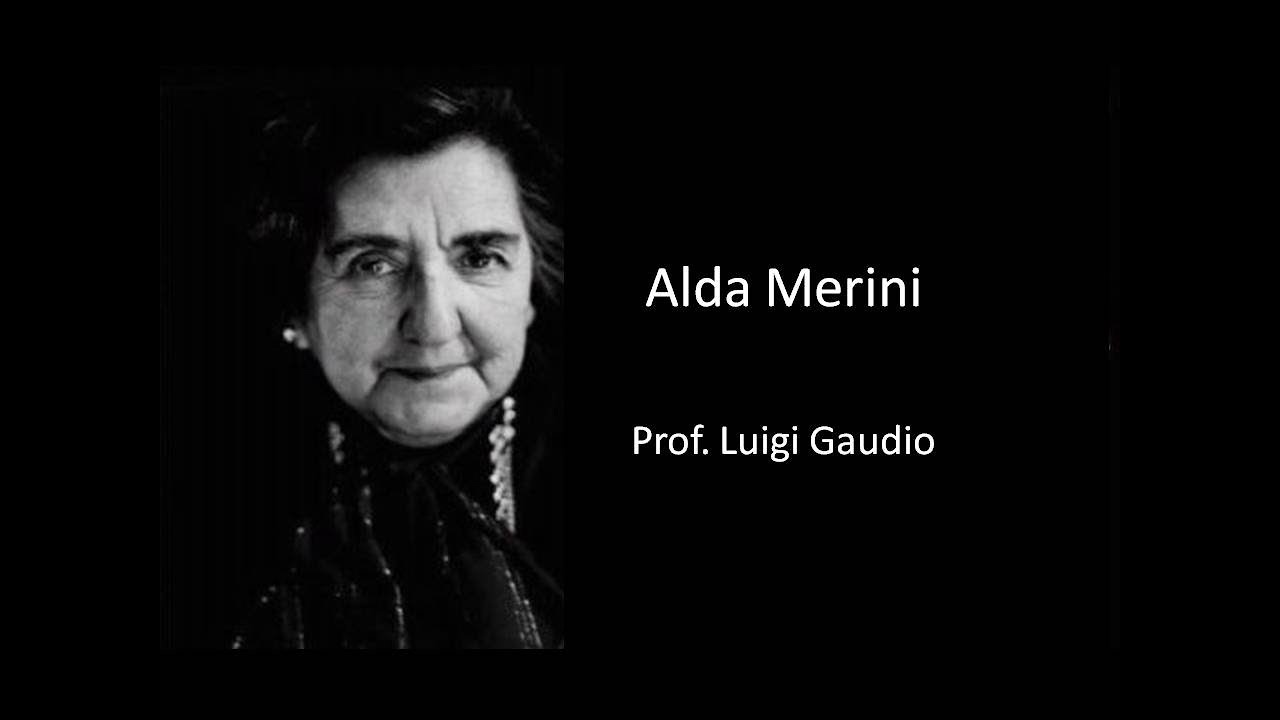
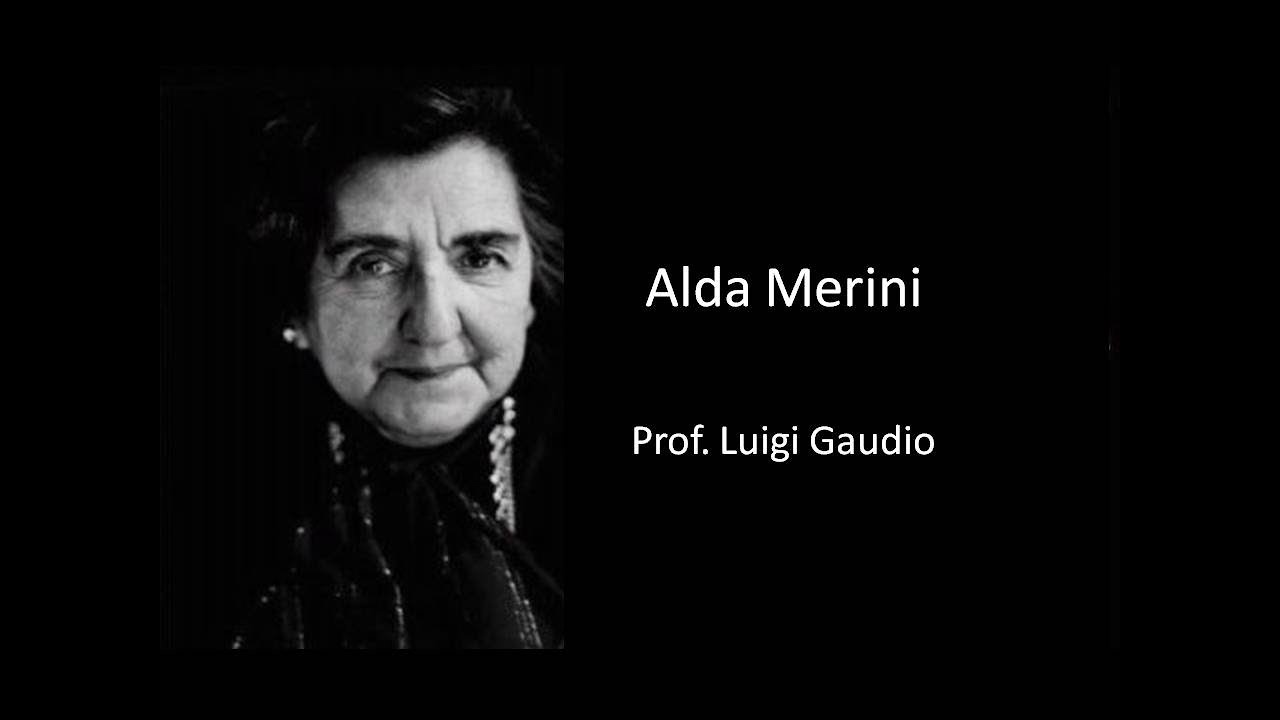
Alda Merini
27 Gennaio 2019Analisi del testo narrativo “Una storia semplice” di Leonardo Sciascia, di Martina Agosti, Seconda F
- Titolo: Una storia semplice ; Piccola Biblioteca; Adelphi; ventunesima edizione: febbraio 2003.
- Autore: Sciàscia, Leonardo
scrittore italiano (Racalmuto, Agrigento, 1921-Palermo 1989). Insegnò nelle scuole primarie fino al 1957 e da questa esperienza trasse lo spunto per il primo romanzo, Le parrocchie di Regalpietra (1956), che rappresenta con realismo aggressivo le contraddizioni più stridenti della società siciliana. Dopo i racconti Gli zii di Sicilia (1958) e i romanzi Il Consiglio d’Egitto (1963) e Morte dell’inquisitore (1964), S. ha affrontato il tema della mafia in alcune tra le sue opere più mature: Il giorno della civetta (1961, portato sullo schermo da D. Damiani nel 1968), L’onorevole (1965), amara satira del mondo politico, e A ciascuno il suo(1966, diretto da E. Petri nel 1967 per il cinema), sulla vana ricerca di un intellettuale per scoprire i responsabili di un duplice delitto. Il procedimento di romanzo giallo caratterizza anche Il contesto (1971, da cui F. Rosi nel 1976 ha tratto il film Cadaveri eccellenti), impietosa analisi del potere politico come strumento di dominio, e Todo modo (1974, tradotto in film nel 1976 per la regia di E. Petri), lucida requisitoria contro l’arroganza del potere che si cela dietro la copertura di una falsa religiosità. A La scomparsa di Majorana (1975), che ha suscitato un appassionato dibattito nel mondo della scienza italiano, hanno fatto seguito I pugnalatori (1976), Candido ovvero un sogno fatto in Sicilia (1977), i pamphlet politici L’affaire Moro (1978), Nero su nero e il libro-intervista La Sicilia come metafora, pubblicati nel 1979, Kermesse (1982), raccolta di storie incentrate su detti siciliani, La sentenza memorabile (1983), la raccolta saggistica Cruciverba (1983) e il repertorio di locuzioni siciliane Occhio di capra (1984). Del 1988 è il disincantato romanzo Il cavaliere e la morte, seguito da Una storia semplice (1989). Ai suoi due ultimi anni di vita appartengono le conversazioni con D. Porzio, pubblicate postume con il titolo Fuoco all’anima (1992). Tra il 1987 e il 1991 sono usciti i tre volumi delle Opere, curati da C. Ambroise. Sempre postume (1992) sono state pubblicate le raccolte di saggi Fatti diversi di storia letteraria e civile e A futura memoria (se la memoria ha un futuro). A S. si devono anche acuti saggi letterari (Pirandello e la Sicilia, 1961; La corda pazza, 1971) e tre testi teatrali, riuniti in volume nel 1976: L’onorevole – Recitazione della controversia liparitana – I mafiosi. Collaboratore di numerosi giornali e riviste, come saggista e critico, ha diretto Nuovi Argomenti e svolto la funzione di finissimo suggeritore editoriale per Sellerio. Spirito libero, curioso, coltissimo, critico lucido e provocatorio del nostro tempo, S. è una delle grandi figure del Novecento italiano ed europeo.
- Riassunto: la sera del 18 marzo Giorgio Roccella telefona per parlare con il questore che però non c’è. Esso, quindi, viene messo in contatto con l’ufficio del commissario e parla con il brigadiere al quale dice di avere una cosa da fargli vedere. Alla fine della telefonata il commissario chiede spiegazioni, da l’ordine di andare al villino e di non chiamarlo perché doveva festeggiare con un amico san Giuseppe. Il giorno seguente il brigadiere ed altri si recano sul luogo per controllare ma trovano Roccella morto, appoggiato alla sua scrivania sulla quale stava un foglio con la scritta ‘ho trovato. .
Da qui incominciano le indagini del brigadiere che è convinto che si tratti di un omicidio. Prima di arrivare alla soluzione del caso interroga molte persone tra cui: padre Cricco, il professor Ranzò, ex moglie e figlio di Roccella.
Avviene poi un fatto molto strano, infatti da un treno fermo perché senza un segnale di via libera viene chiesto ad un uomo che guidava una Volvo di andare dal capotreno per avere il segnale. Esso ci andò ma invece del vero capostazione trovò tre uomini che avevano ucciso il vero capostazione e i macchinisti. L’uomo però non lo sapeva e se ne andò. Per questo diventò un indagato ma quando scoprirono che non aveva colpa fu d’aiuto per il riconoscimento dei macchinisti.
In fine il brigadiere scopre la colpevolezza del commissario soprattutto grazie ad un particolare. Infatti il commissario, pur dicendo di non essere mai stato in quella casa, sapeva dove si trovava la luce delle scale del villino che il brigadiere non era riuscito a trovare.
La morte del commissario avvenne nel suo ufficio dove fingendo di pulire la sua arma sparò al brigadiere senza colpirlo. Questo prese la sua pistola e lo ammazzò.
Infine si scopre che il finto capostazione era padre Cricco grazie ad un ricordo dell’uomo della Volvo che però decide di non dirlo a nessuno.
- Personaggi: Giorgio Roccella: diplomatico in pensione di Monterosso, nato appunto a Monterosso il 14 gennaio 1923. Era stato console d’Italia in varie città europee, si era fermato in fine a Edimburgo dove, separato dalla moglie, viveva con un figlio ventenne. Non era tornato in Italia, dopo all’incirca quindici anni, se non per tragicamente morirvi, il 18 marzo del 1989. Era stato il solo della famiglia a conservare, ma non curandosene, qualche frantume di una vasta e varia proprietà.
Figlio di Roccella: vive con esso ad Edimburgo, e diventa proprietario del patrimonio del padre;
Moglie di Roccella: vive a Stoccarda; non riceve niente in eredità;
Questore: fin dall’inizio, durante le indagini, vuole chiudere il caso come un suicidio ma alla fine cambia idea seguendo i ragionamenti del brigadiere;
Brigadiere Antonio Lagandara: era nato in un paese contadino tanto vicino alla città che ormai se ne poteva considerare parte. Aveva preso il diploma ma non sapendo che fare e non trovando, si era arruolato nella polizia; e ne era diventato, cinque anni dopo, sottufficiale. Il mestiere lo appassionava, e voleva perciò farvi carriera. Si era iscritto alla facoltà di legge, la frequentava quando e come poteva, studiava. La laurea in legge era il suo sogno. Fin dall’inizio era convinto la morte di Roccella non era un suicidio ma era un omicidio.
Commissario: inizialmente esce dalla scena dicendo di non chiamarlo perché doveva festeggiare san Giuseppe da un amico; poi, scoperto omicida, verrà ucciso dal brigadiere;
Padre Cricco: si occupava di far sapere a Roccella le condizioni del villino attraverso delle telefonate;
Professor Carmelo Franzò: era un caro amico di Roccella;
Uomo della Volvo: incaricato di avvisare il capotreno di dare il segnale di via libera al treno fu accusato e chiuso in prigione ma poi, scagionato aiutò nelle indagini il brigadiere;
Capotreno e altri due uomini: complici del commissario;
Medici; fotografi; giornalista; agenti della scientifica; procuratore della Repubblica:
- Spazio: la vicenda si svolge sia in spazi chiusi, come il villino, che in spazi aperti come la ferrovia. Si svolge nel paese di Monterosso e principalmente nella contrada Cotugno, dal bivio per Monterosso, strada a destra, quattro chilometri. I luoghi sono abbastanza importanti.
- Tempo: La vicenda inizia alle 9.37 della sera del 18 marzo, sabato. La vicenda si inserisce nell’arco di tempo di pochi giorni. Prevalgono le scene ma ci sono molte descrizioni che fermano la vicenda.
- Stile: L’autore usa un linguaggio semplice, privo di dialetti e lingue straniere. Il registro è colloquiale.
- Tecniche di presentazione delle parole e dei pensieri dei personaggi: Prevale il discorso indiretto.
- Narratore: il narratore è esterno ed è onnisciente anche se pur sapendo non ci rivela subito tutti i segreti.
- Tematiche: Il testo può far pensare che al giorno d’oggi vogliamo arrivare sempre ad una soluzione, anche se non siamo sicuri che sia quella corretta. Il questore, infatti, senza considerate tutte le prove è deciso sul fatto che si tratta di un suicidio. Si può riflettere anche sul comportamento della moglie di Roccella che se ne frega della morte dell’ex marito e pensa soltanto a quel che gli spetta in eredità anche se poi scoprirà che tutto è stato lasciato al figlio.
Infine bisogna pensare che l’omicidio non può risolvere niente. Il commissario usa l’omicidio contro Roccella che aveva scoperto qualcosa e poi tanta anche di uccidere il brigadiere che aveva capito chi era l’assassino.
- Commento: questo libro giallo mi è piaciuto perché essendo breve ti porta subito alla fine della vicenda, cioè in poco tempo riesci ad arrivare alla conclusione del caso.