
3. Nascere e crescere in un mondo in crisi: ripartiamo dalle basi del pensiero di …
21 Giugno 2017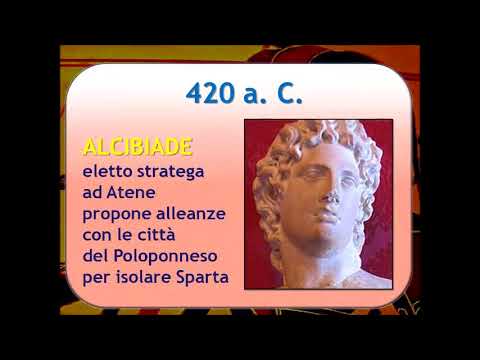
Imparare da Tucidide: “La Guerra del Peloponneso” (o “StorieR…
21 Giugno 2017
Oggi propongo un altro percorso di lettura e riflessione, che può in
realtà aprire le porte alle varie tematiche che questo Dialogo platonico
abbraccia – per esempio il tema dell’omofilia, tradotto anche come
omosessualità, lì dove però Platone non si ferma al piano sessuale di una
relazione tra amanti dello stesso sesso; oppure il tema del simposio e del suo
ruolo culturale in una Grecia antica priva di televisione, con qualche
costosissimo rotolo di papiro da leggere in privato, ma soprattutto portata
alla vita sociale tra pari dello stesso sesso. Io mi sento ormai personalmente
affascinata soprattutto la riflessione sulla distinzione tra desiderio inteso
come desiderio di migliorarsi, completarsi, e mera brama per le cose che non si
hanno ma che si vogliono in nostro possesso (essere o volere… 😉 );
interessante l’aspetto della nostalgia di ciò che manca ed a cui si anela come
stimolo creativo; un po’ meno, ormai, per quel che mi riguarda, il discorso del
desiderio dell’altra metà, ma le fasi della vita sono diverse e varie,
sicuramente qualche anno fa questa tematica aveva un’altra valenza anche per
me, oggi la ha per mio figlio. Ciò non toglie che il mito dell’androgino sia
bellissimo e meritevole di essere ascoltato (il prof. Cicero, nel primo link,
lo leggerà).
realtà aprire le porte alle varie tematiche che questo Dialogo platonico
abbraccia – per esempio il tema dell’omofilia, tradotto anche come
omosessualità, lì dove però Platone non si ferma al piano sessuale di una
relazione tra amanti dello stesso sesso; oppure il tema del simposio e del suo
ruolo culturale in una Grecia antica priva di televisione, con qualche
costosissimo rotolo di papiro da leggere in privato, ma soprattutto portata
alla vita sociale tra pari dello stesso sesso. Io mi sento ormai personalmente
affascinata soprattutto la riflessione sulla distinzione tra desiderio inteso
come desiderio di migliorarsi, completarsi, e mera brama per le cose che non si
hanno ma che si vogliono in nostro possesso (essere o volere… 😉 );
interessante l’aspetto della nostalgia di ciò che manca ed a cui si anela come
stimolo creativo; un po’ meno, ormai, per quel che mi riguarda, il discorso del
desiderio dell’altra metà, ma le fasi della vita sono diverse e varie,
sicuramente qualche anno fa questa tematica aveva un’altra valenza anche per
me, oggi la ha per mio figlio. Ciò non toglie che il mito dell’androgino sia
bellissimo e meritevole di essere ascoltato (il prof. Cicero, nel primo link,
lo leggerà).
Qui però non desidero parlare io, ma introdurre la mia proposta nello
stile dell’ultimo post, lasciando posto alle parole di altri. Quindi, segnalo:
stile dell’ultimo post, lasciando posto alle parole di altri. Quindi, segnalo:
1) come introduzione all’opera in generale, una presentazione del testo
del mancato Prof. Giovanni Reale, sui cui testi molti di noi si saranno trovati
a preparare qualche esame di Filosofia antica. Il Professore era/è uno stimato
esponente dell’interpretazione “metafisica” di Platone, della sua
Dottrina delle Idee e della “dottrina non scritta”, uno dei percorsi
che, tempo permettendo, avrei in mente di proporre qui. Al di là di questa
linea interpretativa più o meno condivisibile, il Prof. Reale rimane uno
studioso del pensiero platonico da ascoltare. Accanto alla sua esposizione, ci
sono le belle letture espressive di due parti dell’opera che aiuteranno
senz’altro ad incuriosirsi sul testo platonico:
del mancato Prof. Giovanni Reale, sui cui testi molti di noi si saranno trovati
a preparare qualche esame di Filosofia antica. Il Professore era/è uno stimato
esponente dell’interpretazione “metafisica” di Platone, della sua
Dottrina delle Idee e della “dottrina non scritta”, uno dei percorsi
che, tempo permettendo, avrei in mente di proporre qui. Al di là di questa
linea interpretativa più o meno condivisibile, il Prof. Reale rimane uno
studioso del pensiero platonico da ascoltare. Accanto alla sua esposizione, ci
sono le belle letture espressive di due parti dell’opera che aiuteranno
senz’altro ad incuriosirsi sul testo platonico:
2) Nel 1989, il regista Marco Ferreri ha tratto da questo Dialogo il suo
film “Il Banchetto di Platone”, che la Rai ha anche trasmesso, ma di
cui io trovo lo streaming solo in links che si presentano come dubbi e che non
me la sento di segnalare (fate pure una ricerca autonoma). Per avere un’idea,
indico il link di YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=uhYWihYWk0E)
del dialogo tra la sacerdotessa Diotima e Socrate, che poi sarebbe quello
avvolto da un’atmosfera mitica, bellissimo, che il Prof. Reale dice di aver
voluto far leggere, ma che era troppo lungo.
film “Il Banchetto di Platone”, che la Rai ha anche trasmesso, ma di
cui io trovo lo streaming solo in links che si presentano come dubbi e che non
me la sento di segnalare (fate pure una ricerca autonoma). Per avere un’idea,
indico il link di YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=uhYWihYWk0E)
del dialogo tra la sacerdotessa Diotima e Socrate, che poi sarebbe quello
avvolto da un’atmosfera mitica, bellissimo, che il Prof. Reale dice di aver
voluto far leggere, ma che era troppo lungo.
3) aggiungo qui il contributo del Prof. Galimberti, di cui apprezzo
moltissimo alcune idee ed associazioni, nonché la preparazione culturale, ma
che mi lascia personalmente sempre un po’ perplessa e diffidente. In ogni caso
stimolante, segnalo qui la sua interpretazione: https://www.youtube.com/watch?v=3_c1BcSGW3o&t=2572s
moltissimo alcune idee ed associazioni, nonché la preparazione culturale, ma
che mi lascia personalmente sempre un po’ perplessa e diffidente. In ogni caso
stimolante, segnalo qui la sua interpretazione: https://www.youtube.com/watch?v=3_c1BcSGW3o&t=2572s
4) Per chi volesse avvicinarsi a questo punto alla scoperta ed alla lettura diretta del testo platonico, ecco qui il Dialogo online: http://www.libreriafilosofica.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/12/platone_simposio_pdf.pdf
Cristina Rocchetto

