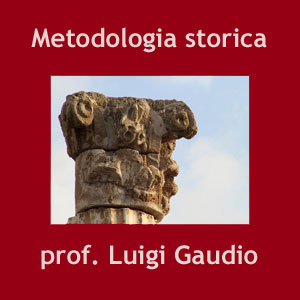
La Storia: una scienza complessa e indispensabile
6 Giugno 2025
Scuola e nuove tecnologie
6 Giugno 2025Traccia svolta di un tema argomentativo sull’invadenza del web
ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE PRIMA PROVA SCRITTA – PROVA DI ITALIANO – Sessione Straordinaria 2019
TRACCIA TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO
PROPOSTA B3
Testo tratto da:
Teresa Numerico – Domenico Fiormonte – Francesca Tomasi, L’umanista digitale, il Mulino, Bologna 2010, pp. 60-62
In questo libro gli autori, esperti di scienza della comunicazione, di sociologia della comunicazione digitale e di informatica umanistica, affrontano la questione delle trasformazioni del web e delle loro conseguenze.
Testo
«Come Tim Berners-Lee ama ripetere, il web non è qualcosa di compiuto: è uno strumento costantemente in evoluzione che deve essere riprogettato periodicamente per rimanere sempre al servizio dell’umanità. Sul tema del servizio all’umanità le cose sono piuttosto complesse. Non è sempre chiaro se e in che senso la tecnologia possa restare al servizio dell’umanità intera, o invece porsi al servizio di una parte di essa, di solito la più ricca, la più efficiente e la più organizzata da un certo punto di vista cognitivo, come aveva acutamente avvisato Wiener ormai circa sessant’anni fa. A questo punto vorrei abbandonare la storia e osservare il presente, con l’obiettivo di fare qualche previsione su che cosa accadrà nel prossimo futuro.
Innanzitutto è necessario dire qualche parola sul web 2.0, una fortunata etichetta inventata per ragioni di marketing da Tim O’Reilly [2005], che chiamò così un ciclo di conferenze organizzate dalla sua casa editrice nel 2004 e che ha ottenuto un successo mediatico senza precedenti. Scorrazzando per le applicazioni web, non ce n’è una che non possa essere ricompresa nell’alveo del web 2.0. Qual era l’obiettivo del nuovo titolo da dare al web? Rianimare il settore colpito dal crollo delle dot com all’inizio del secolo che stentava a riprendersi dopo lo scoppio irrimediabile della bolla speculativa cresciuta intorno alle aspirazioni e alle velleità delle aziende di servizi web. Così O’Reilly si lasciava il passato alle spalle e rilanciava le imprese web da una nuova prospettiva. Se cerchiamo di rintracciare il filo del suo discorso con l’aiuto di un importante studioso italiano di web e politica, Carlo Formenti, ci troviamo in presenza di uno spettacolo alquanto diverso dagli obiettivi del primo web. Diciamo che siamo di fronte a una specie di caricatura.
Gli obiettivi del web 2.0 si possono sintetizzare così: puntare sull’offerta di servizi e non di software, considerare il web un’architettura di partecipazione, elaborare strategie per lo sfruttamento dell’intelligenza collettiva, con particolare riguardo alle opportunità dei remix di servizi riorganizzati in modi nuovi. Interrogato sull’argomento nel 2006, l’inventore del web affermò che si trattava sostanzialmente di un termine gergale e che oltre a wiki e blog (al centro dell’interesse web 2.0 dell’epoca) esistevano molti altri modi per le persone di collaborare e condividere contenuti [Berners-Lee 2006]. Quindi nihil novi sub sole. Del resto il carattere strumentale del web 2.0 e i suoi fini commerciali sono assolutamente trasparenti nel progetto di O’Reilly. Si tratta di usare il contenuto prodotto dagli utenti (user generated content) in diverse forme¹, e organizzarlo in maniere appetibili per il mercato pubblicitario e per altri modelli di business a esso affini. In sintesi il bene comune rappresentato dal contenuto digitale messo al servizio di business privati. Una sorta di capitalismo 2.0 dove chi possiede la piattaforma dove condividere le informazioni con amici o postare video e foto non deve neanche preoccuparsi di pagare i contenuti e può vendere la pubblicità sull’attenzione generata da questi contenuti collettivi, allargando oltretutto la platea degli investitori: online, infatti, è possibile vendere e comprare anche piccole quantità di spazi pubblicitari, permettendo così anche a piccoli inserzionisti di avere il proprio piccolo posto al sole.
Altro che scomparsa degli intermediari². L’etichetta web 2.0 segnala, dunque, la comparsa di nuovi mediatori di un tipo più sofisticato che guadagnano per il solo fatto di trovarsi in una certa posizione di organizzatori dei contenuti collettivi. Tutto questo avveniva con buona pace della protezione dei dati personali e del riconoscimento della figura dei produttori di contenuti. Ci avviciniamo a un’era che lo studioso critico del web Geert Lovink [2007] ha definito a «commenti zero», nella quale cioè chi scrive in rete di solito non raggiunge una posizione di visibilità e riconoscimento tale da consentirgli di acquisire lo status di autore. Il web 2.0 è considerato il regno dell’amatorialità. Non ci sono professionisti e, quando lo sono, essi vengono trattati come se non lo fossero (non pagati per le loro prestazioni), in una sterile celebrazione dell’intelligenza delle folle che diventa solo un pretesto per una nuova leva di business web, disinteressata a costruire meccanismi di finanziamento della produzione intellettuale. C’è di che riflettere per l’umanista digitale e di che lavorare a lungo.»
Note:
¹ Alcuni esempi di servizi basati sui contenuti generati dagli utenti: social networking (Facebook, MySpace), microblogging (Twitter), social bookmarking (Delicious), programmi per la condivisione di foto (Flickr) e video (YouTube).
² Uno dei topoi interpretativi alle origini del www era che sarebbero scomparse tutte le forme di mediazione, permettendo ai cittadini del web di accedere direttamente e immediatamente ai contenuti.
COMPRENSIONE E ANALISI
- Qual è il tema principale sviluppato nel testo? Sintetizzane i contenuti, mettendo in evidenza i principali snodi concettuali.
- In base al testo proposto, in cosa consiste il web 2.0? Da chi e con quali obiettivi è stato lanciato?
- Nel primo capoverso cosa si afferma del web?
- Per gli autori in cosa consistono i fini commerciali «assolutamente trasparenti» del web 2.0?
- «C’è di che riflettere per l’umanista digitale e di che lavorare a lungo» (righe 39-40): spiega la conclusione del testo, riconducendola a ciò che gli autori affermano sull’amatorialità e sull’autorialità dei contenuti nel web 2.0.
PRODUZIONE
Elabora un testo argomentativo sui temi trattati da Numerico, Fiormonte e Tomasi, in particolare su ciò che affermano a proposito dello sfruttamento dell’intelligenza collettiva nel web 2.0.
Arricchisci il tuo elaborato con riferimenti pertinenti, tratti sia dalle tue conoscenze sia dalle tue esperienze dirette o indirette del web e dei servizi basati sui contenuti generati dagli utenti.
Sessione straordinaria 2019 Prima prova scritta
___________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.

SVOLGIMENTO
🔍 ‘L’umanista digitale’ di Numerico, Fiormonte e Tomasi
Il testo di Teresa Numerico, Domenico Fiormonte e Francesca Tomasi, L’umanista digitale, offre una disamina critica delle trasformazioni del web, concentrandosi in particolare sull’avvento del Web 2.0 e sulle sue implicazioni, soprattutto in relazione alla nozione di “servizio all’umanità” e allo sfruttamento dell’intelligenza collettiva. Gli autori, esperti nel campo della comunicazione digitale e dell’informatica umanistica, mettono in luce le complesse dinamiche economiche e sociali che sottostanno all’evoluzione della rete.
Comprensione e Analisi
1. Qual è il tema principale sviluppato nel testo? Sintetizzane i contenuti, mettendo in evidenza i principali snodi concettuali.
Il tema principale sviluppato nel testo è la critica alla natura e alle finalità del Web 2.0, in particolare riguardo alla presunta neutralità e al servizio all’umanità promesso dal web fin dalle sue origini. Gli autori argomentano che, nonostante le dichiarazioni di intenti, il Web 2.0 ha di fatto deviato verso un modello di business che sfrutta l’intelligenza collettiva e i contenuti generati dagli utenti (UGC) a fini prevalentemente commerciali e pubblicitari, mascherando dietro l’etichetta di “partecipazione” una nuova forma di capitalismo.
I principali snodi concettuali sono:
- La complessità del “servizio all’umanità” (righe 1-5): Gli autori partono dall’affermazione di Tim Berners-Lee secondo cui il web è uno strumento in continua evoluzione al servizio dell’umanità, ma problematizzano immediatamente questa visione, suggerendo che la tecnologia possa porsi al servizio di una parte specifica della società (la più ricca, efficiente e organizzata cognitivamente), come già avvertito da Wiener.
- Il Web 2.0 come etichetta di marketing (righe 8-16): Viene sottolineato che il termine “Web 2.0” è stato coniato per ragioni di marketing da Tim O’Reilly per rilanciare il settore internet dopo il crollo delle dot-com. Nonostante il successo mediatico, gli autori, supportati da Carlo Formenti, lo considerano una “caricatura” degli obiettivi originali del web.
- Gli obiettivi del Web 2.0 e la critica di Berners-Lee (righe 17-22): Gli obiettivi dichiarati sono l’offerta di servizi, l’architettura di partecipazione e lo sfruttamento dell’intelligenza collettiva. Tuttavia, lo stesso Berners-Lee ha minimizzato il termine come “gergale”, evidenziando che la collaborazione esisteva già in molte altre forme.
- La trasparenza dei fini commerciali (righe 22-33): Gli autori rivelano che il carattere strumentale e commerciale del Web 2.0 è palese nel progetto di O’Reilly: usare i contenuti prodotti dagli utenti per generare business privati attraverso la pubblicità. Questo è definito un “capitalismo 2.0” che sfrutta l’attenzione degli utenti, con i proprietari delle piattaforme che non pagano i contenuti e guadagnano dalla pubblicità. Viene inoltre evidenziata la comparsa di “nuovi mediatori” (le piattaforme stesse) che guadagnano dalla loro posizione di organizzatori di contenuti, smentendo l’idea originale della “scomparsa degli intermediari”.
- Amatorialità e “commenti zero” (righe 34-40): Il Web 2.0 è descritto come il “regno dell’amatorialità”, dove i produttori di contenuti (UGC) non raggiungono visibilità o riconoscimento come autori, e se professionisti, non vengono pagati. Questa “sterile celebrazione dell’intelligenza delle folle” serve da pretesto per nuovi business, disinteressati a finanziare la produzione intellettuale.
2. In base al testo proposto, in cosa consiste il web 2.0? Da chi e con quali obiettivi è stato lanciato?
In base al testo, il Web 2.0 non è tanto una rivoluzione tecnologica, quanto una “fortunata etichetta inventata per ragioni di marketing” (r. 8). È stato lanciato da Tim O’Reilly nel 2005 (ma la conferenza che gli diede il nome fu nel 2004) con l’obiettivo principale di rianimare il settore tecnologico dopo il crollo delle dot-com, rilanciando le imprese web da una nuova prospettiva per superare la bolla speculativa.
Gli obiettivi operativi del Web 2.0, come sintetizzati dagli autori, consistono nel:
- Puntare sull’offerta di servizi piuttosto che di software.
- Considerare il web un’architettura di partecipazione.
- Elaborare strategie per lo sfruttamento dell’intelligenza collettiva.
- Dare particolare riguardo alle opportunità dei remix di servizi riorganizzati in modi nuovi.
In sintesi, il Web 2.0 è stata una strategia commerciale per monetizzare la partecipazione e la produzione di contenuti da parte degli utenti.
3. Nel primo capoverso cosa si afferma del web?
Nel primo capoverso, si afferma che il web è uno strumento costantemente in evoluzione che deve essere riprogettato periodicamente per rimanere sempre al servizio dell’umanità (righe 1-2). Tuttavia, gli autori problematizzano immediatamente questa visione, sottolineando che “sul tema del servizio all’umanità le cose sono piuttosto complesse” (r. 3). Viene sollevato il dubbio se la tecnologia possa effettivamente servire l’umanità intera, o piuttosto solo una parte di essa, solitamente la “più ricca, la più efficiente e la più organizzata da un certo punto di vista cognitivo” (righe 4-5), come già avvertito da Wiener sessant’anni prima. Questo capoverso introduce la tesi critica degli autori sulla neutralità e sulle reali finalità del web.
4. Per gli autori in cosa consistono i fini commerciali «assolutamente trasparenti» del web 2.0?
Per gli autori, i fini commerciali “assolutamente trasparenti” del Web 2.0 consistono fondamentalmente nell’uso del contenuto prodotto dagli utenti (User Generated Content – UGC) per generare profitto privato attraverso la pubblicità e altri modelli di business affini.
Questo modello, che definiscono “capitalismo 2.0”, funziona così:
- Le piattaforme (come i social network, i siti di condivisione video/foto) ottengono i contenuti dagli utenti senza doverli pagare (r. 27).
- Queste piattaforme vendono spazi pubblicitari basandosi sull’attenzione e l’engagement generati da tali contenuti collettivi (r. 27-28).
- Il modello permette di allargare la platea degli investitori pubblicitari, includendo anche i piccoli inserzionisti grazie alla possibilità di comprare piccole quantità di spazi online (righe 29-30).
In sintesi, il “bene comune rappresentato dal contenuto digitale” (r. 25), ovvero l’intelligenza collettiva e la creatività degli utenti, viene messo “al servizio di business privati” (r. 26) attraverso un meccanismo di monetizzazione dell’attenzione e dei dati degli utenti stessi. Viene inoltre evidenziato come ciò comporti la comparsa di “nuovi mediatori” (le piattaforme) che guadagnano per il solo fatto di organizzare questi contenuti, smentendo l’idea iniziale della scomparsa degli intermediari.
5. «C’è di che riflettere per l’umanista digitale e di che lavorare a lungo» (righe 39-40): spiega la conclusione del testo, riconducendola a ciò che gli autori affermano sull’amatorialità e sull’autorialità dei contenuti nel web 2.0.
La conclusione del testo, “C’è di che riflettere per l’umanista digitale e di che lavorare a lungo”, è un appello all’azione e alla critica, direttamente collegato alle affermazioni degli autori sull’amatorialità e l’autorialità dei contenuti nel Web 2.0.
Gli autori definiscono il Web 2.0 il “regno dell’amatorialità” (r. 36). Ciò significa che la stragrande maggioranza dei contenuti (UGC) è prodotta da non professionisti, da utenti che non vengono remunerati per il loro lavoro creativo. Anche quando i contenuti sono prodotti da professionisti, essi “vengono trattati come se non lo fossero (non pagati per le loro prestazioni)” (r. 37-38). Questa “sterile celebrazione dell’intelligenza delle folle” diventa un pretesto per un nuovo modello di business che è “disinteressato a costruire meccanismi di finanziamento della produzione intellettuale” (r. 39).
In questo contesto, la questione dell’autorialità diventa critica. Il testo suggerisce che ci si avvicina a un’era di “commenti zero” (r. 35), dove chi scrive in rete “di solito non raggiunge una posizione di visibilità e riconoscimento tale da consentirgli di acquisire lo status di autore” (r. 35-36). La produzione di contenuti diventa una forma di lavoro non riconosciuto e non retribuito, funzionale solo agli interessi commerciali delle piattaforme.
Pertanto, “c’è di che riflettere e lavorare a lungo per l’umanista digitale” perché:
- Riflessione critica: L’umanista digitale deve analizzare e comprendere le implicazioni etiche, sociali ed economiche di questo modello. Deve interrogarsi su come la “partecipazione” degli utenti sia in realtà uno sfruttamento e come la “collaborazione” si traduca in profitto per pochi.
- Lavoro per il futuro: L’umanista digitale ha il compito di proporre e costruire modelli alternativi che possano garantire una maggiore protezione dei dati personali, un riconoscimento dell’autorialità e, soprattutto, meccanismi di finanziamento che valorizzino la produzione intellettuale e artistica degli utenti, affinché il web torni a essere uno strumento al servizio dell’umanità intera, e non solo della sua parte più efficiente e organizzata commercialmente. È un invito a sviluppare un web più equo e consapevole.
Produzione
L’Intelligenza Collettiva Sfruttata: Il Paradosso del Web 2.0
Il saggio L’umanista digitale di Numerico, Fiormonte e Tomasi offre una prospettiva illuminante e, per certi versi, scomoda sulle trasformazioni del web, concentrandosi in particolare sull’avvento del Web 2.0 e sulla presunta “intelligenza collettiva” che lo anima. L’argomentazione degli autori, secondo cui lo sfruttamento di questa intelligenza è diventato il fulcro di un “capitalismo 2.0” a esclusivo vantaggio delle piattaforme, è una tesi che condivido pienamente. La mia esperienza diretta e indiretta del web, osservando le dinamiche delle piattaforme e il comportamento degli utenti, conferma la profonda verità di questa critica.
Il concetto di “intelligenza collettiva”, spesso celebrato come la grande promessa del Web 2.0, è stato in origine associato a una visione quasi utopica di condivisione democratica del sapere e della creazione. L’idea che milioni di utenti potessero collaborare, produrre contenuti, e auto-organizzarsi, sembrava prefigurare un’era di partecipazione diffusa e di eliminazione degli intermediari. Blog, wiki, piattaforme di condivisione di foto e video come Flickr e YouTube (citati dagli autori) hanno rappresentato per anni l’emblema di questa rivoluzione, dove la “folla” generava valore. Si è assistito a fenomeni straordinari di crowdsourcing e di creazione di conoscenza condivisa, dalla stessa Wikipedia allo sviluppo di software open source. Il potenziale democratico e creativo era, e in parte rimane, innegabile.
Tuttavia, come acutamente rilevano Numerico, Fiormonte e Tomasi, dietro questa facciata di partecipazione si è celato un modello di business astuto e, per certi versi, predatorio. Il Web 2.0 ha trasformato l’attività degli utenti in una vera e propria materia prima gratuita. Le piattaforme non pagano i contenuti che gli utenti creano, né retribuiscono il tempo e l’attenzione che essi dedicano alla produzione e fruizione di tali contenuti. Al contrario, monetizzano l’aggregazione di questi “dati” e l’attenzione generata, vendendo spazi pubblicitari a un mercato sempre più ampio. Questo è il cuore del “capitalismo 2.0”: un sistema in cui il valore è generato gratuitamente dagli utenti e appropriato dalle piattaforme che possiedono l’infrastruttura e gli algoritmi.
La mia esperienza quotidiana con i social media ne è una prova costante. Pubblico foto su Instagram, scrivo commenti su Facebook, guardo video su YouTube. Questi atti, apparentemente innocui e spontanei, contribuiscono tutti ad alimentare un gigantesco motore di business. Le mie preferenze, i miei interessi, le mie interazioni diventano dati profilati, trasformati in un prodotto che viene offerto agli inserzionisti. Non ricevo alcuna remunerazione per i contenuti che creo e che generano engagement; anzi, la “visibilità” è spesso l’unica moneta di scambio. Se volessi monetizzare un mio contenuto, dovrei sottostare alle regole della piattaforma, spesso ricevendo una percentuale minima rispetto al valore generato. Questo rende gli utenti non solo “produttori” non retribuiti, ma anche “lavoratori invisibili” di una vasta macchina economica.
La critica degli autori si estende alla questione dell’autorialità e dell’amatorialità. Il Web 2.0, pur celebrando l’intelligenza delle folle, tende a negare il riconoscimento dello status di “autore” a chi produce contenuti. I “commenti zero”, le infinite condivisioni senza un’attribuzione chiara, la prevalenza dell’anonimato o dello pseudonimo, erodono il concetto di proprietà intellettuale e di identità autoriale. Ciò si traduce in una “sterile celebrazione dell’intelligenza delle folle” che serve a giustificare un modello di business in cui “non ci sono professionisti e, quando lo sono, essi vengono trattati come se non lo fossero (non pagati per le loro prestazioni)”. Questo è particolarmente evidente in settori come il giornalismo o la fotografia, dove contenuti di qualità professionale vengono spesso riutilizzati o diffusi gratuitamente, minando il valore del lavoro intellettuale.
Inoltre, il testo mette in luce un aspetto cruciale: la ricomparsa e la sofisticazione degli “intermediari”. Laddove si sbandierava la “scomparsa degli intermediari” a favore di un accesso diretto ai contenuti, il Web 2.0 ha visto l’ascesa di nuove e potentissime figure: le stesse piattaforme. Google, Facebook, YouTube non sono semplici canali, ma veri e propri gatekeeper, che decidono cosa è visibile, come viene indicizzato, e quali informazioni raggiungono l’utente. Guadagnano non solo dalla pubblicità, ma anche dalla loro “posizione di organizzatori dei contenuti collettivi”, esercitando un potere enorme sulla circolazione dell’informazione e sulla formazione dell’opinione pubblica.
In conclusione, la riflessione di Numerico, Fiormonte e Tomasi è un monito fondamentale per l’umanista digitale e per la società intera. Il Web 2.0, pur avendo aperto nuove frontiere di comunicazione e partecipazione, ha celato sotto la retorica della “condivisione” un modello di sfruttamento dell’intelligenza collettiva che pone serie domande etiche ed economiche. È imperativo “riflettere e lavorare a lungo” per sviluppare modelli alternativi che garantiscano una maggiore equità, che riconoscano il valore del lavoro intellettuale degli utenti e che assicurino che la tecnologia rimanga al servizio dell’umanità intera, e non solo di pochi giganti digitali. Solo così potremo trasformare l’attuale “capitalismo 2.0” in un ecosistema digitale più giusto e sostenibile, dove la creatività e la conoscenza siano celebrate e remunerate, piuttosto che semplicemente sfruttate.
Appunti e approfondimenti su Adorno, Horkeimer e Marcuse della Scuola di Francoforte su questo sito atuttascuola©
- Theodor Wiesengrund Adorno: Un Pensatore Critico del Novecento di atuttascuola©
-
Theodor Wiesengrund Adorno: A Critical Thinker of the Twentieth Century di atuttascuola©
-
Dialettica dell’illuminismo di Adorno e Horkheimer di atuttascuola©
-
La critica alla modernità nel pensiero di Adorno e Horkheimer di atuttascuola©
-
Max Horkheimer: il pensatore che ha sfidato la modernità di atuttascuola©
-
Max Horkheimer, il padre della Scuola di Francoforte di atuttascuola©
-
Herbert Marcuse di atuttascuola©
-
Erich Fromm, psicoanalista dell’uomo moderno di atuttascuola©
-
Erich Fromm: avere o essere? di atuttascuola©
-
La Scuola di Francoforte: origini, filosofia e critiche di atuttascuola©
-
Tesina sulle Masse di atuttascuola©
-
Tesina sul Sessantotto di atuttascuola©
Appunti e approfondimenti su altri siti
-
Adorno di Diego Fusaro
-
Adorno da riflessioni.it
-
Horkheimer di Diego Fusaro
-
Marcuse di Diego Fusaro
Audio Lezioni, ascolta il podcast di Filosofia del prof. Gaudio
Ascolta “Filosofia” su Spreaker.




