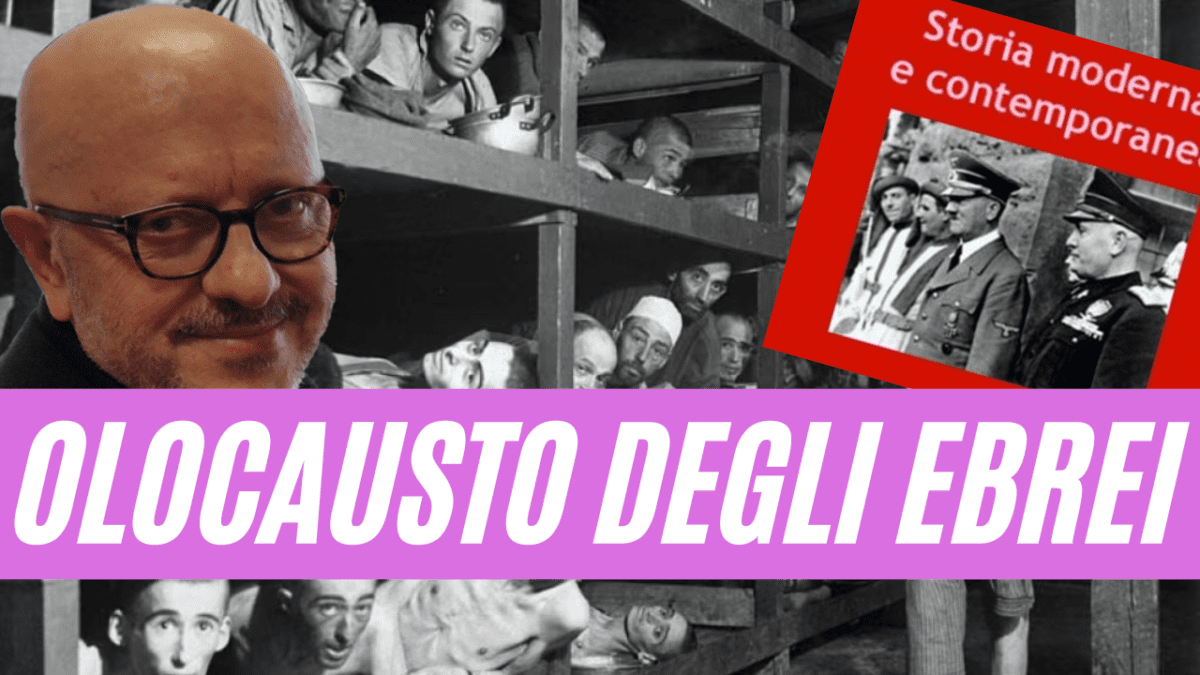Musicologia: il potere della musica
8 Giugno 2025
Cambiamento climatico ed esaurimento delle risorse energetiche
9 Giugno 2025Traccia e svolgimento di un Tema argomentativo sulla persecuzione degli Ebrei nel corso della seconda guerra mondiale
TRACCIA
ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE PRIMA PROVA SCRITTA – PROVA DI ITALIANO – Sessione Ordinaria 2022
TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO
PROPOSTA B1
Testo tratto da: Gherardo Colombo, Liliana Segre, La sola colpa di essere nati, Garzanti, Milano, 2021, pp. 25-27.
Testo:
«Quando, per effetto delle leggi razziali, fui espulsa dalla scuola statale di via Ruffini, i miei pensarono di iscrivermi a una scuola ebraica non sapendo più da che parte voltarsi. Alla fine decisero di mandarmi a una scuola cattolica, quella delle Marcelline di piazza Tommaseo, dove mi sono trovata molto bene, perché le suore erano premurose e accudenti. Una volta sfollati a Inverigo, invece, studiavo con una signora che veniva a darmi lezioni a casa.
L’espulsione la trovai innanzitutto una cosa assurda, oltre che di una gravità enorme! Immaginate un bambino che non ha fatto niente, uno studente qualunque, mediocre come me, nel senso che non ero né brava né incapace; ero semplicemente una bambina che andava a scuola molto volentieri perché mi piaceva stare in compagnia, proprio come mi piace adesso. E da un giorno all’altro ti dicono: «Sei stata espulsa!». È qualcosa che ti resta dentro per sempre. «Perché?» domandavo, e nessuno mi sapeva dare una risposta. Ai miei «Perché?» la famiglia scoppiava a piangere, chi si soffiava il naso, chi faceva finta di dover uscire dalla stanza. Insomma, non si affrontava l’argomento, lo si evitava. E io mi caricavo di sensi di colpa e di domande: «Ma cosa avrò fatto di male per non poter più andare a scuola? Qual è la mia colpa?». Non me ne capacitavo, non riuscivo a trovare una spiegazione, per quanto illogica, all’esclusione. Sta di fatto che a un tratto mi sono ritrovata in un mondo in cui non potevo andare a scuola, e in cui contemporaneamente succedeva che i poliziotti cominciassero a presentarsi e a entrare in casa mia con un atteggiamento per nulla gentile. E anche per questo non riuscivo a trovare una ragione.
Insieme all’espulsione da scuola, ricordo l’improvviso silenzio del telefono. Anche quello è da considerare molto grave. Io avevo una passione per il telefono, passione che non ho mai perduto. Non appena squillava correvo nel lungo corridoio dalla mia camera di allora per andare a rispondere. A un tratto ha smesso di suonare. E quando lo faceva, se non erano le rare voci di parenti o amici con cui conservavamo una certa intimità, ho addirittura incominciato a sentire che dall’altro capo del filo mi venivano indirizzate minacce: «Muori!», «Perché non muori?», «Vattene!» mi dicevano. Erano telefonate anonime, naturalmente. Dopo tre o quattro volte, ho riferito la cosa a mio papà: «Al telefono qualcuno mi ha detto “Muori!”». Da allora mi venne proibito di rispondere. Quelli che ci rimasero vicini furono davvero pochissimi. Da allora riservo sempre grande considerazione agli amici veri, a quelli che in disgrazia non ti abbandonano. Perché i veri amici sono quelli che ti restano accanto nelle difficoltà, non gli altri che magari ti hanno riempito di regali e di lodi, ma che in effetti hanno approfittato della tua ospitalità. C’erano quelli che prima delle leggi razziali mi dicevano: «Più bella di te non c’è nessuno!». Poi, dopo la guerra, li rincontravo e mi dicevano: «Ma dove sei finita? Che fine hai fatto? Perché non ti sei fatta più sentire?». Se uno è sulla cresta dell’onda, di amici ne ha quanti ne vuole. Quando invece le cose vanno male le persone non ti guardano più. Perché certo, fa male alzare la cornetta del telefono e sentirsi dire «Muori!» da un anonimo. Ma quanto è doloroso scoprire a mano a mano tutti quelli che, anche senza nascondersi, non ti vedono più. È proprio come in quel terribile gioco tra bambini, in cui si decide, senza dirglielo, che uno di loro è invisibile. L’ho sempre trovato uno dei giochi più crudeli. Di solito lo si fa con il bambino più piccolo: il gruppo decide che non lo vede più, e lui inizia a piangere gridando: «Ma io sono qui!». Ecco, è quello che è successo a noi, ciascuno di noi era il bambino invisibile.»
Testo tratto da: Gherardo Colombo, Liliana Segre, La sola colpa di essere nati, Garzanti, Milano, 2021, pp. 25-27.
Comprensione e Analisi
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte a tutte le domande proposte.
- Riassumi il contenuto del brano senza ricorrere al discorso diretto.
- Perché Liliana Segre considera assurda e grave la sua espulsione dalla scuola?
- Liliana Segre paragona l’esperienza determinata dalle leggi razziali con il gioco infantile del “bambino invisibile”: per quale motivo utilizza tale similitudine?
- Nell’evocare i propri ricordi la senatrice allude anche ai sensi di colpa da lei provati rispetto alla situazione che stava vivendo: a tuo parere, qual era la loro origine?
Produzione
Liliana Segre espone alcune sue considerazioni personali che evidenziano il duplice aspetto della discriminazione – istituzionale e relazionale – legata alla emanazione delle “leggi razziali”; inquadra i ricordi della senatrice nel contesto storico nazionale e internazionale dell’epoca, illustrando origine, motivazioni e conseguenze delle suddette leggi. Esprimi le tue considerazioni sul fenomeno descritto nel brano anche con eventuali riferimenti ad altri contesti storici. Argomenta le tue considerazioni sulla base di quanto hai appreso nel corso dei tuoi studi ed elabora un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso.
SVOLGIMENTO
La Discriminazione: Ferite Istituzionali e Relazionali nel Ricordo di Liliana Segre
Il toccante estratto da “La sola colpa di essere nati” di Gherardo Colombo e Liliana Segre ci immerge nella drammatica esperienza di una bambina costretta a confrontarsi, all’improvviso e senza alcuna spiegazione comprensibile, con la brutalità della discriminazione. Il racconto della senatrice a vita, focalizzato sull’espulsione dalla scuola e sull’ostracismo sociale subito a causa delle leggi razziali, evidenzia in modo straziante il duplice aspetto di ogni atto discriminatorio: quello istituzionale, imposto dall’alto, e quello relazionale, che si manifesta nel silenzio, nell’abbandono e nella negazione dell’esistenza altrui. La sua testimonianza non è solo una cronaca del passato, ma un monito potente e universale, che risuona con dolorosa attualità ancora oggi.
Comprensione e Analisi
1. Sintetizza il contenuto del brano senza ricorrere al discorso diretto.
Liliana Segre narra la sua esperienza di bambina ebrea in Italia durante l’emanazione delle leggi razziali. Ricorda la sua improvvisa espulsione dalla scuola statale, a cui seguì l’iscrizione, prima a una scuola ebraica e poi a una cattolica dove si trovò bene. Successivamente, durante lo sfollamento a Inverigo, continuò a studiare a casa con lezioni private. La bambina considerò fin da subito questa esclusione un fatto assurdo e grave, poiché non ne comprendeva la ragione, non avendo compiuto nulla di sbagliato. La sua famiglia evitava di affrontare l’argomento, scoppiando in lacrime o cercando scuse per allontanarsi, il che la portava a caricarsi di sensi di colpa e interrogativi irrisolti. Parallelamente all’espulsione, rammenta l’improvviso silenzio del telefono di casa, una sua grande passione. Quando il telefono riprendeva a squillare, riceveva minacce anonime che la invitavano a morire o ad andarsene, spingendo il padre a proibirle di rispondere. Pochi amici le rimasero vicini, e la senatrice riflette sul valore degli amici veri, quelli che non abbandonano nelle difficoltà, a differenza di coloro che l’avevano lodata in passato ma che poi, senza nascondersi, smisero di riconoscerla. Ella paragona questa esperienza al crudele gioco infantile del “bambino invisibile”, dove il gruppo decide di non vedere più uno dei suoi membri, lasciandolo solo e disperato.
2. Perché Liliana Segre considera assurda e grave la sua espulsione dalla scuola?
Liliana Segre considera la sua espulsione dalla scuola assurda e grave per diversi motivi, legati alla sua prospettiva di bambina innocente e inconsapevole:
- Assenza di colpa personale: Era “uno studente qualunque, mediocre come me, nel senso che non ero né brava né incapace; ero semplicemente una bambina che andava a scuola molto volentieri perché mi piaceva stare in compagnia”. Non aveva fatto “niente” di male, non aveva commesso alcuna infrazione che potesse giustificare una simile punizione.
- Mancanza di spiegazioni: Nonostante le sue continue domande (“Perché?”), nessuno in famiglia le sapeva dare una risposta chiara. Questo silenzio e l’evitamento dell’argomento da parte degli adulti la lasciavano nell’incapacità di comprendere l’illogicità dell’esclusione.
- Impatto emotivo devastante: Essere espulsa da un ambiente che le piaceva e dove si sentiva a suo agio (“mi piaceva stare in compagnia”), e sentirsi dire “Sei stata espulsa!” da un giorno all’altro, fu un trauma che le “resta dentro per sempre”, evidenziando la profondità della ferita psicologica.
Per una bambina, l’espulsione da scuola, priva di una ragione comprensibile, equivaleva a una condanna immotivata, una totale irrazionalità che infrangeva il suo mondo di certezze.
3. Liliana Segre paragona l’esperienza determinata dalle leggi razziali con il gioco infantile del “bambino invisibile”: per quale motivo utilizza tale similitudine?
Liliana Segre utilizza la similitudine del “bambino invisibile” per descrivere l’esperienza delle leggi razziali perché essa rende perfettamente l’idea dell’ostracismo sociale e della negazione dell’esistenza che subirono gli ebrei. Nel gioco, il gruppo decide, senza dirlo, che uno dei bambini è invisibile, portandolo a piangere e a gridare la sua presenza (“Ma io sono qui!”).
Il paragone è potente perché:
- Sottolinea l’irrazionalità e la crudeltà: Come il gioco, la discriminazione razziale è una decisione arbitraria e non giustificabile, che infligge una sofferenza gratuita e senza colpa. È “uno dei giochi più crudeli” perché nega la realtà stessa dell’altro.
- Evidenzia la negazione dell’identità e dell’esistenza: Gli ebrei, da un giorno all’altro, furono trattati come se non esistessero più per la società. Non erano più visti, riconosciuti, o considerati parte della comunità. Le persone “non ti guardano più”, si comportano “come se uno di loro è invisibile”.
- Rappresenta la sofferenza silenziosa e l’impotenza della vittima: La vittima, come il bambino nel gioco, tenta disperatamente di affermare la propria presenza e la propria umanità, ma si scontra con un muro di indifferenza o di volontaria cecità. Questo genera un profondo senso di solitudine e disperazione.
La similitudine cattura l’essenza del dolore inflitto non solo dalla persecuzione fisica, ma anche dall’annientamento sociale e psicologico, trasformando la vittima in un’entità non-esistente per la società che la circonda.
4. Nell’evocare i propri ricordi la senatrice allude anche ai sensi di colpa da lei provati rispetto alla situazione che stava vivendo: a tuo parere, qual era la loro origine?
I sensi di colpa provati da Liliana Segre, a mio parere, avevano la loro origine principale nell’assoluta mancanza di spiegazioni comprensibili e nella tendenza degli adulti a evitare l’argomento. Una bambina, per natura, cerca una logica, una causa-effetto per ciò che le accade, specialmente se è un evento negativo e punitivo.
Dal testo emerge che:
- Le sue domande (“Perché?”) non trovavano risposta, o ricevevano reazioni emotive (pianto, evasione) che non fornivano alcuna chiarificazione.
- Non avendo commesso nulla di male, l’unica “ragione” che una mente infantile può elaborare per una punizione così grave è che la colpa debba risiedere in sé stessa, in qualcosa di inespresso o inconscio. Se gli adulti non spiegano, e la punizione è così severa, deve esserci una colpa nascosta.
- L’isolamento e l’abbandono da parte degli amici e della società rinforzavano questa auto-accusa. Se tutti si allontanano, pensava implicitamente la bambina, è perché io devo aver fatto qualcosa di così sbagliato da meritare questo ostracismo.
In assenza di una verità esterna e di una giustificazione razionale, la mente infantile di Liliana cercò una spiegazione interna, internalizzando il problema e generando sensi di colpa per una “colpa” inesistente, ma percepita come tale per la sua esclusione.
Produzione
Il Marchio Indelebile della Discriminazione: Una Lezione di Storia e di Umanità
La testimonianza di Liliana Segre, permeata dalla dolorosa memoria delle leggi razziali, offre una lente potente per comprendere la natura duplice della discriminazione: quella istituzionale, imposta con la forza della legge, e quella relazionale, che si insinua nelle pieghe del tessuto sociale. Inquadrare i suoi ricordi nel contesto storico nazionale e internazionale dell’epoca è essenziale per afferrare la profondità del trauma vissuto da milioni di persone, ma anche per riconoscere la persistenza di simili fenomeni, seppur con forme diverse, nella società contemporanea.
Il Contesto Storico: L’Ascesa delle Leggi Razziali
L’esperienza di Liliana Segre si colloca nel drammatico contesto delle leggi razziali emanate in Italia nel 1938. Queste norme, volute dal regime fascista di Benito Mussolini, furono un’applicazione diretta delle teorie razziali naziste e rappresentarono un’aberrazione giuridica e morale nella storia italiana. L’origine e le motivazioni di tali leggi erano profondamente radicate in un’ideologia razzista che vedeva gli ebrei come una “razza” inferiore e una minaccia alla “purezza” della razza italiana. Il Manifesto della razza, pubblicato pochi mesi prima delle leggi, fornì la giustificazione pseudo-scientifica a questa politica persecutoria. A livello internazionale, la Germania nazista aveva già intrapreso, fin dal 1933, una politica di persecuzione sistematica degli ebrei, culminata con le leggi di Norimberga del 1935, che privavano gli ebrei della cittadinanza e proibivano matrimoni misti. L’Italia fascista si allineò a questa politica, rafforzando l’asse con la Germania di Hitler.
Le conseguenze delle leggi razziali furono immediate e devastanti. Gli ebrei vennero privati dei diritti civili e politici: esclusi dalle scuole statali (come accadde a Liliana), dalle università, dagli impieghi pubblici e privati, dalle professioni (insegnanti, medici, avvocati, giornalisti), e privati del diritto di proprietà. Fu vietato loro di prestare servizio militare e di contrarre matrimoni con “ariani”. Questi provvedimenti non furono solo vessazioni simboliche, ma un’esclusione sociale e economica che minava la vita stessa degli individui e delle famiglie ebraiche, rendendoli cittadini di seconda classe, in un processo di progressiva deumanizzazione che culminò con la deportazione e lo sterminio nei campi di concentramento e sterminio nazisti, come Auschwitz, che divenne il tragico destino anche di Liliana Segre e del suo padre.
La Discriminazione Istituzionale e Relazionale nel Ricordo di Liliana Segre
Il racconto di Liliana Segre evidenzia con forza il duplice volto della discriminazione. La discriminazione istituzionale è rappresentata innanzitutto dall’espulsione dalla scuola. Un’istituzione fondamentale della vita civile, la scuola, da luogo di formazione e inclusione si trasforma in strumento di esclusione, applicando una legge che priva una bambina innocente del suo diritto all’istruzione. L’irruzione dei poliziotti in casa, con un atteggiamento “per nulla gentile”, è un’altra manifestazione della violenza del potere statale che si impone sulla vita privata, minando la sicurezza e la tranquillità domestica. Questo aspetto istituzionale è la base legale che legittima e rende possibile ogni altra forma di discriminazione.
Parallelamente, e forse con un impatto ancora più lacerante per la sensibilità di una bambina, si manifesta la discriminazione relazionale. La “improvvisa silenzio del telefono”, l’abbandono da parte di amici e conoscenti che “non ti guardano più”, e le minacce anonime ricevute, sono le ferite inferte dal tessuto sociale. Il dolore di non ricevere risposte chiare dai familiari, che piangevano o evitavano l’argomento, portò Liliana a interrogarsi sulla propria colpa, a sentirsi inspiegabilmente responsabile per una situazione che non aveva causato. Questa internalizzazione del senso di colpa è una strategia di sopravvivenza psicologica di fronte all’irrazionalità, ma è devastante per la costruzione dell’identità. Il paragone con il “bambino invisibile” è qui emblematico: l’invisibilità sociale è una forma di annientamento che nega la dignità, l’esistenza stessa della persona, trasformandola in un’ombra, un non-essere per coloro che un tempo erano vicini.
Discriminazione Ieri e Oggi: Un Fenomeno Persistente
Il fenomeno della discriminazione, purtroppo, non è confinato solo al buio periodo delle leggi razziali. La storia è costellata di esempi in cui un gruppo di individui viene privato di diritti e dignità in base a caratteristiche arbitrarie, che siano etnia, religione, genere, orientamento sessuale, disabilità, o estrazione sociale. Si pensi all’apartheid in Sudafrica, un sistema istituzionalizzato di segregazione e discriminazione razziale che per decenni ha privato la popolazione nera di ogni diritto fondamentale, confinandola in condizioni di vita subumane. O alla segregazione razziale negli Stati Uniti, dove le leggi Jim Crow imposero la separazione tra bianchi e neri in tutti gli ambiti della vita pubblica, generando violenze e ingiustizie che hanno lasciato cicatrici profonde. Anche in questi contesti, la discriminazione era sia istituzionale (leggi che negavano il voto, l’accesso a scuole e servizi) sia relazionale (il rifiuto sociale, l’umiliazione quotidiana, il disprezzo).
Ancora oggi, la discriminazione persiste, assumendo forme più sottili ma non meno dannose. Il razzismo continua a manifestarsi attraverso stereotipi, pregiudizi e atti di intolleranza. La xenofobia colpisce i migranti, spesso privati di un riconoscimento pieno della loro dignità e dei loro diritti. La discriminazione di genere e quella basata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere persistono in molti contesti sociali e professionali. Il fenomeno dell’hate speech (discorso d’odio) online, che si diffonde a macchia d’olio, riproduce in chiave digitale la logica del “bambino invisibile”, prendendo di mira e isolando individui o gruppi attraverso la negazione della loro dignità e la diffusione di minacce anonime, proprio come le telefonate subite da Liliana Segre.
La lezione di Liliana Segre ci impone una vigilanza costante. La sua esperienza ci insegna che la discriminazione non nasce solo da grandi eventi storici, ma si nutre del silenzio, dell’indifferenza e della complicità dei singoli. È compito di ciascuno di noi, come cittadini consapevoli, riconoscere e contrastare ogni forma di discriminazione, a livello istituzionale e relazionale. Dobbiamo essere “amici veri” per chi è in difficoltà, capaci di alzare la voce contro l’ingiustizia e di non girare lo sguardo quando qualcuno viene reso “invisibile”. Solo così, mantenendo viva la memoria e agendo con coraggio, potremo sperare di costruire una società più giusta, inclusiva e rispettosa della dignità di ogni individuo.