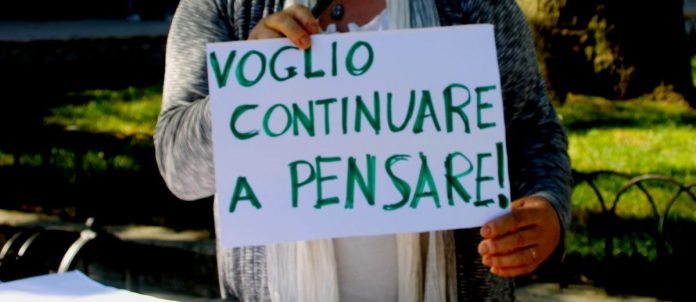Cesare Beccaria – di Carlo Zacco
6 Agosto 2015


Giuseppe Parini – di Carlo Zacco
6 Agosto 2015Gli elementi fondamentali del neoclassicismo. L’espressione artistica dell’Illuminismo prevalente nella seconda metà del Settecento è il Neoclassicismo, che si unisce a sua volta con gli ideali dell’illuminismo.
Gli elementi fondamentali:
1) l’arte deve essere ispirata dalla ragione, e rifarsi ai criteri antichi di armonia, regolarità, semplicità;
2) contemporaneamente l’arte deve essere utile alla società (elemento illuministico), ed essere impegnata in senso civile ed etico (Parini, Foscolo);
Tendenze opposte. Questa tendenza si afferma soprattutto in Francia e in Italia;
– meno in Germania e Inghilterra, dove già a fine secolo viene presto sostituita dal Romanticismo in aperta contrapposizione al
Neoclassicismo.
Neoclassicismo.
– In realtà il Neoclassicismo ha già dentro di sé alcune forze che fanno presagire il Romanticismo.
1) Il Neoclassicismo propriamente detto. L’estetica del Neoclassicismo è stata formulata intorno alla metà del secolo. I principali
teorici sono
teorici sono
– l’archeologo tedesco Johan Joachim Winkelmann;
– lo scrittore Gotthold Ephraim Lessing;
– il filosofo enciclopedista francese Diderot;
La teorizzazione dell’estetica Neoclassica parte dal concetto di imitazione della natura:
– l’arte non deve essere un’imitazione della natura, ma una sua rielaborazione da parte dell’artista, che opera una sintesi
superiore rispetto a tutte le realtà naturali (sintesi);
superiore rispetto a tutte le realtà naturali (sintesi);
– il principio ispiratore di questa sintesi deve essere l’ideale di grazia e armonia, che si rifà alla formulazione winkelmaniana di «nobile semplicità» e «quieta grandezza» (è implicita una critica al Rococò, considerato troppo frivolo e decorativo);
– in generale l’arte neoclassica diffonde un senso di malinconia e inquietudine, date dalla consapevolezza della separazione tra mondo antico e moderno: quella comunione tra uomo e natura tipica degli antichi oggi non è più possibile (Vico);
– non si dovevano soltanto imitare gli antichi, ma calare le opere nella contemporaneità, come per altro avevano fatto gli autori antichi: fare come avevano fatto loro, non fare le stesse cose che avevano fatto loro;
– in Italia era ancora viva l’esperienza dell’Arcadia, e pertanto era presente anche un neoclassicismo più disimpegnato e meno militante, ad esempio quello di Monti.
2) Le tendenze preromantiche interne al Neoclassicismo. All’interno del Neoclassicismo vi è anche una tendenza che fa già
presagire il Romanticismo. Una novità è stata la teorizzazione della categoria estetica del Sublime.
presagire il Romanticismo. Una novità è stata la teorizzazione della categoria estetica del Sublime.
– ad animare la discussione intorno al sublime è stato uno studioso inglese, Edmund Burke.
– Nel suo saggio (del 1759) Burke afferma che anche le sensazioni di terrore e sbigottimento di fronte alla morte o altre situazioni possono essere fonte di piacere estetico: questo è il concetto di sublime: ansia, paura, terrore, sbigottimento erano sensazioni legate all’idea di bello.
– nascono quindi opere d’arte che rappresentano notturni, cimiteri, sepolcri, castelli abbandonati;
3) Le tendenze anticlassicistiche. Le posizioni anticlassiche prendono piede in particolare in Inghilterra e in Germania.
a) Inghilterra. Qui una posizione anticlassica fu proposta da James Macpherson.
– Macpherson aveva scritto un’opera, spacciandola per una traduzione di canti medievali dei bardi (poeti di canti popolari del Nord) gaelici e irlandesi: i canti di Ossian (1761/62);
– l’opera fu ritenuta autentica, ed ebbe immenso successo in tutta Europa.
– nacque il mito romantico di una poesia come frutto spontaneo di una natura umana primitiva, non mediata dalla cultura e dalla ragione; una poesia come espressione della sensibilità popolare.
– alle tesi di Winkelmann e ai modelli neoclassici si opponevano Shakespeare, ritenuto il maggior interprete dello spirito poetico delle popolazioni del Nord.
b) Germania. Qui tra gli anni 70/’70 prese piede il movimento dello Sturm un Drang.
– anche qui la poesia naturale come espressione spontanea e immediata del popolo viene contrapposta al Neoclassicismo;
– vengono esaltati i concetti di «cuore», «intuizione», «spontaneità», «genio», e anche qui Shakespeare era considerato modello di questo genio popolare.
– gli autori principali sono Herder, e il giovane Goethe.