
Il fanciullino
27 Gennaio 2019
Adriano Celentano
27 Gennaio 2019Analisi del significato e delle dinamiche profonde della novella La carriola di Luigi Pirandello (1921), focalizzata su alcuni brani significativi, con introduzione e commento.
📘 Introduzione
La novella La carriola, pubblicata nel 1921 e inclusa nella raccolta Novelle per un anno, rappresenta una delle espressioni più compiute del pensiero pirandelliano. Al centro vi è un professionista borghese, avvocato e professore di diritto, simbolo di rispettabilità sociale, la cui interiorità contrasta violentemente con la maschera che è costretto a indossare.
Come altri personaggi pirandelliani (si pensi a Belluca de Il treno ha fischiato, o a Mattia Pascal), anche qui assistiamo a uno scollamento tra identità pubblica e impulso individuale, ma ciò che distingue il protagonista della Carriola è la segretissima, meschina forma di ribellione che egli mette in atto — un gesto tanto banale quanto disperato: far fare la carriola alla propria cagnolina Lupetta.
🔍 Analisi e commento dei brani
1. L’Inizio: lo sguardo della bestia
Quand’ho qualcuno attorno, non la guardo mai; ma sento che mi guarda lei […] tremando, la voluttà d’una divina, cosciente follia, che per un attimo mi libera.
In questa apertura, il narratore si rivolge direttamente al lettore, rivelando un gesto segreto, tanto innocuo in superficie quanto portatore di una carica liberatoria devastante. Lo sguardo della cagna, “che mi guarda senza staccarmi un momento gli occhi d’addosso”, è specchio di una coscienza morale che osserva e giudica, come una presenza che conosce la realtà inconfessabile che si cela dietro la maschera.
Il gesto – fare la carriola alla cagna – è caricato di significato: è un atto non giustificabile dalla razionalità, compiuto nel segreto, nella sospensione della maschera sociale. Pirandello qui esplora il tema della “cosciente follia”: la consapevolezza razionale di un comportamento assurdo ma liberatorio, che diventa sfogo silenzioso contro il proprio ruolo imposto.
2. Il centro: l’epifania del pianerottolo
Io vidi a un tratto […] me stesso e la mia vita, ma per non riconoscermi e per non riconoscerla come mia.
Questa è la scena cardine della novella: la crisi d’identità. Di ritorno da un viaggio, il protagonista si ferma dinanzi alla porta del proprio studio, dove il suo nome campeggia incorniciato da titoli e onorificenze. È la pienezza dell’identità borghese, costruita e riconosciuta. Ma in quell’istante, il protagonista percepisce una distanza radicale tra il sé intimo e il sé sociale: si guarda “da fuori”, come uno sconosciuto.
Questo momento di epifania negativa è tipicamente pirandelliano: la realtà viene vista all’improvviso come finzione, maschera, recita. La percezione improvvisa dell’“oltre”, dell’assurdo del quotidiano, è simile al treno che ha fischiato per Belluca: un risveglio mentale, ma che non porta a una liberazione vera e propria. Il sistema è troppo saldo. Il protagonista non si ribella in modo eclatante, ma si rifugia nella follia controllata del gesto privato.
3. Il finale: la carriola
Questo è tutto. Non faccio altro. […] Ma, ecco, la bestia […] séguita maledettamente a guardarmi, atterrita.
Il gesto finale – fare la carriola alla cagna – è l’atto simbolico che dà il titolo alla novella. È un’azione priva di senso, infantile, grottesca; eppure, per l’uomo “carico come un cannone di tutta la sua sapienza formidabile”, rappresenta l’unico momento in cui può disfarsi del ruolo sociale, dei doveri, dell’“austera dignità” imposta.
Ma neanche in questo gesto c’è pace. La reazione della cagna, che lo guarda “atterrita”, rompe l’illusione. Lupetta non riconosce il suo padrone: l’irruzione dell’assurdo mina l’ordine consueto, e il gesto liberatorio diventa angoscia riflessa. La cagna diventa testimone di una crisi, come un contraltare silenzioso della società: essa non può concepire che l’uomo di legge possa scherzare.
Così, la follia controllata e segreta del protagonista si rivela inutile e patetica: il gesto non cambia nulla, non trasforma, non redime. Dopo l’atto, egli “si rimette in trono”, come se nulla fosse. È una libertà solo apparente, un’autoterapia della frustrazione, che lascia intatto il teatro della vita.
🧩 Conclusione
La carriola è una profonda allegoria del rapporto tra individuo e società, tra spinta vitale e costrizione della forma. Il protagonista è un uomo che ha introiettato il proprio ruolo fino a identificarsi con esso, e che non può permettersi nessuna rottura visibile. Come in molte opere di Pirandello, la libertà non è conquistabile pubblicamente, ma solo in gesti privati, ambigui, illogici, che non portano alla redenzione ma testimoniano l’inquietudine di vivere.
Il gesto della carriola non è ridicolo in sé, ma lo diventa nella dissonanza tra la serietà sociale del personaggio e l’assurdità infantile del gesto, come se la sola via d’uscita fosse una follia consapevole, privata, non condivisibile.
📘Esercizio finale
Confronta questa novella con Il treno ha fischiato o con Uno, nessuno e centomila. ✨
📖 La carriola di Luigi Pirandello
Il professore stimato di diritto, avvocato, mentre sta viaggiando in treno (un evento come per Belluca) riconosce l’oltre nella sua vita. Tuttavia la sua ribellione non diventa pubblica, come quella di Belluca, ma meschinamente privata, con la cagna Lupetta. Si ferma a vedere il suo nome e cognome incisi sulla porta, ma come Mattia, rientra nella vita di prima.
Brani significativi della novella “La carriola” del 1921 (Luigi Pirandello)
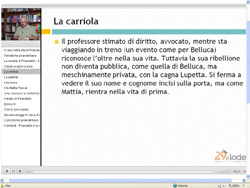
La carriola – inizio
Quand’ho qualcuno attorno, non la guardo mai; ma sento che mi guarda lei, mi guarda, mi guarda senza staccarmi un momento gli occhi d’addosso. Vorrei farle intendere, a quattr’occhi, che non è nulla; che stia tranquilla; che non potevo permettermi con altri questo breve atto, che per lei non ha alcuna importanza e per me è tutto. Lo compio ogni giorno al momento opportuno, nel massimo segreto, con spaventosa gioja, perché vi assaporo, tremando, la voluttà d’una divina, cosciente follia, che per un attimo mi libera
La carriola – a metà
Con quest’animo scesi alla stazione, montai sulla mia automobile che m’attendeva all’uscita, e m’avviai per ritornare a casa.
Ebbene, fu nella scala della mia casa; fu sul pianerottolo innanzi alla mia porta.
Io vidi a un tratto, innanzi a quella porta scura, color di bronzo, con la targa ovale, d’ottone, su cui è inciso il mio nome, preceduto dai miei titoli e seguito da’ miei attributi scientifici e professionali, vidi a un tratto, come da fuori, me stesso e la mia vita, ma per non riconoscermi e per non riconoscerla come mia.
La carriola – finale
piano, con garbo, le prendo le due zampine di dietro e le faccio fare la carriola: le faccio muovere cioè otto o dieci passi, non più, con le sole zampette davanti, reggendola per quelle di dietro.
Questo è tutto. Non faccio altro. Corro subito a riaprire l’uscio adagio adagio, senza il minimo cricchio, e mi rimetto in trono, sul seggiolone, pronto a ricevere un nuovo cliente, con l’austera dignità di prima, carico come un cannone di tutta la mia sapienza formidabile.
Ma, ecco, la bestia, da quindici giorni, rimane come basita a mirarmi, con quegli occhi appannati, sbarrati dal terrore. Vorrei farle intendere – ripeto – che non è nulla; che stia tranquilla, che non mi guardi cosí.
Comprende, la bestia, la terribilità dell’atto che compio.
Non sarebbe nulla, se per ischerzo glielo facesse uno dei miei ragazzi. Ma sa ch’io non posso scherzare; non le è possibile ammettere che io scherzi, per un momento solo; e séguita maledettamente a guardarmi, atterrita.





