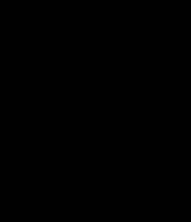Bauhaus
27 Gennaio 2019

Programma svolto di disegno
27 Gennaio 2019Le formelle alla base del campanile di Giotto a Firenze
Introduzione all’argomento
La costruzione del Campanile ebbe inizio nel 1334 quando Giotto fu chiamato dall’Opera di Santa Maria del Fiore, voluta e finanziata dalla Repubblica Fiorentina, per diventare capomastro della nuova Cattedrale di Firenze, dopo che Arnolfo di Cambio nel 1296 aveva posto la prima pietra del Duomo. Santa Maria del fiore, la cattedrale, è dedicata alla Madonna e questo si vede anche dalle varie decorazioni sulla facciata proprio incentrate sulla Madonna. La sintesi del significato della cattedrale si trova nel rilievo esterno sul lato sud, esso raffigura lAnnunciazione” risalente alla fine del 1200.


Foto campanile di Giotto


Foto di Santa Maria in Fiore con vista dall’alto
Successivamente, alla costruzione delle prime due campate e realizzando il rivestimento marmoreo esterno e il primo livello delle sculture della facciata, Giotto si concentrò nella costruzione del campanile. Il campanile fu la grande novità del nuovo Duomo a essere realizzata. Questo campanile, di grande imponenza e di grande altezza, fu costruito in soli trent’anni. Nel progetto originario doveva essere la costruzione più alta di Firenze, più alta delle numerose torri patrizie, che proprio Arnolfo nel 1299 aveva iniziato, più alto anche della cupola del Duomo che sempre Arnolfo aveva ideato. La torre del Campanile doveva dominare con la sua altezza e con la lucentezza dei suoi marmi la veduta della città anche per chi giungeva da lontano. Giotto ideò l’alto e ricco campanile caratterizzandolo con una base solida di marmo, su cui si sviluppavano un numero crescente di finestre, fino a giungere a elaborato coronamento a guglia. La torre del Campanile doveva dominare con la sua altezza e con la lucentezza dei suoi marmi la veduta della città anche per chi giungeva da lontano. Giotto ideò l’alto e ricco campanile caratterizzandolo con una base solida, di rigore classico, su cui si sviluppavano un numero crescente di finestre, fino a giungere a elaborato coronamento a guglia. Giotto morì tre anni dopo l’inizio del Campanile avendo, secondo la tradizione, cominciato a disegnare le formelle esagonali del basamento.
Dai documenti risulta già collaboratore nella fase di realizzazione dei rilievi Andrea Pisano che dal 1330 al 1336 aveva eseguito le porte bronzee del Battistero raffiguranti le Storie del Battista. Andrea Pisano portò avanti i lavori del Campanile fino agli anni 40, in un periodo di grandi difficoltà politiche ed economiche; si deve a lui lo sviluppo della parte scultorea, incentrata su due livelli sovrapposti con l’inserimento delle formelle romboidali. Andrea Pisano fu sostituito da Francesco Talenti che dette compimento alla struttura architettonica del Campanile e successivamente ingrandì il progetto della Cattedrale di Arnolfo secondo le proporzioni che ancora oggi la contraddistinguono. I rilievi scultorei delle formelle, che caratterizzano il basamento del Campanile, sono riferibili ad Andrea Pisano e al suo ambito eccetto le ultime raffiguranti i Sacramenti, attribuite ad Alberto Arnoldi. Successivamente il ciclo fu in parte alterato con lo spostamento sul lato nord delle formelle raffiguranti la pittura e la scultura e con l’inserimento, sempre sul lato nord, di cinque formelle esagonali, realizzate da Luca della Robbia, raffiguranti le arti liberali e i loro inventori. Questo intervento, estraneo alla leggibilità del ciclo, fu voluto quando nel 1431 fu abbattuto il cavalcavia che collegava la Cattedrale col Campanile.
Un ciclo come quello delle formelle del Campanile di Giotto, sintesi di una complessa cultura diffusa, ha sicuramente un suo ispiratore diretto o indiretto. Probabilmente è fra Remigio dè Girolami, un teologo domenicano attivo a Firenze tra il Duecento e il Trecento, discepolo diretto di san Tommaso d’Aquino a Parigi e forse a Napoli, Il corredo scultoreo del Campanile fu completato con l’inserimento nelle nicchie del terzo livello di sedici statue raffiguranti patriarchi, re, profeti e sibille.
I cicli sul lavoro
I cicli sul lavoro sono tipici di tutta la cultura medievale e si trovano ancora conservati in tante città , da Chartres a Modena, a Perugia. Il Medioevo era infatti ben consapevole che dal cristianesimo era nata un’antropologia nuova e una originale concezione del lavoro, non come attività servile, ma come creativa espressione dell’uomo libero.
A Firenze questo tema è svolto in modo assolutamente originale e in un’epoca, alla metà circa del Trecento, più tarda rispetto ai cicli sul lavoro conservati nelle altre città europee. I cicli medievali descrivono di solito il lavoro dell’uomo in rapporto al ritmo dei mesi o delle stagioni e questo nesso è tipico della civiltà contadina. A Firenze invece, il ciclo sul lavoro è totalmente svincolato dal ciclo dei mesi, probabilmente per la vocazione mercantile della città , che nel Trecento può essere annoverata tra le più importanti e ricche città europee. L’importanza di Firenze, a differenza di altre città medievali, non è legata a un passato glorioso. La città prima del 1000, non ha alcun rilievo particolare: non è stata significativa né per la civiltà etrusca, né per quella romana e neppure per quella dell’alto Medioevo. All’improvviso, dopo il 1000, come testimonia la straordinaria mole del Battistero realizzato nell’XI secolo, Firenze esplode. Nel ciclo del lavoro la città di Firenze vanta la ragione del suo successo, che non deriva da una tradizione gloriosa o da una ricchezza legata alla terra, ma scaturisce da quelle attività imprenditoriali cittadine, sorte per l’opera laboriosa dei suoi abitanti. E’ il lavoro dell’uomo, come partecipazione alla creatività di Dio, che dà senso al tempo, trasformandolo in storia e civiltà .
Sulle mura del Campanile di Giotto, edificio che nella città scandiva col suono delle campane le ore e sottolineava i momenti e gli eventi più importanti, il nesso lavoro-tempo è espresso attraverso la descrizione storica di tutte le attività umane. Il ciclo si articola su due livelli con formelle esagonali nel primo ordine e romboidali nel secondo, ad eccezione del lato nord che originariamente aveva solo quelle romboidali. Entrambi i tipi delle formelle si distribuiscono su tutti e quattro i lati del Campanile.
Il tema del lavoro nel ciclo delle formelle
Il lato ovest prospiciente il Battistero
Il ciclo parte definendo che cos’è l’uomo e che cos’è il lavoro dell’uomo. La risposta è dalla cultura medievale rintracciata nelle prime pagine della Bibbia, precisamente nel libro della Genesi: l’uomo è creatura, fatto da Dio a sua immagine e somiglianza. Dio è l’eterno lavoratore – tam Pater nemo, così generatore, nessuno – che crea dal nulla tutte le cose e chiama l’uomo a collaborare alla creazione. In questa vocazione consiste tutta la dignità del lavoro umano.
Sopra i rilievi dedicati alle storie della Genesi – la cui forma esagonale ricorda che sei sono i giorni della creazione e il sesto giorno Dio creò l’uomo a sua immagine e somiglianza – sono raffigurati i sette pianeti, disposti secondo l’ordine tolemaico: Luna, Mercurio, Venere, Sole, Marte, Giove, Saturno. Il senso di lettura degli esagoni procede, come la scrittura, da sinistra verso destra, mentre i pianeti sono ordinati da destra verso sinistra.
Linsolita disposizione probabilmente è subordinata alla topografia della città . A destra del Campanile infatti sorgono il Palazzo della Signoria e la chiesa di Orsanmichele – appartenente alle corporazioni fiorentine -, il centro politico ed economico di Firenze; mentre a sinistra troviamo la Cattedrale. Per questa ragione il cielo più vicino alla terra, la Luna, è collocato a destra nella zona terrestre, mentre il settimo cielo, Saturno, il più vicino allEmpireo, è situato a sinistra nella zona celeste.


Schema formelle lato ovest
Le formelle esagonali
1. La creazione di Adamo
La prima formella esagonale rappresenta La creazione di Adamo: «e Dio disse: Facciamo l’uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla terra”» (Gen. 1, 26). All’inizio del ciclo, il realismo medievale ci impone la meditazione sul grande lavoro di Dio che è la creazione, il cui vertice è l’uomo, la creatura, fatta a immagine e somiglianza del creatore


Formella esagonale rappresentante La creazione di Adamo”
2. La creazione di Eva
La seconda formella esagonale rappresenta La creazione di Eva, Dio non crea l’uomo solo. Dio stesso è mistero di comunione e fa l’uomo come mistero di comunione, uomo e donna. «Dio creò l’uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò»


Formella esagonale rappresentante La creazione di Eva”
3. Il lavoro dei progenitori
In questa formella Adamo ara la terra seguito da Eva che impugna il rocco per filare la lana Prosegue il percorso Il lavoro dei progenitori. Adamo, curvo verso il suolo, lavora la terra. Eva, al fianco, regge il fuso. Il lavoro non è la conseguenza del peccato originale, ma deriva dal fatto che l’uomo è simile a Dio: il Padre è l’Eterno Lavoratore e l’uomo è il lavoratore. Il fatto che sia lavoratore è il segno supremo della sua somiglianza con il Creatore, perché Dio ha voluto, in tutta la creazione, creare qualcuno simile a sé che continuasse il suo lavoro.


Formella esagonale rappresentante Il lavoro dei progenitori”
Gli altri quattro esagoni raffigurano i primordiali lavori, secondo la Genesi, assieme ai loro biblici fondatori:
4. Jabal, inventore della pastorizia
Egli si trova seduto a gambe incrociate nella sua tenda circondata dal gregge.
5. Jubal, inventore della musica (di Nino pisano, figlio di Andrea)
Egli fu il padre di tutti suonatori di cetra e di flauto.
6. Tubalcain, il primo fabbro, raffigurato allincudine
Egli era il padre di coloro che lavoravano il rame e il ferro.
7. Noè, il primo agricoltore (di un collaboratore di Andrea Pisano)
Egli fu il padre dell’agricoltura. Questa formella vuole mettere in risalto un fattore positivo caratteristico del paesaggio e della civiltà toscana. Due terzi della formella sono infatti occupati dalla vite piena di grappoli e dalla botte con il prezioso vino.
Le formelle romboidali
Sopra le sette formelle esagonali, che rappresentano la creazione e le prime attività dell’uomo, sono collocate, entro cornici romboidali, le personificazioni dei pianeti. Tra queste la Luna, con le sembianze di una fanciulla che tiene nella mano destra una fontana ed è seduta sulle acque; Saturno, che tiene con la mano sinistra Crono, suo figlio, il tempo e nella mano destra, la ruota del tempo.
1. Saturno, con la ruota del tempo (collaboratore)
2. Giove, nelle vesti cristiane di un monaco con il calice e la croce, simboli della fede (collaboratore)
3. Marte, nelle vesti di un guerriero a cavallo (collaboratore)
4. Sole, impersonato da Apollo, giovane coronato con scettro e disco solare (collaboratore)
5. Venere, principio universale di generazione, che sostiene con la destra una coppia di amanti (Nino Pisano)
6. Mercurio, con il segno dei gemelli (Nino Pisano)
7. Luna, che assisa sulle onde, allusione al suo influsso sulle acque, tiene nella mano destra una fontana (collaboratore)
Su questo versante trionfa l’uomo naturale, l’uomo dominato dai pianeti. Sul secondo lato del Campanile, irrompe nella storia l’avvenimento di Cristo
Il lato sud verso piazza della Signoria
Sul lato sud si trovano altre sette formelle di Andrea Pisano e di alcuni collaboratori. Sul lato sud del Campanile, nei rombi del livello superiore troviamo raffigurate, dove sull’altro lato erano collocati i pianeti, le virtù della conoscenza di Cristo, che è conoscenza della realtà totale, fino al suo significato e le virtù cardini della vita morale: Fede, Carità e Speranza (virtù teologali), Prudenza, Giustizia, Temperanza e Fortezza (virtù cardinali). Le virtù teologali vengono da Dio e le virtù cardinali costituiscono i cardini della vita umana. L’uomo è dominato dalla conoscenza di Cristo e vive il lavoro non più come vera risposta ai suoi bisogni immediati, ma come la forma del suo incivilimento.


Schema formelle lato sud
Sotto le sette virtù sono posti gli esagoni delle attività del primo incivilimento umano.
Su questo lato i rimandi fra losanghe ed esagoni sono molto evidenti: lAstrologo pare volgersi alla rappresentazione della Fede; l’opera solidale del cantiere corrisponde alla Carità che sostiene i deboli; allesagono della Medicina si accompagna la Speranza; la Prudenza tiene a freno il cavaliere; il lavoro della Tessitrice è sorvegliato dalla Giustizia; la Temperanza presiede all’opera del Legislatore; il personaggio di Dedalo evoca la Fortezza.
Le formelle esagonali
8. Gionitus, inventore dell’astronomia (collaboratore)
In questa ottava formella esagonale viene rappresentato Gionitus, inventore dell’astronomia. In questa formella c’è un astronomo che sta scrutando il cielo con lo strumento del suo lavoro, che è lastrolabio o cercatore di stelle. Il cielo è inscritto in un cerchio, modello dell’universo finito, oltre il quale si affaccia il paradiso, lEmpireo, con le piccole teste degli angeli, dei santi e di Dio Padre. Lastronomia è anche collocata in corrispondenza della Fede, il primo lavoro umano è nell’ordine della conoscenza.


Formella esagonale rappresentante Gionitus, inventore dell’astronomia”
9. Arte di edificare (collaboratore)
In questa nona formella esagonale viene rappresentata L’arte di edificare. L’uomo per lavorare non ha bisogno solo di conoscere lo scopo di tutto, il nesso che ogni particolare ha con le stelle, l’uomo per lavorare ha bisogno di una guida autorevole, di qualcuno da cui possa imparare. La formella mostra il capomastro che guida i muratori nella costruzione dell’edificio. Questa figura è sproporzionata rispetto alle altre e il volto ha le sembianze di quello di Cristo. L’arte medievale traduce iconograficamente l’idea di autorità con la raffigurazione di un uomo più grande”.
10. Medicina (Nino Pisano)
In questa decima formella esagonale viene rappresentata La medicina. La formella rappresenta un medico in cattedra che esamina con solennità un vaso di urine, che i pazienti gli consegnano in tipici contenitori. La grandezza del lavoro dipende dallo scopo, non della materia trattata. Il medico non si occupa di stelle, ma di uomini malati, eppure il suo lavoro ha la stessa identica dignità dell’astronomo.


Formella esagonale rappresentante La medicina”
11. La caccia o Equitazione
In questa undicesima formella esagonale viene rappresentata La caccia e l’equitazione che sono rappresentate da un cavaliere.
12. Lanificium, ovvero l’arte tessile
In questa dodicesima formella esagonale viene rappresentata LArte tessile. Quella della tessitura è la formella più ricca di particolari di tutto il ciclo del Campanile. Dal Lanificium, l’arte tessile, deriva gran parte della ricchezza della Firenze trecentesca. In un trattato di fra Remigio Gerolami, probabile fonte di questo ciclo, si parla dell’arte della tessitura, come del lavoro umano più simile al lavoro di Cristo nella storia, ovvero tessere la veste della Sua sposa, la Chiesa.


Formella esagonale rappresentante L’arte della tessitura”
13. Phoroneus, mitico re greco di Argo che impersona la legislazione (Nino Pisano)
In questa tredicesima formella esagonale viene rappresentata La legislazione, con la raffigurazione di Phoroneus, il mitico fondatore del diritto, che consegna le leggi agli uomini.
14. La meccanica
In questa quattordicesima formella esagonale viene rappresentata La meccanica, con il mito di Dedalo, inventore del volo e personificazione della teche, che per i greci era insieme arte e sapere tecnico.
Formella esagonale rappresentante La meccanica”
Questo lato viene proprio concluso con il mito di Dedalo. L’uomo che scruta il cielo (Lastronomia) apre questa sezione mentre l’uomo che lo conquista chiude il ciclo. Dedalo è considerato nell’antichità classica il mitico inventore di tutte le arti e le tecniche, viene esaltato in questa sua funzione della cultura medievale.
Le formelle romboidali
Sopra le sette formelle esagonali, che rappresentano lincivilimento dell’uomo ci sono le sette formelle romboidali che rappresentano le virtù cardinali e teologali.
8. Fede, con la croce e il calice (Gino Micheli)
9. Carità , che reca nella mano destra un cuore e nella sinistra una cornucopia (collaboratore di Andrea Pisano)
10. Speranza, con le ali spiegate e le mani giunte in atto di preghiera (collaboratore A. Pisano)
11. Prudenza, con due teste, una giovanile e una senile, il serpente e lo specchio
12. Giustizia, con spada e bilancia
13. Temperanza, nelle vesti di una donna che versa acqua nel vino
14. Fortezza, ammantata di una pelle di leone, con clava e scudo (collaboratore di A. Pisano)
Il lato est verso via dello Studio


Schema formelle lato est
Il terzo lato, quello est, si sviluppa verso la sede originaria dello Studio Fiorentino (nucleo originario dell’università ). La nascita della prestigiosa istituzione fu deliberata nel 1321 e riconosciuta nel 1341 da papa Clemente VI. Il pontefice espresse il desiderio che i professori provenissero dalle maggiori università europee e autorizzò la nascita di una facoltà teologica, privilegio al tempo assai raro. Questo lato può essere considerato un omaggio alla università che si stava formando.
Nel suo assetto definitivo, il lato est era decorato solo da cinque formelle, le prime tre di Andrea, le altre di Nino:
15. Navigatio, la navigazione
In questa quindicesima formella esagonale viene rappresentata La navigazione. L’iconografia di questa formella rimanda evidentemente a una scena evangelica: Gesù in barca con due discepoli.
Formella esagonale rappresentante La naviigatio”
16. Giustizia sociale o liberazione della terra dai mostri
In questa sedicesima formella esagonale viene rappresentata La giustizia sociale o liberazione della terra dai mostri, impersonata dalla scena mitologica di Ercole che abbatte Caco, predone di armenti La giustizia sociale, è dedicata alla politica come lavoro. L’autore si serve di una scena mitologica: Ercole che uccide Caco. Fare politica significa liberare la terra dai mostri, restituire l’armonia originale ai rapporti tra gli uomini, come suggerisce la posizione di questa formella, collocata sotto La musica. La giustizia è la musica” nei rapporti umani, è scoprire quell’armonia nascosta che è la legge delle cose.
Formella esagonale rappresentante Giustizia sociale o liberazione della terra dai mostri”
17. Homogirus, inventore dell’agricoltura
In questa diciassettesima formella esagonale viene raffigurata L’agricoltura. Sempre su questo tema, in analoga posizione, corrisponde nel primo lato, quello posto a ovest, la formella con Adamo curvo verso il suolo. La differenza tra la prima e la seconda formella dedicata all’agricoltura è segnata dalla storia. Tutto il ciclo è incentrato sul binomio lavoro-tempo: il Campanile è il monumento del tempo e su questo edificio il tema del lavoro è rappresentato storicamente. Dalla fatica di Adamo si passa a questo uomo che opera fecondamene sulla terra. Il passaggio è reso possibile dalla storia, da un fatto che nella storia è accaduto: l’avvenimento di Cristo. L’uomo che lavora non è più servo, ma è padrone della terra, tanto che sembra comunicare questo vigore e questa dignità anche ai buoi, mentre insegna a suo figlio, che lo guarda con ammirazione, a fare altrettanto.
Formella esagonale rappresentante L’agricoltura”
18. Theatrica o arte delle feste e degli spettacoli
In questa diciottesima formella esagonale viene rappresentata La theatrica.
Questa formella rappresentata da una carro leggero che allude ai giochi del circo.
19. Architettura
In questa diciannovesima formella esagonale viene rappresentata Larchitettura, dove il geometra Euclide è raffigurato nell’atto di disegnare. La formella dell’architettura è collocata quasi nello spigolo del Campanile. Larchitetto non è più il muratore presente nel secondo lato, ma è l’uomo che modella lo spazio. All’apice del lavoro umano sta l’uomo che crea lo spazio, rispondendo al gesto di Dio che crea la grande stanza dell’universo. L’uomo imita Dio fino a quel vertice. Se questo architetto, raffigurato mentre sta disegnando, alzasse la testa, vedrebbe di fronte a sé l’immensa mole di Santa Maria del Fiore ideata dalla sua mente.
Formella esagonale rappresentante Larchitettura”
Formelle romboidali
Nell’ordine delle formelle romboidali troviamo le arti del trivio e del quadrivio, ovvero le arti riconosciute dalla tradizione classica come liberali (dell’uomo libero) e insegnate nelle università medievali. Le personificazioni delle arti liberali sovrastano i sette esagoni con le raffigurazioni dei lavori che costituiscono l’apice dellincivilimento umano. Le formelle dell’ordine superiore sono, secondo una tradizione che ebbe nel Medioevo e nel primo Rinascimento una larga diffusione, personificazioni allegoriche delle arti.
Le prime due arti liberali sono Lastronomia e La musica, entrambe già presenti nel ciclo del Campanile, ma nel livello inferiore, nelle formelle esagonali. Secondo la dottrina di san Tommaso d’Aquino, ripresa da Dante, l’uomo «da sensato apprende ciò che fa poscia d’intelletto degno» (apprende dall’esperienza, ciò che diventa poi conoscenza intellettuale). Nella prima parte del ciclo Lastronomia e La musica erano raffigurate come attività empiriche, ora come conoscenze intellettuali.
Sul lato est sono raffigurate le sette Arti liberali:
15. Astronomia, con lastrolabio
16. Musica, con il salterio (Gino Micheli)
17. Geometria, con il libro e compasso (Andrea Pisano)
18. Grammatica, che impugnando un frustino, insegna ad alcuni fanciulli (Gino Micheli)
19. Retorica, con spada e scudo (Andrea Pisano)
20. Logica, con le forbici (Gino Micheli)
21. Aritmetica, nell’atto di contare (Gino Micheli)
Il lato nord prospiciente il prospetto laterale della Cattedrale


Schema formelle lato nord
Nel quarto lato, il lato nord, secondo il progetto originario successivamente modificato, non troviamo più il doppio ordine di formelle. Questa scelta dipende dal fatto che nel mondo esiste un lavoro in cui ideale e realtà , conoscenza e azione coincidono. Nel punto di passaggio tra il Campanile e la Cattedrale, c’è un solo ordine: i Sacramenti, il lavoro di Cristo, come uomo, la creatività di Cristo, in cui l’ideale accade e diventa un pezzo della realtà . La raffigurazione dei Sacramenti, in formelle romboidali, non è di carattere simbolico o allegorico. Il lavoro è figurato come azione sacramentale. Con scelta realistica i sacramenti non sono rappresentati in modo allegorico, bensì attraverso la concreta vicenda della loro amministrazione, mentre l’aspetto simbolico è appena accennato in una piccola immagine situata nella parte bassa della losanga. In questo lato nord le formelle più importanti sono quelle romboidali e non quelle, come negli altri tre lati, quelle esagonali.
22. Il Battesimo
In questa ventiduesima formella romboidale viene rappresentata Il Battesimo. Il battesimo è il gesto con cui Cristo ricrea l’uomo, rendendolo nuova creatura. Nella formella, la madrina sorregge il neonato sul fonte mentre il sacerdote gli bagna il capo con l’acqua santa. In basso si trova un putto con cornucopia, a significare grazia e abbondanza.
Formella romboidale rappresentante Il Battesimo”
23. Confessione o Penitenza
In questa ventitreesima formella romboidale viene rappresentata La confessione o la penitenza.
La permanenza di questo uomo nuovo è assicurata dalla misericordia di Cristo che continuamente perdona il peccato.
Nella formella c’è un fedele che è inginocchiato di fronte al sacerdote seduto, che gli impone la mano nell’atto dell’assoluzione. In basso si trova una testa di Furia simbolo del disordine dell’anima in seguito al peccato.
24. Il Matrimonio
In questa ventiquattresima formella romboidale viene rappresentato Il Matrimonio. Nella formella
c’è lo sposo che è rappresentato nell’atto di infilare l’anello al dito della sua sposa. Al centro si trova il sacerdote e dietro altri quattro personaggi, che sono i testimoni e i parenti. In basso è rappresentata un’architettura con ogiva trilobata, che sta ad indicare la solidità dell’unione matrimoniale. Il matrimonio è il sacramento attraverso cui Dio rende l’amore tra l’uomo e la donna generazione del Suo popolo.
Formella romboidale rappresentante Il Matrimonio”
25. Ordine e Sacerdozio
In questa venticinquesima formella romboidale viene rappresentato L’ordine e il sacerdozio. In questo rilievo, a forma di cuspide era collocato sopra la lunetta che sormontava l’antica porta del Campanile sul lato nord; rappresenta un vescovo che legge la formula di consacrazione del nuovo sacerdote.
26. La Cresima
In questa ventiseiesima formella romboidale viene rappresentata La cresima. In questa formella c’è un vescovo con una mitria che unge la fronte del bambino tenuto in braccio dalla madrina. In basso una testa di Ercole, simbolo dell’investitura a soldato di Cristo, conferita dal sacramento. La cresima, è fissata nel gesto con cui Cristo conferma nel mondo il protagonista della storia, il Suo testimone.
27. LEucaristia
In questa ventisettesima formella romboidale viene rappresentata LEucaristia. Nella formella si vede il sacerdote, assistito da un chierico inginocchiato, che è raffigurato nel momento dell’elevazione dellostia. In basso si trova una testa di leone, simbolo della forza soprannaturale della Chiesa. LEucaristia, è colta nel momento della consacrazione in cui un pezzo di pane diventa il Corpo di Cristo. Questo sacramento esprime il desiderio del lavoro umano di trasformare con le proprie mani la realtà e di manifestare la sua ultima consistenza.
Formella romboidale rappresentante LEucaristia”
28. Estrema Unzione
In questa ventottesima formella romboidale viene rappresentata Lestrema unzione.
Nella formella si vede un moribondo dalle forme scheletriche che giace sul suo letto di agonia. Un sacerdote gli unge il petto, mentre un chierico legge le preghiere e un altro impugna un cero. In basso è raffigurata un aquila, simbolo del volo dell’anima verso il cielo della beatitudine eterna. Lestrema unzione chiude questa sezione. Il lavoro di Cristo accompagna l’uomo fino alla soglia dell’eterno. E l’eterno, infatti, la parola conclusiva di questa ultima formella.
Formella romboidale rappresentante L’Estrema unzione”
Questa misteriosa opera di Cristo, i cui gesti sono i sacramenti, è l’opera perfetta che c’è nel mondo, quella a cui tutta la laboriosità umana tende, tanto che il cristiano è l’uomo chiamato a sentire il lavoro come il riflesso ancora crepuscolare dei sacramenti sul cosmo intero. I sacramenti sono i gesti del grande Sacramento di Cristo nella storia che è la Chiesa e proprio verso la Cattedrale guardano queste formelle.
Sul lato nord ci sono anche formelle esagonali:
20. Armonia
21. Grammatica
22. Dialettica
23. Poesia
24. Aritmetica