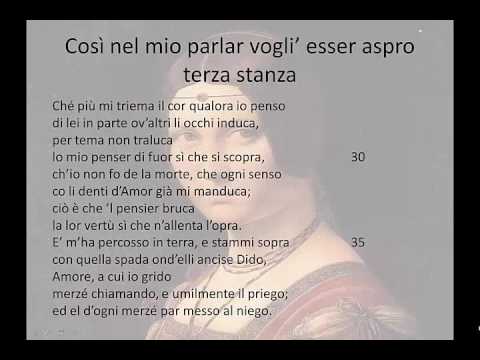
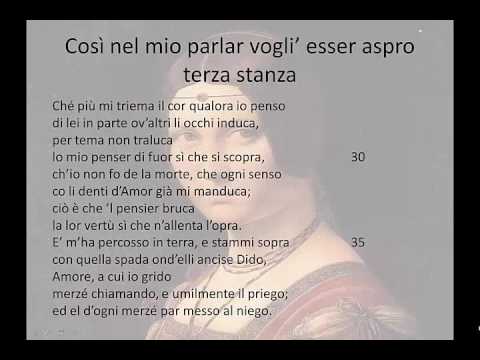
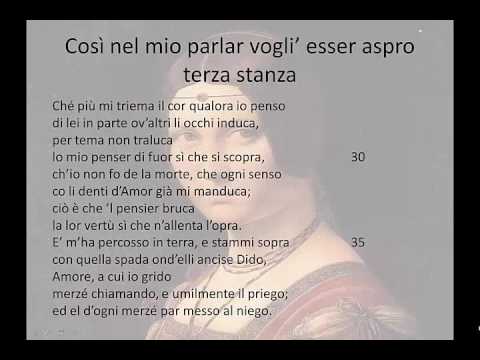
Così nel mio parlar voglio esser aspro. Parafrasi interlineare e commento delle r…
3 Agosto 2015

Inferno XXXIII dalla Divina commedia di Dante Alighieri – di Carlo Zacco
3 Agosto 2015
Inferno XXVI
1-12. Violenta invettiva contro Firenze e la sua corruzione, scaturita da
ciò che Dante aveva visto nel canto precedente, nella bolgia dei ladri.
–
Segue una oscura profezia su una sventura che colpirà la città.
Segue una oscura profezia su una sventura che colpirà la città.
36912 |
Godi, Fiorenza, poi che se’ sí grande,che per mare e per terra batti l’ali,e per lo ‘nferno tuo nome si spande!Tra li ladron trovai cinque cotalituoi cittadini onde mi ven vergogna,e tu in grande orranza non ne sali.Ma se presso al mattin del ver si sogna,tu sentirai di qua da picciol tempodi quel che Prato, non ch’altri, t’agogna.E se già fosse, non saría per tempo:cosí foss’ei, da che pur esser dee!ché più mi graverà, com più m’attempo. |
Godi: in senso ironico:
|
Questa invettiva rientra in un percorso tematico che percorre tutta la commedia:
–
If VI, Ciacco: la descrizione di Ciacco dei mali di Firenze: «superbia,
avarizia, invidia»;
If VI, Ciacco: la descrizione di Ciacco dei mali di Firenze: «superbia,
avarizia, invidia»;
–
If XV, Brunetto: «gent’è avara, invidiosa e superba»;
If XV, Brunetto: «gent’è avara, invidiosa e superba»;
–
If XVI Dante a Iacopo Rusticucci: dove accusa i «sùbiti guadagni»;
If XVI Dante a Iacopo Rusticucci: dove accusa i «sùbiti guadagni»;
–
Tocca il culmine in Pd XV, XVI, XVII con il lungo discorso di Cacciaguida.
Tocca il culmine in Pd XV, XVI, XVII con il lungo discorso di Cacciaguida.
Dante, nella Commedia, traccia una storia morale di Firenze, in chiave negativa,
e ne denuncia la degenerazione morale.
e ne denuncia la degenerazione morale.
13-24. Inizia il racconto. Dante-personaggio risale faticosamente sul ponte
che sovrasta l’ottava bolgia.
–
c’è una importante affermazione di Dante-autore, che riflette sulla
necessità di mantenere il proprio ingegno entro i limiti importi dalla morale
cristiana.
c’è una importante affermazione di Dante-autore, che riflette sulla
necessità di mantenere il proprio ingegno entro i limiti importi dalla morale
cristiana.
15182124 |
Noi ci partimmo, e su per le scaleeche n’avean fatte i borni a scender pria,rimontò ‘l duca mio e trasse mee;e proseguendo la solinga via,tra le schegge e tra’ rocchi dello scogliolo piè sanza la man non si spedía.Allor mi dolsi, e ora mi ridoglioquando drizzo la mente a ciò ch’io vidi,e più lo ‘ngegno affreno ch’i’ non soglio,perché non corra che virtú nol guidi;sí che, se stella bona o miglior cosam’ha dato ‘l ben, ch’io stessi nol m’invidi. |
iborni: due interpretazioni:
|
Introduzione morale. Il dolore provato da Dante-Personaggio nel vedere le
sofferenze di coloro che sono puniti per aver rivolto il proprio ingegno in
azioni scorrette, porta Dante-Autore ad attualizzare quel ricordo, e fare in
modo che agisca freno morale, sia per lui, che per i lettori.
–
l’intelligenza è un dono di Dio ma comporta rischi se usata male, cioè fuori
dalla virtù morale; l’uso scorretto della ragione più portare a due diversi tipi
di peccato, ugualmente puniti nell’VIII bolgia:
l’intelligenza è un dono di Dio ma comporta rischi se usata male, cioè fuori
dalla virtù morale; l’uso scorretto della ragione più portare a due diversi tipi
di peccato, ugualmente puniti nell’VIII bolgia:
1)
se il male è nel mezzo o nel fine, porta alla frode e all’inganno:
se il male è nel mezzo o nel fine, porta alla frode e all’inganno:
2)
se il male è nell’autosufficienza intellettuale (fare a meno di Dio), porta alla
superbia, ed è quello che teme Dante per sé;
se il male è nell’autosufficienza intellettuale (fare a meno di Dio), porta alla
superbia, ed è quello che teme Dante per sé;
–
Ulisse le ha entrambe: gli inganni (enumerati da Virgilio) la Superbia
(l’ultimo viaggio, raccontato da lui);
Ulisse le ha entrambe: gli inganni (enumerati da Virgilio) la Superbia
(l’ultimo viaggio, raccontato da lui);
25-42. in questa sezione Dante descrive l’VIII
bolgia, attraverso due similitudini, una agreste, l’altra biblica: l’VIII è una
cava in cui i peccatori fluttuano avvolti completamente da una fiamma, che li
sottrae alla vista.
273033363942 |
Quante il villan ch’al poggio si riposa,nel tempo che colui che ‘l mondo schiarala faccia sua a noi tien meno ascosa,come la mosca cede a la zanzara,vede lucciole giú per la vallea,forse colà dov’e’ vendemmia ed ara;di tante fiamme tutta risplendeal’ottava bolgia, sí com’io m’accorsitosto che fui là ‘ve ‘l fondo parea.E qual colui che si vengiò con li orsivide ‘l carro d’Elia al dipartire,quando i cavalli al cielo erti levorsi,che nol potea sí con li occhi seguire,ch’el vedesse altro che la fiamma sola,sí come nuvoletta, in su salire;tal si move ciascuna per la goladel fosso, ché nessuna mostra il furto,e ogni fiamma un peccatore invola |
Quante > lucciole > tante fiamme
nel tempo…ascosa: in estate;
|
Introduzione visiva. Due similitudini: una agreste (come le lucciole
d’estate); una biblica (come il carro di Elia rapito in cielo). Entrambe fanno
vedere la scena da due punti di vista diversi, il primo più da lontano, il
secondo più da vicino, secondo una tecnica di zoom, che manifesta la
graduale presa di consapevolezza di Dante di fronte alla scena. Dal Campo
lungo > al primo piano. Di grande effetto.
43-63. Dante è talmente attratto da ciò che vede che, se non si aggrappasse
ad una roccia, rischierebbe di cadere nella bolgia. Virgilio vede l’interesse di
Dante, e spiega che si tratta di peccatori avvolti da Fiamme;
–
Dante in realtà è attratto da una fiamma diversa dalle altre, in quanto contiene
non uno, ma due peccatori, e appare pertanto biforcuta, e chiede spiegazioni.
Virgilio risponde che si tratta di Ulisse e Diomede che, come in vita
hanno agito insieme compiendo inganni, allo stesso modo sono puniti insieme.
Quindi Virgilio elenca i tre più famosi inganni di Ulisse e Diomede: il cavallo
di Troia; l’inganno a Deidamia; il furto del Palladio;
Dante in realtà è attratto da una fiamma diversa dalle altre, in quanto contiene
non uno, ma due peccatori, e appare pertanto biforcuta, e chiede spiegazioni.
Virgilio risponde che si tratta di Ulisse e Diomede che, come in vita
hanno agito insieme compiendo inganni, allo stesso modo sono puniti insieme.
Quindi Virgilio elenca i tre più famosi inganni di Ulisse e Diomede: il cavallo
di Troia; l’inganno a Deidamia; il furto del Palladio;
45485154576063 |
Io stava sovra ‘l ponte a veder surto,sí che s’io non avessi un ronchion preso,caduto sarei giú sanz’esser urto.E ‘l duca, che mi vide tanto atteso,disse: «Dentro dai fuochi son li spirti;ciascun si fascia di quel ch’elli è inceso».«Maestro mio» rispuos’io, «per udirtison io più certo; ma già m’era avvisoche cosí fosse, e già voleva dirti:chi è in quel foco che vien sí divisodi sopra, che par surger della piradov’Eteòcle col fratel fu miso?»Rispuose a me: «Là dentro si martiraUlisse e Dïomede, e cosí insemealla vendetta vanno come all’ira;e dentro dalla lor fiamma si gemel’agguato del caval che fe’ la portaonde uscí de’ Romani il gentil seme.Piangevisi entro l’arte per che, morta,Deïdamía ancor si duol d’Achille,e del Palladio pena vi si porta». |
S’io non avessi: allusione chiara
|
La bolgia dell’intelligenza. Questa bolgia è anomala. L’atmosfera è molto
pacata, composta:
–
non vi si trovano le scene ripugnanti, grottesche, oscene tipiche delle altre
bolge;
non vi si trovano le scene ripugnanti, grottesche, oscene tipiche delle altre
bolge;
–
non si insiste sulla crudeltà della pena, che tra l’altro sembra più dignitosa
delle altre;
non si insiste sulla crudeltà della pena, che tra l’altro sembra più dignitosa
delle altre;
–
la descrizione del dolore non è affidata alla forza delle immagini, ma a parole
astratte: si martira, si geme, piangevisi; Sembra che Dante abbia un
certo rispetto per coloro che hanno fatto cattivo uso dell’ingegno.
la descrizione del dolore non è affidata alla forza delle immagini, ma a parole
astratte: si martira, si geme, piangevisi; Sembra che Dante abbia un
certo rispetto per coloro che hanno fatto cattivo uso dell’ingegno.
Ulisse e Diomede. Viene introdotta una terza similitudine mitologica, che
chiama in causa la vicenda della guerra contro Tebe, una vicenda mitica, che
prepara all’incontro con le due grandi figure mitologiche.
–
Virgilio descrive la scena in modo contenuto, rispettoso verso la tradizione
letteraria di cui lui stesso è stato portatore.
Virgilio descrive la scena in modo contenuto, rispettoso verso la tradizione
letteraria di cui lui stesso è stato portatore.
64-84. Dante chiede di parlare con quella doppia fiamma, ma Virgilio lo
trattiene, dando una motivazione non del tutto chiara, spiegando cioè che è
meglio che sia lui a parlare, poiché i due sono greci, e potrebbero essere
ostili al parlare di Dante.
–
Quindi Virgilio chiama le due anime, gli chiede di arrestare il loro movimento,
e dopo una articolata captatio benevolentiae chiede a Ulisse di
raccontare come è morto.
Quindi Virgilio chiama le due anime, gli chiede di arrestare il loro movimento,
e dopo una articolata captatio benevolentiae chiede a Ulisse di
raccontare come è morto.
66697275788184 |
«S’ei posson dentro da quelle favilleparlar» diss’io, «maestro, assai ten priegoe ripriego, che il priego vaglia mille,che non mi facci dell’attender niegofin che la fiamma cornuta qua vegna:vedi che del disio ver lei mi piego!»Ed elli a me: «La tua preghiera è degnadi molta loda, e io però l’accetto;ma fa che la tua lingua si sostegna.Lascia parlare a me, ch’i’ ho concettociò che tu vuoi; ch’ei sarebbero schivi,perché fuor greci, forse del tuo detto».Poi che la fiamma fu venuta quividove parve al mio duca tempo e loco,in questa forma lui parlare audivi:«O voi che siete due dentro ad un foco,s’io meritai di voi mentre ch’io vissi,s’io meritai di voi assai o pocoquando nel mondo li alti versi scrissi,non vi movete; ma l’un di voi dicadove per lui perduto a morir gissi». |
schivi: reticenti verso la tua
|
85-111.L’ultimo viaggio di Ulisse. Parla Ulisse, e racconta che dopo
che si fu allontanato da Circe, né l’affetto del figlio, né l’amore per il padre
e per la moglie riuscirono ad impedirgli di seguire il suo ardore di
conoscere il mondo, e l’essere umano.
–
si imbarcò con pochi compagni su una nave, e navigò nel Mediterraneo fino allo
stretto di Gibilterra, dove Ercole pose le sue colonne perché nessuno le
oltrepassasse.
si imbarcò con pochi compagni su una nave, e navigò nel Mediterraneo fino allo
stretto di Gibilterra, dove Ercole pose le sue colonne perché nessuno le
oltrepassasse.
8790939699102105108111 |
Lo maggior corno de la fiamma anticacominciò a crollarsi mormorando,pur come quella cui vento affatica;indi la cima qua e là menando,come fosse la lingua che parlasse,gittò voce di fuori e disse: «Quandomi diparti’ da Circe, che sottrasseme più d’un anno là presso a Gaeta,prima che sì Enëa la nomasse,né dolcezza di figlio, né la pietadel vecchio padre, né ‘l debito amorelo qual dovea Penelopè far lieta,vincer potero dentro a me l’ardorech’i’ ebbi a divenir del mondo espertoe de li vizi umani e del valore;ma misi me per l’alto mare apertosol con un legno e con quella compagnapicciola da la qual non fui diserto.L’un lito e l’altro vidi infin la Spagna,fin nel Morrocco, e l’isola d’i Sardi,e l’altre che quel mare intorno bagna.Io e ‘ compagni eravam vecchi e tardiquando venimmo a quella foce strettadov’ Ercule segnò li suoi riguardiacciò che l’uom più oltre non si metta;da la man destra mi lasciai Sibilia,da l’altra già m’avea lasciata Setta. |
– antica: per la grande distanza
|
Il viaggio. Dante non conosce l’Odissea, e si basa su un brano delle Met. di
Ovidio, il quale racconta che:
–
Quando Enea giunge presso Gaeta incontra Macareo, che era stato tra i compagni
di Ulisse,
Quando Enea giunge presso Gaeta incontra Macareo, che era stato tra i compagni
di Ulisse,
–
Macareo racconta a sua volta che dopo un anno di ?prigionia’ presso Circe, dopo
che i compagni furono ritrasformati in uomini, Ulisse decise di partire per una
nuova avventura (Ovidio non dice quale!), ma lui, Macareo si era
rifiutato, ed era rimasto a Gaeta, poiché erano appunto «vecchi e tardi»;
Macareo racconta a sua volta che dopo un anno di ?prigionia’ presso Circe, dopo
che i compagni furono ritrasformati in uomini, Ulisse decise di partire per una
nuova avventura (Ovidio non dice quale!), ma lui, Macareo si era
rifiutato, ed era rimasto a Gaeta, poiché erano appunto «vecchi e tardi»;
Circe. Il distacco da Circe è allegorico: Boezio, nel De
Consolatione Philosophiae, dice che Circe è allegoria della
sensualità, la quale rende gli uomini bruti; il distacco dal piacere
dei sensi è il primo passo da compiere per giungere alla sapienza.
L’ardore. Ulisse dice che gli affetti familiari non sono riusciti a frenare
l’ardore per la conoscenza. Questo accomuna Ulisse a Dante, il quale (nel
Convivio) afferma che l’amore per la sapienza è prioritario rispetto a
quello per la famiglia stessa (criticato da Petrarca).
112-142. Il naufragio. In questa sezione c’è il breve discorso che Ulisse fa
ai suoi compagni per convincerli a proseguire il viaggio oltre le colonne:
l’argomento centrale di questo sta nel ricordare che è proprio della natura
umana seguire la virtù e la conoscenza.
–
Quindi il viaggio prosegue: oltrepassato lo stretto di Gibilterra, la nave devia
verso sud, fino a raggiungere l’emisfero australe. Una volta giunti vicino alla
montagna del Purgatorio, un turbine si stacca dall’isola e affonda la nave.
Quindi il viaggio prosegue: oltrepassato lo stretto di Gibilterra, la nave devia
verso sud, fino a raggiungere l’emisfero australe. Una volta giunti vicino alla
montagna del Purgatorio, un turbine si stacca dall’isola e affonda la nave.
114117120123126129132135138141 |
“O frati”, dissi, “che per cento miliaperigli siete giunti a l’occidente,a questa tanto picciola vigiliad’i nostri sensi ch’è del rimanentenon vogliate negar l’esperïenza,di retro al sol, del mondo sanza gente.Considerate la vostra semenza:fatti non foste a viver come bruti,ma per seguir virtute e canoscenza”.Li miei compagni fec’ io sì aguti,con questa orazion picciola, al cammino,che a pena poscia li avrei ritenuti;e volta nostra poppa nel mattino,de’ remi facemmo ali al folle volo,sempre acquistando dal lato mancino.Tutte le stelle già de l’altro polovedea la notte, e ‘l nostro tanto basso,che non surgëa fuor del marin suolo.Cinque volte racceso e tante cassolo lume era di sotto da la luna,poi che ‘ntrati eravam ne l’alto passo,quando n’apparve una montagna, brunaper la distanza, e parvemi alta tantoquanto veduta non avëa alcuna.Noi ci allegrammo, e tosto tornò in pianto;ché de la nova terra un turbo nacquee percosse del legno il primo canto.Tre volte il fé girar con tutte l’acque;a la quarta levar la poppa in susoe la prora ire in giù, com’altrui piacque,infin che ‘l mar fu sovra noi richiuso». |
– Cento milia: iperbole >
|
Orazion picciola. Il breve discorso di Ulisse è modellato secondo i canoni
della Retorica antica:
–
apostrofe affettuosa e familiare; > iperbole che funge da
captatio benevolentiae;
apostrofe affettuosa e familiare; > iperbole che funge da
captatio benevolentiae;
– il richiamo all’istituto dell’Ethos: cioè considerare il valore
della dignità umana, per differenziarsi, in antitesi, dai bruti;
L’averroismo. Sotto questo testo è sottesa la conoscenza da parte di Dante
dell’averroismo radicale, e dei rischi che questo comporta per l’anima: poiché
questo pensiero (introdotto da poco in Italia) separa la fede dalla ragione.
–
il purgatorio: ciò che Ulisse vuole raggiungere col folle volo è
la conoscenza del Purgatorio: e l’uomo non può raggiungere questo luogo se non
per grazia divina
il purgatorio: ciò che Ulisse vuole raggiungere col folle volo è
la conoscenza del Purgatorio: e l’uomo non può raggiungere questo luogo se non
per grazia divina





