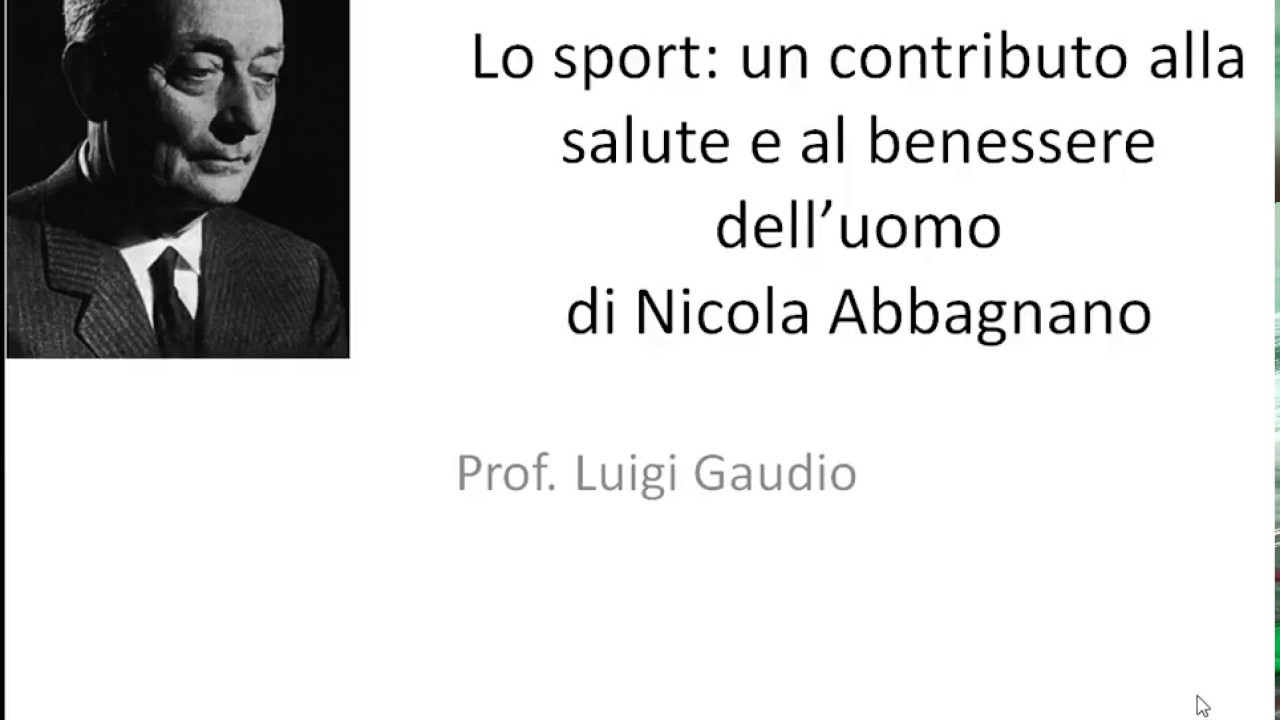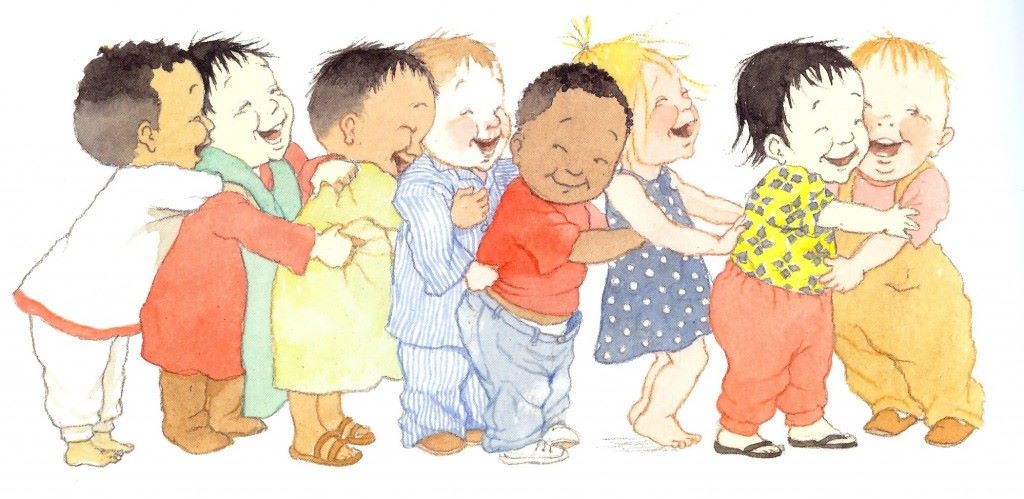Ripasso di introduzione alla Divina Commedia,
27 Gennaio 2019

Collab ORAle
27 Gennaio 2019della prof.ssa Irma Lanucara
Pochi fenomeni sociali hanno una visibilità pari a quella dello sport. Esso sembra costituire un ambito distinto e autonomo della nostra esperienza sociale: esiste una cronaca sportiva che occupa una quota fissa delle pagine dei quotidiani, programmi televisivi sullo sport, perfino emittenti dedicate unicamente alla trasmissione di eventi sportivi. Lo stesso spazio in cui viviamo appare segnato dalla presenza di luoghi nei quali si pratica sport o si assiste ad attività sportive: stadi, palestre, piscine, spazi naturali attrezzati per una qualche forma di esercizio fisico o competizione. Anche la percezione del tempo appare profondamente segnata dalla presenza dello sport: i calendari delle varie attività agonistiche scandiscono il ciclo dei mesi e delle settimane e nuovi riti domenicali, celebrati allo stadio o al palazzetto dello sport, si sovrappongono alle tradizionali pratiche religiose festive.
- DIFFERENZA TRA SPORT ANTICHI E SPORT MODERNI
Lo sport è un fenomeno tipicamente moderno. Le antiche Olimpiadi, ad esempio, non erano manifestazioni sportive autonome, in quanto accompagnavano celebrazioni religiose in onore di Zeus e costituivano quindi il completamento di un altro evento spettacolare. Possiamo riconoscere in queste manifestazioni sportive solo due caratteristiche comuni alle pratiche agonistiche moderne: la competizione e l’utilizzo di abilità fisiche. A tali elementi lo sport moderno ne aggiunge almeno altri due: la presenza di regole precise, ben codificate e l’istituzionalizzazione, cioè l’inserimento delle attività e degli individui in un quadro organizzativo definito, con la presenza di federazioni, enti, ecc..
- LA NASCITA DELLO SPORT MODERNO
E’a partire dal XVII secolo che il fenomeno sportivo inizia ad assumere delle caratteristiche che ancora oggi lo identificano come tale. Il sociologo tedesco N. Elias, insieme a E. Dunning, sostenne che proprio in tale periodo prende forma quel processo di civilizzazione della società occidentale che comporta, tra l’altro, una generale disciplina delle abitudini e dei costumi. Essa si situerebbe, secondo Elias, all’origine della sportivizzazione di attività tradizionalmente appannaggio dell’aristocrazia (duellare, cacciare), trasformate dalle nuove classi borghesi in veri e propri sport”.
Un ulteriore sviluppo di tale processo è segnato, nel XIX secolo, dalla trasformazione dello sport in un vero e proprio strumento pedagogico, utilizzato dalle istituzioni politiche sia per formare la classe dirigente, sia le classi popolari.
- DAL RITUALE AL RECORD
In quanto prodotto della moderna civiltà borghese, nata dalla rivoluzione industriale, lo sport ne assimila in qualche modo gli aspetti e gli stessi valori fondanti. Lo studioso contemporaneo A. Guttman, autore del saggio dal titolo Dal rituale al record (1978), individua sette parole chiave che esemplificano, a suo giudizio, i tratti distintivi della modernità sportiva:
- Secolarizzazione: lo sport moderno nasce emancipandosi dall’antica connotazione religiosa
- Uguaglianza: lo sport abolisce ogni tipo di discriminazione, permettendo l’accesso alle competizioni a soggetti sociali prima esclusi (ad esempio le donne)
- Specializzazione: nella pratica sportiva si afferma il principio generale della divisione del lavoro, presupposto necessario della civiltà industriale. Nasce così una pluralità di mansioni e di competenze distinte, non solo all’interno dell’attività agonistica (sport di squadra), ma anche a contorno di essa (allenatori, fisioterapisti, ecc.)
- Razionalizzazione: lo sport si sottopone sempre più a logiche basate su razionalità ed efficienza, sottomettendosi a regole dettagliate
- Burocratizzazione: nasce una fitta rete di strutture e apparati istituzionali incaricati di gestire i vari aspetti del fenomeno sportivo
- Quantificazione: si introducono strumenti di misurazione esatta, rilevazioni cronometriche
- Ricerca del record: il confronto tra situazioni agonistiche distanti nel tempo e nello spazio modifica radicalmente la natura della competizione (l’atleta gareggia non solo con chi gli è fisicamente vicino, ma anche con persone che non conosce) e i limiti umani vengono costantemente sfidati
- I QUATTRO MODELLI IDEALI DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA
Il sociologo tedesco K. Heinemann ha parlato di quattro tipi ideali di attività sportiva presenti nella società contemporanea:
- Il modello competitivo, erede dello sport tradizionale, di cui conserva regole, sistema di valori, struttura organizzativa
- Il modello espressivo, che include attività poco organizzate, praticate più che altro per ricerca di evasione dalla routine quotidiana (sciare, praticare surf, ecc.)
- Il modello strumentale, associato alle palestre commerciali, che risponde all’esigenza di poter dare al proprio corpo l’aspetto desiderato
- Il modello spettacolare, caratterizzato dalla trasformazione del fenomeno sportivo in puro spettacolo.
- SPORT E MOTIVAZIONE
Perché le persone fanno sport? Porsi un interrogativo del genere significa indagare la motivazione che spinge gli individui alla pratica sportiva. Nell’ambito dello sport possono entrare in gioco sia motivazioni estrinseche, come mantenersi in salute, intrecciare nuovi rapporti o esibire il proprio corpo; sia motivazioni intrinseche, in quanto la pratica sportiva può costituire un’importante fonte di gratificazione o di espressione di sé e della propria personalità e può anche essere uno strumento per mettere alla prova le proprie abilità (a questo proposito la psicologia ha introdotto il concetto di need for competence, ossia bisogno di mettere alla prova le proprie competenze).
- LA FUNZIONE EDUCATIVA DELLO SPORT
In primo luogo, l’esercizio di uno sport richiede il possesso di abilità e competenze che devono essere apprese, quindi insegnate. Ciò ha determinato, all’interno di ogni disciplina sportiva, la nascita di una vera e propria area didattica dotata di autonomia.
Lo sport è in grado di formare non solo un atleta, ma anche un qualsiasi individuo, in modo da renderlo più maturo e completo. Soprattutto in età evolutiva la pratica dello sport viene suggerita come un utile supporto per la strutturazione dell’identità personale.
Lo sport può essere uno strumento importante per conoscere sé e il proprio corpo ed è il presupposto fondamentale di un’adeguata vita di relazione. Inoltre esso può essere importante per educare alle emozioni fondamentali: la situazione agonistica, il confronto con gli altri, lo scontro inevitabile con i propri limiti mettono costantemente l’atleta di fronte a situazioni emotive di questo genere, obbligandolo a trovare una strada per gestirle.
Lo sport, infine, può contribuire a migliorare l’autostima, cioè il giudizio che la persona ha su di sé, sulle sue capacità e sul suo valore. Eseguendo esercizi, imparando nuove abilità, l’individuo può incrementare la sicurezza nei propri mezzi e la convinzione di poter superare difficoltà.
- IL FENOMENO DEL TIFO
Si tratta dell’intenso attaccamento emotivo che, negli sport di squadra, lega lo spettatore a un determinato club o team. Tale fenomeno nell’ambito della sociologia è stato spesso assimilato ai comportamenti collettivi: vengono così chiamati quei fenomeni che si verificano quando un insieme anche numeroso di persone si muove all’unisono, come se fosse un unico soggetto, dando luogo ad azioni spontanee e lontane dalla routine quotidiana.
Audio Lezioni sulla Pedagogia e organizzazione della scuola del prof. Gaudio
Ascolta “Pedagogia e organizzazione della scuola” su Spreaker.