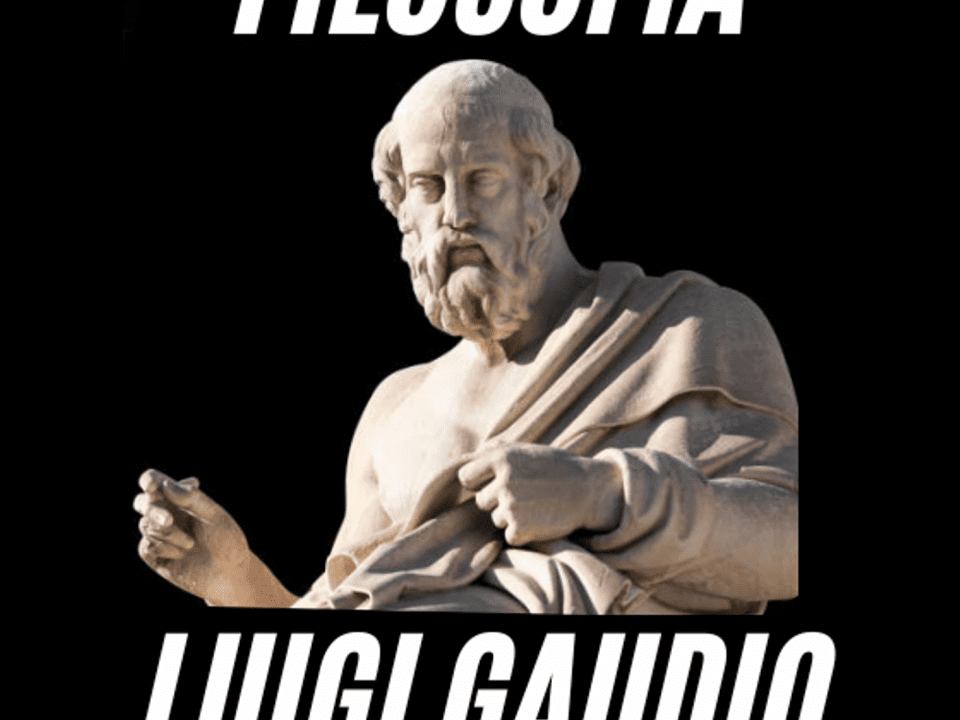Daniela Notarbartolo
27 Gennaio 2019


This is the page
27 Gennaio 2019
da “Racconti e bozzetti” (1880-1922)
Novelle di Giovanni Verga
Il sermone del Paradiso chiudeva il corso degli esercizi spirituali per le monache, dopo la sottile analisi delle colpe recondite, la fosca descrizione del gastigo, e gli anatemi contro il peccato. La voce del predicatore adesso levavasi alta ed esultante nel sole di Pasqua che scintillava sulle dorature della vòlta. Giù in chiesa una dozzina di donnicciuole pregavano inginocchiate dinanzi all’altare della Vergine splendente di ceri. Dietro la grata del coro biancheggiavano confusamente i soggoli e i visi delle suore impalliditi nella clausura e nella penitenza; luccicavano degli occhi perduti nell’estasi di visioni luminose. La voce del missionario, grave e calda, scendeva ai toni bassi come una confidenza e una carezza, saliva trionfante come un inno, modulava i pensieri e le aspirazioni di tutte quelle vergini tentate e sbigottite dal mondo, andava a ricercare le più intime fibre di quei cuori chiusi nelle sacre bende e li faceva palpitare avidamente, aveva tutti gli slanci, le trepidazioni, come dei sospiri d’amore e d’estasi che morivano ai piedi della croce, e facevano intravvedere quasi un balenìo d’ali iridescenti, dei brividi di carni rosse di cherubini che passavano fra nuvole trasparenti, in un’aureola, in ampie distese color di cielo e color d’oro. L’uomo era tutto in quella voce, in quell’inno, in quella letizia: il viso scorgevasi appena, come trasfigurato, nell’ombra del pulpito: degli occhi luminosi, ardenti di fede, pieni di visioni celesti, il viso pallido ed ascetico, immateriale, il segno austero della tonsura sui capelli giovanili, e la mano bianca ed immacolata che accennava, essa sola in luce, fuori della nicchia scura, e pareva stendersi verso le peccatrici, per sollevarle al cielo in un amplesso di perdono e d’affetto, dopo essersi levata minacciosa a fulminare, dopo esser scesa a frugare nei cuori, dopo aver sentito palpitare la tentazione, e i fremiti e le ribellioni della carne. Ora quella mano facevasi lieve, morbida e carezzevole, al pari della voce che addolcivasi in un mormorio affettuoso e in una promessa soave, nella quale passava l’alito di carità, di pietà immensa, e si umiliava, e implorava, e facevasi complice delle povere anime turbate e derelitte, per incoraggiarle, sostenerle e attirarle a Dio.
Egli parlava rivolto al coro, quasi attratto anch’esso dalla simpatia ardente che vi destava, come indovinasse i cuori che rispondevano al suo e gli si aprivano sitibondi. Ivi pure delle teste tonsurate si chinavano, delle labbra tremavano commosse, dei veli candidi palpitavano sui seni incontaminati, sfiorati soltanto dai fremiti che sorgono nelle tenebre, nelle notti irrequiete e paurose.
Il sagrestano s’alzò d’appiè del pulpito e andò ad accendere le altre candele dell’altare – una gloria di fiammelle tremolanti, delle gocce di splendore nella mattinata limpida, nella gaiezza primaverile, nel profumo dei fiori, e dell’incenso, nel suono grave dell’organo che levavasi dalle profondità misteriose del coro – un canto alato, un inno di grazie e di gloria che irrompeva, e libravasi al cielo trionfante. Fra le monache raccolte nel coro una voce bella e fresca intuonò il Tantum ergo, una voce di donna che sembrava cantare la giovinezza, l’amore, il sogno, l’azzurro, i fiori e la vita in quell’inno religioso, una voce che aveva le lagrime, le estasi, i sorrisi, la gioventù, la bellezza, e li deponeva trepidante ai piedi dell’altare. Il frate orava in ginocchio, a capo chino. Sembrava che a quel canto si riverberassero delle sfumature rosee sulla nuca bianca d’adolescenza casta e prolungata. Egli stesso sembrava quasi immateriale fra le pieghe molli della tonaca nera che cadeva sui gradini dell’altare, simile a una veste muliebre. Poi sorse un’irradiazione abbagliante, una gloria di raggi che ecclissò, nell’aureola dell’ostensorio gemmato, l’uomo segnato dalla stola d’oro, come in una croce, sulla cotta spumante di trine al pari di un abito da sposa. Tutte le teste si prostrarono umiliate. Le campane squillarono alte in un coro festante, insieme alle note gravi e sonore dell’organo che vibravano sotto la vòlta dorata della chiesa, irrompevano dalle finestre dipinte, pel cielo azzurro, nella primavera gioconda, sotto il sole radioso, mentre il canto moriva in un’estasi sovrumana.
Suor Crocifissa era rimasta accanto all’organo, colle mani ancora erranti sulla tastiera, le labbra palpitanti dell’inno d’amore mistico, smarrita nella visione interiore di quegli splendori che alla sua anima esaltata dalla musica, dalla reclusione, dal digiuno, dal cilicio e dalla preghiera in comune recavano uno sgomento e una dolcezza nuova della vita, un turbamento degli echi e degli incitamenti che venivano a morire sotto le mura del convento colla canzone errante, coi rumori del vicinato, colla carezza della l’una che entrava dall’alta inferriata a posarsi sul lettuccio verginale, e tentava il mistero pudibondo della cella solitaria, e vi destava le curiosità timide, le fantasie vagabonde, e gli scrupoli vaghi che annidavansi nell’ombra. Ella sentiva ora una bramosia calda, un desiderio quasi carnale di mondarsi l’anima e lo spirito di quelle allucinazioni peccaminose, di difendersi dal mondo, di agguerrirsi contro la tentazione, coll’aiuto di quell’uomo il quale discerneva la via della colpa coi suoi occhi luminosi e insinuavasi nei cuori colla voce soave, e scacciava il peccato colla mano fine e bianca, e parlava dell’amore eterno con accento d’innamorato. – Accostarsi a lui, essere con lui, confondersi in lui. – Avere in quell’uomo purificato dal sacramento il consigliere, il conforto, l’amico, il confidente, il perdono, la verità e la luce.
Una suora la toccò dolcemente sull’omero. Ella si scosse e la seguì vacillante, cogli occhi ardenti di fede, premendo colle mani ceree in croce sul seno il cuore che sbigottiva di passione, chinando il capo umiliato dall’umana miseria nella benda che chiudeva le trecce recise e incorniciava il viso di un’altra bianchezza fredda, sbattuta, stirata d’angoscia, illividita da vigilie tormentose, come la sua povera anima sbigottita, e chiese alla superiora il permesso di confessarsi al predicatore. L’abbadessa acconsentì, alzando la mano a benedire, leggendo forse le stesse inquietudini dolorose che avevano provato la sua giovinezza trascorsa in quelle sopracciglia lunghe e nere, e in quelle labbra dolorose, soltanto vive nel viso mortificato ed austero.
Lì, attraverso la grata del confessionario che aguzzava il mistero e rincorava la coscienza trepida, aprirgli il cuore, tutto, coi suoi palpiti, colle sue angosce, coi suoi pudori. Parlare d’amore con lui, parlargli di colpa e di perdizione, dirgli quello che non avrebbe osato mormorare sottovoce, da sola ai piedi del crocifisso muto. Udire il suono delle proprie parole, colla fronte ardente su quella grata di ferro dietro alla quale lui ascolatava. Intravvedere il riflesso dei propri pensieri, delle proprie allucinazioni, dei propri terrori su quella testa china. Vedere arrossire e impallidire del pari quella fronte pura. Aver lì, sotto il proprio anelito concitato, quel sacerdote, quella coscienza, quell’intelletto, quella carità, quel turbamento, quella simpatia, quell’uomo, trasfigurato dall’abito sacro, legato dal vingolo indissolubile, segnato fra gli eletti dalla tonsura religiosa, agitato al par di lei, sbigottito come lei, palpitante come lei, mentre la sua voce velata giungeva a lei come attraverso la lapide di una tomba, per consigliare, per sorreggere, per consolare, sommessa, confidente, nel mistero, nel segreto delizioso della chiesa deserta. E vederlo trasalire sotto l’angoscia della passione di lei, vederlo arrossire al riverbero della sua vergogna, vedere il soffio infocato della sua parola che implorava aiuto, scendere sino in fondo a quell’uomo, e destare in lui le debolezze istesse perché ne sentisse la miseria e la pietà , e rifiorirgli nei brividi e nei pallori improvvisi della carne. Sentirsi ricercare nel più profondo del cuore e delle viscere da quella voce dolce e insinuante, nel più vivo, nel segreto, dove s’annidiavano e rabbrividivano pensieri, e desideri, e palpiti ch’essa stessa non avrebbe neppur sospettato – la confusione dolce, il rossore trepido, l’abbandono del pudore violentato, – e darsi tutta a lui come in uno smarrimento dei sensi. Scorgere in lui, nel consigliere, nel ministro, nel forte, la simpatia di quelle debolezze, la pietà di quei dolori; sentire nella sua voce commossa l’eco e il fascino trepido delle medesime inquietudini – con una tenerezza trepida per lui, maggiormente esposto al pericolo, votato alla lotta col peccato, solo nel mondo, nella tentazione, senza altra difesa che quell’abito che trasfigurava l’uomo, e il segno irrevocabile della tonsura come un marchio di castità sui capelli castagni – con un desiderio materno di stringersi al petto quel viso impallidito e sbattuto dalle medesime angosce, quel capo tonsurato in cui bollivano le stesse febbri, onde proteggerlo e difenderlo.
Egli ascoltava, raccolto, colla fronte velata dalla mano scarna, gli occhi vaghi e senza sguardo. Passavano dei bagliori di tanto in tanto in quegli occhi pensierosi, dei fantasmi che dileguavano dinanzi alla volontà severa, dei fremiti destati da quell’alito caldo e profumato di donna, dalla parola commossa, l’ombra di tutte le debolezze, di tutte le miserie, di tutti gli allettamenti, le effusioni, le dolcezze, gli struggimenti, le febbri, le estasi. Con lei rifaceva l’aspro cammino che avevano fatto verso la croce quei piedi delicati. Rivedeva la fanciullezza orfana, l’adolescenza precocemente mortificata, la gioventù scolorita e trista, l’agonia dello spirito e le ribellioni della carne. Fuori, il cielo azzurro, l’ampia distesa dei prati, il sole, la luce, l’aria, lontani, perduti in un mondo al quale non apparteneva più, – e la gran rinunzia di tutto ciò, per sempre! – E pensava qual eco dovesse avere fra quelle mura claustrali la voce di un uomo o il pianto di un bambino, il brivido che doveva portarvi il profumo di un fiore o un raggio di primavera. – Le fronti pallide che trasalivano, gli occhi spenti che guardavano lontano, le labbra che mormoravano inconsciamente accenti desolati. E sentiva una grande pietà , una gran tenerezza per quelle povere anime che tendevano al cielo strette ancora fra i legami della terra, per quei gemiti d’agonia che si tradivano nella parola esitante e supplichevole, per quelle mani tremanti che si stendevano verso di lui, che cercavano di aggrapparsi alla vita, al perdono, alla fede, alla costanza, e che doveva lasciarsi cadere ai piedi, insensibile e inesorabile, che doveva abbandonare dietro di sé continuando sulla terra il suo pellegrinaggio d’apostolato, e scuotendo i lembi della sua tonaca perché non si contaminasse a quella seduzione, – anch’esso solitario, legato soltanto dalla disciplina dell’ordine alla fredda famiglia religiosa, senza genitori, senza casa, senza patria, passando sulla terra cogli occhi rivolti al cielo, fallendo se inciampava, se le spine del cammino gli insanguinavano le carni, o le voci del mondo penetravano nelle sue orecchie, se la vita batteva nelle sue arterie o tumultuava nel suo cuore, se la tentazione di quell’incognita, il ricordo di quella sconosciuta che si era data a lui in ispirito, in un momento di mistico abbandono, veniva a turbare la sua fantasia o a fargli tremare la preghiera sulle labbra.
Un campanello squillò. Il prete cinse la stola fulgida che lo sollevava dalla terra, e si accinse a comunicarla. Ella genuflessa dinanzi allo sportellino aperto della grata annichilivasi nella contemplazione degli splendori celesti che apriva la sfera d’oro. Un languore soave, una calma infinita, una dolcezza ineffabile per tutto l’essere: la battaglia vinta, il cuore librantesi nella fede, il conforto, la forza, l’ardore di quell’ostia consacrata che scendeva nel suo petto e si confondeva col suo sangue – l’ostia che le posava lui stesso sulle labbra trepide, colle mani trepide, mormorando soavemente le parole sacramentali, chinando gli occhi, dolci, come velati da una visione interiore nelle occhiaie profonde e misteriose, sul viso sbattuto ed emaciato anch’esso. – Egli la vide quel momento solo, in quell’abbandono, in quella bramosia arcana, in quell’estasi, colle pupille smarrite, il viso trasfigurato, in un’irradiazione candida di veli, sporgendo le labbra avide e innamorate.
Essa chinò il capo, nell’atto di ringraziamento, in un torpore e in uno sfinimento delizioso di tutta se stessa. La chiesa tornò vuota e silenziosa come una tomba.
Il missionario era andato via per sempre, continuando il suo viaggio di carità, lasciando a lei la benedizione di quella pace e di quella fede. Essa lo accompagnava col pensiero per strade e per paesi sconosciuti; vedeva ancora quegli occhi dolci, quel viso emaciato, quella tonaca fluttuante dietro la sua persona esile, in altre chiese risonanti della sua parola, dinanzi ad altre monache palpitanti; lo seguiva nei rumori che giungevano dalla via, nelle notti stellate, nel cielo che stendevasi al di là delle inferriate claustrali. Era un grande sconforto, un isolamento più tristo, come un abbandono. Poi, quando la sua coscienza inquieta cominciò a ridestarsi, pregò una delle sorelle anziane che aveva sofferto e dubitato come lei d’intercedere presso l’antico confessore, il quale si rifiutava a confessarla geloso che essa gli avesse preferito una volta il predicatore di passaggio. Era un vecchio incanutito nel confessionario, con dei grandi occhi chiari e penetranti, abituati a guardare nelle tenebre dei cuori, e il pallore delle lunghe confidenze e delle attese pazienti sulle guance incavate.
– No. Io non servo di ripiego… M’ha messo da banda una volta; si cerchi un altro confessore…
– Ma essa aveva sempre la speranza…
– Speranza si chiama vossignoria. Essa chiamasi suor Crocifissa -.