



Scuole tra bombe, allagamenti ed incendi
27 Gennaio 2019

Essere cristiani in Cina
27 Gennaio 2019Arrivano i Vichinghi o Normanni terza parte de L’angolo dei tesori – Una proposta multimediale” per rivedere insieme il percorso della Storia europea: L’Alto Medioevo di Cristina Rocchetto
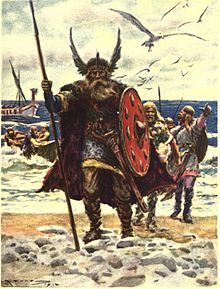
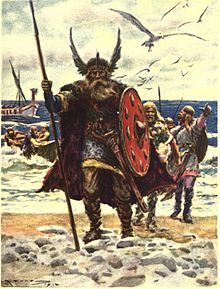
La volta scorsa ho indicato il link di una interessante ricostruzione storica della figura di Carlo Magno, il fondatore del Sacro Romano Impero carolingio, alleato della Chiesa di Roma e comprendente gran parte dell’Europa continentale Nord-occidentale, ma durato pochissimo e dissoltosi nel giro di pochissime generazioni tra lotte per la successione, divisioni del territorio, discendenti incapaci e, soprattutto, travolto dalle tendenze all’autonomia del potere progressivamente maggiore dei nobili, i grandi feudatari di Carlo teoricamente vassalli della corona. Per poter amministrare il vasto territorio del suo Impero privo di una burocrazia centralizzata – che, fortissima, esisteva invece alla corte romana d’Oriente di Bisanzio/Costantinopoli (vedere numero 1. di questa rubrica, nell’archivio, alla data 18 novembre) – infatti, Carlo Magno lo aveva diviso in contee” (territori interni) e marche” (territori ai confini dell’Impero), affidandone la gestione a suoi fiduciari, vassalli che a loro volta suddividevano la loro parte in feudi più piccoli assegnandoli a valvassori, che si appoggiavano eventualmente a valvassini: erano state gettate le basi del sistema feudale. Nell’idea originaria il feudo era stato concepito come un vitalizio” dato ad un valoroso collaboratore in usufrutto per la sola durata della sua vita; ormai però i feudatari non solo non erano disposti ad accettare l’autorità centrale nel loro territorio, ma tendevano a pensare a quello come ad una loro proprietà personale trasmettibile alla propria discendenza. Inoltre, sin dai tempi dei Merovingi (la discendenza di Clodoveo, primo re dei Franchi (vedere numero 2. di questa rubrica, nell’archivio, alla data del 25 novembre) il Regno dei Franchi era culturalmente diviso in due territori principali divisi dalla linea di demarcazione del Reno, che segnava il confine dell’Impero della grande Roma:
- Ad Oriente dei territori da cui i Franchi si erano mossi inizialmente si trovava il vasto territorio dell’Austrasia (Regno dell’Est”= Oester Reich” in Tedesco), mai romanizzato, dove l’elemento germanico di lingua e cultura era chiaramente più forte; qui la gente parlava una lingua appartenente al tipo dell’alto-Tedesco; a questa parte furono in seguito annessi quelle regioni conquistate da Carlo Magno: per esempio, la Sassonia, della guerra contro la quale, dei massacri e della forzata cristianizzazione ha parlato anche il filmato di Piero ed Alberto Angela da me indicato la volta scorsa. E questa la parte che, come vedremo sotto, diventerà dopo i Carolingi l’Impero Germanico, e lo diventerà proprio sotto una dinastia di Sassonia, gli Ottoni;
- ad Occidente si trovava il territorio della Neustria (Nuovo Regno”= Neuer Reich” in Tedesco), che si trovava ad occidente di Parigi e che era incluso nella Gallia romana. Queste terre, conquistate a Roma da Cesare, avevano subito una fortissima romanizzazione; i Franchi, espandendosi da Nord (territori dell’attuale Belgio ed Olanda), avevano mescolato la loro lingua materna, il Francone (una lingua germanica appartenente al tipo del basso-Tedesco, come quella oggi parlata in Olanda), al Latino locale generando, dopo una fase intermedia di pieno bilinguismo, una lingua, il Franciano (o Francese medievale”), diretto antenato del Francese moderno. Questa parte dell’Impero carolingio ad un certo punto si staccherà dal resto di ciò che era stato l’Impero carolingio e che non era più, coagulandosi attorno ad una dinastia (i Capetingi, nome derivato dal loro capostipite, Ugo Capeto, che nel 987 avvierà il processo di riunificazione territoriale), che dal territorio di Parigi cercherà di ricostituirla in un unico Regno nazionale lottando contro il potere disgregante dei feudatari locali, come vedremo prossimamente.
Alla morte di Carlo Magno, l’Impero era passato al suo solo erede, il figlio Ludovico il Pio: questo caso aveva evitato lotte di successione che esprimevano il contrasto tra l’esigenza di mantenere unificato il vasto territorio imperiale escludendo dalla successione tutti i figli meno il maggiore (maggiorascato”) e la tradizione germanica che invece riconosceva a tutti i figli maschi un uguale diritto di eredità territoriale. Se il problema non si era posto per Ludovico il Pio, rimasto figlio unico, alla sua morte fu sollevato dalla presenza di ben tre figli maschi nella sua famiglia; Ludovico aveva però infine scelto come unico erede del territorio e della corona imperiale il figlio maggiore, Lotario, rispondendo appunto alle esigenze di Stato”. I due fratelli si erano coalizzati ed avevano dichiarato guerra a Lotario: la loro alleanza, trascritta su un documento passato alla storia come Giuramento di Strasburgo” (842 d.C), rappresenta il primo testo scritto che attesta l’esistenza di due lingue medievali distinte all’interno dell’Impero franco: come detto sopra, il Franciano per la parte occidentale ed il Teodisco per quella germanica. I tre nipoti di Carlo Magno vennero l’anno dopo ad un accordo, ed il Trattato di Verdun (843) stabiliva la spartizione dell’Impero carolingio in tre porzioni:
- a) Carlo il Calvo prese la parte più a Ovest, la gran parte di quella Neustria dove si parlerà il Francese medievale, o Franciano, e che, con seguenti annessioni, diverrà successivamente e sotto una nuova dinastia il Regno di Francia autonomo dal territorio imperiale. E proprio Carlo il Calvo a fare una prima grande concessione ai suoi più grandi feudatari/vassalli (877): a riconoscere loro, cioè, il diritto di trasmettere per via ereditaria la proprietà ormai divenuta personale del loro feudo – quella porzione di territorio, cioè, che il nonno Carlo Magno aveva dato ai suoi fedelissimi solo in usufrutto perché l’amministrassero, continuando a considerarla però cosa sua affidata solo in gestione ad altri;
- b) Ludovico il Germanico la parte più a Est, quella che inglobava territori di lingua prettamente teodisca”;
- c) il fratello Lotario, contro il quale i due fratelli minori si erano coalizzati per non essere esclusi dall’eredità dei territori, si teneva il titolo imperiale ed una parte di territorio molto ricco che comprendeva la Lotaringia, (Paesi Bassi, Fiandre, Lorena, Alsazia e tutta la fascia ricca e fertile della Valle del Reno) ed il Nord Italia – strappato dal nonno ai Longobardi e da allora inglobato nel territorio imperiale fino alla Toscana, confinante direttamente con lo Stato pontificio.
Durante il travagliato periodo immediatamente successivo di cui sarebbe dispersivo riferire i dettagli, l’Impero carolingio si trova diviso prima in cinque grandi Regni indipendenti (tra cui un Regno d’Italia che comprende l’Italia settentrionale); poi di nuovo riunito sotto un’unica corona carolingia (di Carlo il Grosso); infine ridiviso in tre parti dalla sua deposizione (887): approssimativamente una parte francese, una italiana e l’altra tedesca, esposte però a diversi pericoli: le nuove ed ultime invasioni (degli Ungari, dei Vichinghi, mentre continua la spinta degli Arabi), che premono i confini dell’Impero carolingio da diverse parti e che rafforzano il potere dei signori locali (i feudatari) a scapito di quello dei re locali. Si assiste al fenomeno dell’incastellamento, ed i castelli, prima di legno, vengono piano costruiti in pietra.
Io oggi vorrei così introdurre l’argomento delle invasioni del IX secolo in maniera da collegarle alle dirette ed importantissime conseguenze che ebbero per la storia europea, guardandole perciò in prospettiva. Cominciamo dunque dai Vichinghi (avremo poi gli Arabi e gli Ungari – o Magiari), chiamati anche Normanni” (uomini del Nord”), perché è dai territori della Danimarca e della Scandinavia che provengono. Popolazioni nordiche di origine germanica, i Vichinghi si spingeranno in ogni dove risalendo con agili barche anche la corrente dei fiumi; fondamentali per l’Europa occidentale medievale furono soprattutto quelli che finiranno per stabilirsi in Normandia, terra della Francia del Nord che da loro appunto prese il nome: da lì, essi partirono in seguito, ma ormai come valorosi cavalieri, alla conquista dell’Inghilterra anglosassone, del Meridione d’Italia bizantino e della Sicilia araba, come vedremo. Sui Vichinghi, tra i tanti, potrei suggerire a chi si senta affascinato da questo argomento per esempio la visione dei cinque spezzoni in cui è diviso il documentario ad essi dedicato, al link https://www.youtube.com/watch?v=dlAiIXmezso&feature=related, che dà informazioni generali sulla loro cultura e la loro superiorità in battaglia.
Nel documentario indicato, però, non si fa molto presente il fatto che i Vichinghi in realtà fossero divisi in tre rami principali e che ripartirono alla volta del Continente europeo da punti geografici differenti: coloro che si erano stabiliti lungo le coste della Norvegia (che, mitigate dalla Corrente del Golfo che dal Messico attraversa l’Atlantico, non ghiacciano mai), prendendo il mare si spinsero verso Ovest giungendo in Scozia, in Irlanda, in Islanda e, da lì, addirittura in Groenlandia e nell’America del Nord (il Canada o Vinland); coloro che occuparono la Svezia, i Vareghi, chiamati da altre fonti Rhos o Rus, si spinsero verso il Bassopiano sarmatico (territori dell’odierna Russia) e, utilizzando le grandi vie d’acqua a scorrimento veloce” (=idrovie, i fiumi), arrivarono fino ai confini dell’Impero bizantino, navigando il fiume Dnepr (che, con i suoi 2.290 km di corso, attraversa i territori delle attuali Russia occidentale, Bielorussia e Ucraina, di cui bagna la capitale, Kiev, per sfociare poi nel Mar Nero); nel Mar dAzov, navigando il fiume Don (di 1950 Km); e nel Mar Caspio, navigando, sempre quando la stagione lo permetteva ovviamente, il Volga (con i suoi 3.530 km, il più lungo fiume in territorio europeo); ed infine coloro che, dalla penisola dello Jutland (la Danimarca), presero di mira sia l’Inghilterra anglo-sassone che, soprattutto, l’Impero carolingio. Furono costoro che, guidati dal loro capo Rollone, ricevettero nel 912 come feudo la Normandia appunto da un discendente di Carlo Magno, Carlo il Semplice, cristianizzandosi e diventando in breve valorosissimi cavalieri difensori di questa religione. Di loro avremo occasione di parlare in particolare prossimamente.
Cristina Rocchetto (educatrice e consulente pedagogista)
torna all’indice de L’angolo dei tesori – Una proposta multimediale” per rivedere insieme il percorso della Storia europea: L’Alto Medioevo – di Cristina Rocchetto
E-book
- Appartenenze straniere di Cristina Rocchetto




