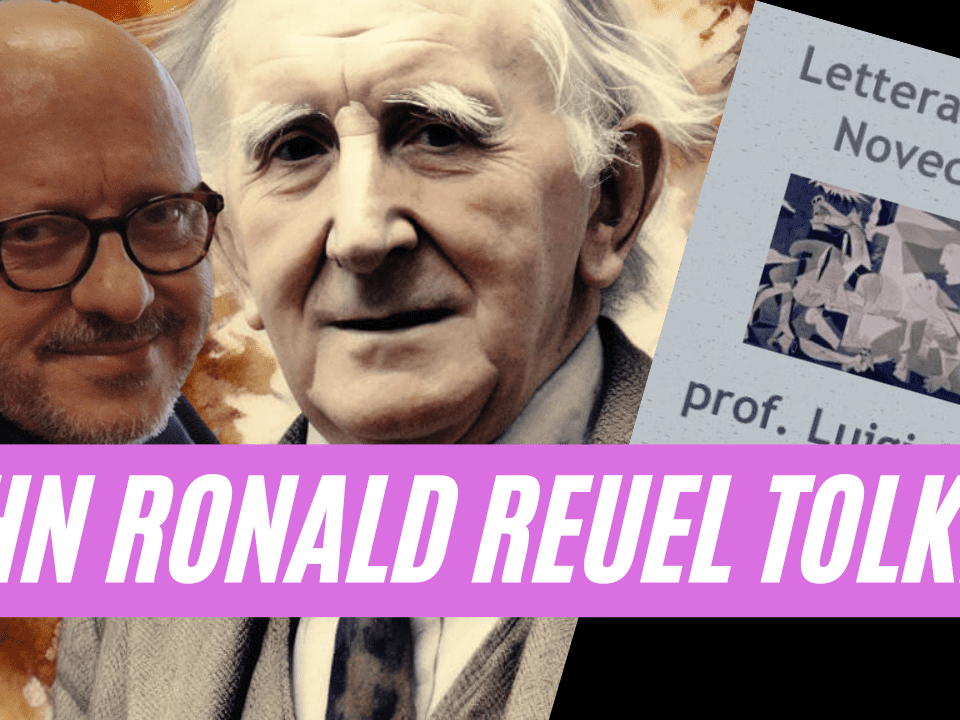Riccardo Bacchelli: il Manzoni del Novecento
27 Gennaio 2019

1984
27 Gennaio 2019Scheda del libro Il taglio del bosco di Carlo Cassola
Lo stile
Periodi brevi (es. “durante la partita si sottolinearono le giocate con le espressioni d’uso” pag.63)
Prosa realistica – Funzione informativa prevalente: Funzione emotiva (es.”Eh, ne aveva fatta di strada dal tempo in cui era un semplice taglialegna! ” pag.87)
– Registro informale prevalente ) – Registro medio presente nei discorsi dei taglialegna (es. “Figuriamoci, per sette punti, possiamo riacchiapparli.”) – Linguaggio prevalentemente semplice, sono però presenti espressioni in disuso (es. “peritavano” pag.48, “avventure occorse” pag.53, “il desinare era finito” pag.26, “chiedere ragguagli” pag.30), espressioni popolari (es. “carne rigata”, “roncolo”, “un tiro di schioppo”), espressioni specifiche dei taglialegna (es. “pennato”, “barroccio”, “tagliata”, “forteto”, “qualità forte, debole”, “taldame da miniera”, “sterzare il terreno”). E’ presente anche una parola onomatopeica (“plaf!” pag.85), e una metafora (“canovaccio” ad indicare lo schema sommario della situazione).
2) – Gli eventi sono narrati in ordine cronologico, ma con qualche sfasatura ogni tanto, in quanto sono presenti:
Anticipazioni: nelle pag.19-20 l’Autore dà per scontato che il lettore sia a conoscenza dei fatti precedenti e lo sottolinea parlando con naturalezza della “solita squadra” e della ” disgrazia” pag.21
Flash-back: “Mio padre mi aveva portato alla fiera del Sasso. Dopo la fiera desinammo…” pag.60, “Stava assistendo il carbonaio che finiva di cuocere le rimanenze della stagione…” pag.64, “Egli tornava dal taglio il sabato sera…” pag.90, “A Cividale, nel 1919, dovevano lavarsi all’aperto… pag.69) 3) Il racconto e’ diviso in due macrosequenze: – preparativi per il taglio – il taglio del bosco Si narra la storia di Guglielmo, un taglialegna di 38 anni, vedovo con due figlie, che organizza il taglio di un bosco in una zona lontana da casa sua. Così riempie le sue giornate lavorando per non sentire la solitudine e la mancanza della moglie.
Organizza una squadra di taglialegna all’interno della quale non trova il dialogo e il calore umano di cui aveva bisogno. I giorni passano e tutto va bene fino quando le condizioni meteorologiche cambiano e non si può proseguire il lavoro. Guglielmo si sente sempre più solo e rimpiange di aver trascurato le figlie. Finalmente arriva la primavera, il carbonaio trasforma la legna tagliata in carbonella, i compagni di Guglielmo tornano a casa perché il lavoro e’ finito. Nel bosco rimangono solo Guglielmo e il carbonaio che nella loro solitudine riescono a parlarsi. Guglielmo si accorge così’ che la sua vita è più felice di quella del carbonaio, non solo perché ha delle figlie, ma anche perché vive all’aria aperta, di giorno, in compagnia dei suoi compagni, al contrario del carbonaio, che vive in solitudine.
Guglielmo torna a casa, passa per il cimitero e, ancora una volta, soffre per la sua situazione senza speranza.
4) – Sequenze narrative, prevalgono nettamente e ne sono presenti molti esempi (es. “La donna sparì dietro la tenda che era in fondo alla stanza …” pag.22) – Sequenze descrittive, riguardano perlopiù i protagonisti ed i luoghi in cui si muovono (es. Era un uomo dall’apparente età di 37 o 36 anni. Indossava una giacca col bavero di pelliccia consunto per l’uso, e teneva il cappello ” pag.19, “Egualmente sobrio era il mobilio: una panca appoggiata al muro, due tavoli accostati, (pag. 20)
Sequenze riflessive: l Autore dà il proprio parere sui personaggi e Guglielmo ripensa alla disgrazia della moglie.
5) Motivi presenti nelle macrosequenze: – Solitudine – Tristezza – Nostalgia – Ricerca di distrazioni (lavoro) – Disperazione – Dolore – Sofferenza – Morte — Amore per la moglie – Rispetto per la natura – Amicizia – Incomunicabilità
6) Nella vicenda si assiste ad un netto peggioramento. All’inizio sembra che le cose si stiano mettendo bene: il protagonista ha trovato un lavoro che lo dovrebbe distrarre dalla sofferenza per la morte della moglie. Andando avanti però si accorge che l’impegno per un lavoro, sia pure impegnativo, non può certo sostituire l’affetto per una persona cara. Nelle ultime frasi il protagonista è addirittura disperato, in quanto si sente completamente solo di fronte alla realtà.
7) Caratterizzazione psicologica: –
Preciso (es. “… aveva l’abitudine di segnare ogni minima spesa …”)
Amante della natura
Distaccato nei confronti della famiglia
Saggio: non gioca a carte pel principio, molta gente è stata rovinata .dal gioco
Si adegua senza convinzione alle idee degli altri (es. sul problema dell’aldilà – Caratterizzazione sociale: vive in un ambiente molto semplice, in mezzo a gente come lui, che per necessità, lavora per distrazione. Non ha problemi economici, perché non deve affrontare spese impegnative, comunque non si cura mollo del denaro: contratta il bosco senza conoscere i prezzi di mercato.
– Caratterizzazione culturale: non sembra che Guglielmo abbia studiato molto;
e’ infatti un semplice taglialegna, ma si impegna nel suo lavoro.
Di fronte a problemi come quello. dell’al di là non sa come rispondere. – Caratterizzazione ideologica: non specificata.
Rapporto con l’Autore: I Autore si rispecchia nel carattere del protagonista, col quale condivide alcune esperienze, come la vita nel bosco . In gioventù Cassola, partigiano, dovette rifugiarsi in un bosco.
8) – Tempo della storia: 1938 – 1939 (nel testo si parla della fine della guerra civile spagnola)
Arco di tempo della narrazione: dal novembre del ’38 al marzo del ’39
Tempo della scrittura: 1948 – 1949 –
Ellissi: (es. “Impiegarono due giorni a costruire il capanno ” pag.43; “Dopo due giorni di inattività .” pag.77; “Nei giorni seguenti piovve ancora …” pag.96; “Rimase tutta la notte ad aiutare il carbonaio …” pag.102; “Alle nove di sera Francesco teneva ancora banco con i suoi racconti.” pag.93) 9)
Spazi aperti: prevalgono, perché la vicenda e’ ambientata in un bosco. Influiscono sull’umore del protagonista (es. Il fulgore del sole, gli odori della campagna, il contusa rumore che era nell’aria, tutto contribuiva a metterlo in un piacevole stato d’animo ” pag.27)
Spazi chiusi: sono di meno, ma sono pure presenti (es. il capanno)
10) – Narratore esterno – Focalizzazione interna – Discorso indiretto — Discorso diretto, prevalente nella seconda parte – Monologo interiore e Flusso di coscienza
(es. “Sono all’oscuro dei prezzi, ma che fa? Può andarmi male, come può andarmi bene … Perdio Se restavo altri quindici giorni senza far niente, finivo al manicomio ? ” pag.28,
“Perché penso a tutte queste cose? Che mi importa guadagnare mille lire o meno? Ah, vorrei tornare ad essere un semplice taglialegna, ma che lei fosse ancora viva!” (pag.87) “Se Dio vuole domani sera dormirò nel capanno” pag.31; “Per fortuna, fu una bella trovata davvero, se tre mesi dopo è morta.” pag.50; “Che paese sarà? Da -che parte rimarrà il nostro paese? ” pag.72; “reggesse un’altra settimana ” pag.79) – Soliloquio: (es.”…ci sono persone a cui non tocca un giorno di felicità nella vita” pag.90)
11) Cassola nacque nel ’17 a Roma, dove trascorse l’infanzia, la adolescenza e la prima giovinezza. La sua infanzia fu abbastanza isolata e caratterizzata dalla presenza dei libri, che gli stimolarono il desiderio di imparare a leggere.
Passava le sue vacanze a Volterra, in campagna; la meta preferita da lui e da suo padre era il bosco Montenero. Da ciò nacque in lui un grande amore per i boschi. Nell’estate del ’35, terminata la maturità gli venne l’ispirazione di scrivere. Verso la fine della guerra Cassola partecipò alla Resistenza ed ebbe quindi contatti con boscaioli in ricordo dei quali scrisse “Il taglio del bosco”.
Cassola visse lavorando come insegnante e come giornalista.
L’Autore afferma di non appartenere ad alcuna corrente letteraria;
scrive solo perché l’immaginazione e’ il solo mezzo per comunicare con gli altri. Tra gli altri romanzi scrisse “La ragazza di Bube” e “Fausto e Anna”.